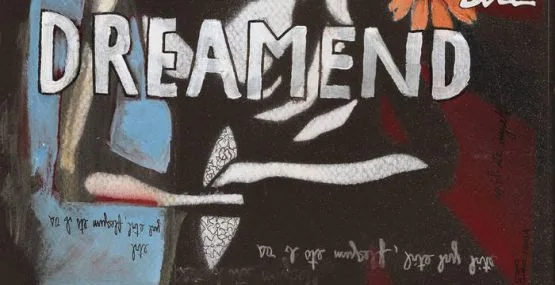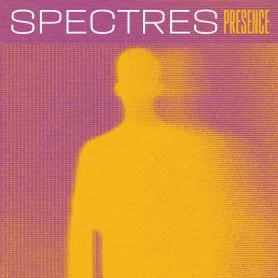Tutto quello che può essere pensato a priori è sbagliato a priori. Almeno in questo caso.
Seabear è un progetto che ha radici nella sola mente di Sindri Már Sigfàºsson, musicista indie-folk nordico. Gli stessi presupposti dei Fanfarlo (o di un sano Jens Lekman. A proposito, ma che fine ha fatto?), ma assolutamente sonorità non accostabili a questi ultimi. Base a Reykjavik, ma non suona proprio alla Sigùr Ros (esatto, non tutti i gruppi che usano gli archi assomigliano ai Sigùr). I suoi brani sono comparsi in promo della BBC e puntate di Gossip Girl, ma non è ne mainstream ne soffritto melodico per ragazzine. Nell’ultimo album hanno partecipato alle composizioni i musicisti che lo hanno circondato nei lavori precedenti, ma questo non ha nessuna analogia con “In A Safe Place” di Jimmy LaValle (Album Leaf). Ma allora di che cazzo sa la loro/sua musica?
Di Indie-folk. Ma fatto bene. Ispirato e intelligente. E lo sperimentale sta nel fatto che è interessante.
Questo ragazzo ha la mente di un onesto Zack Rogue (Rogue Wave). E se non sapessi che tutto il pacchetto viene dall’Islanda, direi che queste note sono state buttate giù, arrangiate e registrate nel nord della California o giù di lì.
Partiamo dai presupposti: “The Ghost That Carried Uu Away”, ovvero: 12 brani che ricalcano strade cantautoriali revival e suadenti passaggi fatti di riverberi leggeri come il primo soffio di vento caldo in primavera, e felici samples rubati alle ou revoir simone mentre dormivano abbracciate a Devendra Banhart (e mettiamo anche un alone amarostico alla Joni Mitchell). Però attenzione. Io non ho visto furto, ammiccamento, imitazione. Qui vedo un filone che procede di pari passo con la scena globale, se non, sinceramente e azzardatamente, un passo avanti, per il grande intuito.
Ma adesso sono di più: da una one-man band sono diventati un sestetto. E a tal proposito Sindri, che a quanto pare la sa lunga, dice che è stato tutto piuttosto naturale. Lui scrive le canzoni e gli altri ci hanno arrangiato sopra. Ma forse è consapevole che la sua impronta è incancellabile da qualsiasi linea strumentale aggiunta. Ed effettivamente si arriva a constatare che ad arrangiare è tanto bravo che si pensa che abbia succhiato il cervello di una ventina di musicisti americani prima di mettersi a scrivere note.
Il ragazzo ha altri side-projects, tra cui uno dovrebbe essere la rielaborazione islandica (si ho scritto islandica) di Simon & Garfunkel (Sindron & Robfunkel); la cosa non mi stupisce affatto. Questo esperimento di importazione/rielaborazione funziona nelle mani di questo tipetto (figo, ad essere onesti, anche se i fighi mi stanno sui maroni se hanno dai 20 ai 30) con idee lungimiranti espresse in modo sornione nelle interviste.
Ma adesso passiamo al lavoro nuovo di zecca, “We Built a Fire”.
Inizio informale, con voce traslucida che si appoggia sul giro di accordi già spedito. “Lion Face Boy” ha un motivetto accattivante da scampagnata.
Neanche il tempo di gradirla a fondo e siamo già alla seconda traccia. Partenza degna dei Mercury Rev, “Fire Dies Down” accelera e frena a tavolino alzando i toni di quella che è una ballata che sa il fatto suo e niente più. Sostenutissima “I’ll Build You A Fire”, procede convinta forte di una ritmica pretestualmente accomodante l’arpeggio trasversale di chitarra che sembra un campionamento (qui è più evidente la presenza di una sovrastruttura musicale).
“Cold Summer” è un velo maestoso e oscuro che si posa sulle considerazioni che si traggono a posteriori. Un protendersi monolitico fa di questo pezzo uno dei migliori della tracklist, e forse il più rappresentativo. Attaccata, quasi accostata, “Wooden Teeth” è country intenzionale con cori innestati per rigirare il tutto a musica popolare. Con “Leafmask” capisco che le radici concettuali di tutto ciò possono essere localizzate tra Bob Dylan e un mood alla Tim Buckley.
“Softship” non so se è un felice tributo agli Yo La Tengo o una strizzatina d’occhio con verve a quello che si può fare quando sei un gruppo indie e conosci abbastanza accordi da fare revival. In entrambi i casi, riuscitissima.
“We Fell Off The Roof” è intima, stile ricordandoilpassatosuunpontile, ma con speranza. Con la speranza che ritorni.
Su “Warm Blood” più che spendere le parole inviterei al solo ascolto. Il ponte costruito tra quello che è stato e il presente non sembra artificiale; melodia degna di un prog impegnato ’70, che si trascina sulla malinconia più che su una struttura non convenzionale. Rintocchi di arco rendono l’epica tragicità .
Verso la fine si va sullo sperimentalismo sopra le righe, perchè sotto ci sono decisamente i Pink Floyd. E gli ipertesti tra loro e gli Arcade Fire che ho letto qua e la qui mi sembrano più plausibili arrivati a questo punto.
Entra “Wolfboy” nel finale che si staglia sobrio con una chanson avvincente nei modi e nel protrarsi dell’atteggiamento, più che esplicativo, delle corde.
Il disco non scende mai di tono, pur cambiando registro. E questa è una gran cosa.
Questo disco è bello davvero. O veramente bello. O bellissimo. Sì, non rivoluzionario, ma bellissimo.