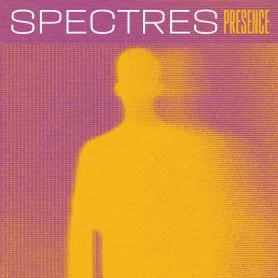Sarebbe un’impresa titanica riuscire a capire in che modo possa essere concepito un disco del genere. A metà strada tra drone, elettronica dark e ambient, questo “Tryptich” (che è davvero un trittico, di dischi) è un’irregolarità continua: irregolarità nei titoli, visibilmente separati da quello che potrebbe essere il significato (o qualsiasi cosa ad esso connessa) delle canzoni, irregolarità negli arrangiamenti, che difficilmente potremo definire tali viste sia la loro complessità che la loro inestricabile trama delirante, ed irregolarità in tutto l’aspetto contenutistico puramente musicale. E’ chiaro che dietro un lavoro così ostico da tradurre in una descrizione nitida, o quantomeno funzionante, ci dev’essere qualcuno di geniale. E se lo volete sapere, questa cosa è vera: dietro Demdike Stare si nascondono Sean Canty e Miles Whittaker, e le loro stupefacenti dimostrazioni di abilità compositiva e d’innovazione che abbiamo potuto inghiottire avidamente in “Symbiosis” solo due anni fa, tornano in toto in un progetto quanto mai ambizioso e stravagante.
Campionamenti bio-techno che non portano da nessuna parte, e che solo dopo l’ascolto dei singoli dischi, prima, e del tutto, poi, si lasciano comprendere, per creare una specie di universo dance che non si può ballare, ma solo ascoltare in distanza. La prima impressione è che una discoteca abbia aperto le finestre e il vento porti il suono con un’eco distorto a venti chilometri di distanza (“Regolith”), prima che tutto questo venga campionato e spalmato su ventitrè tracce diverse, profondamente diverse, ma tutte con un’anima molto simile, che fa capo a certi esperimenti drone d’impronta smaccatamente dark che, nonostante siano imparagonabili, possiamo citare solo per far contenti i clichè del mondo della critica musicale (il progetto Shackleton, nei momenti meno danzerecci, che non sono poi molti, e, forse, anche il dark ambient post-gotico dei Nox Arcana, vedasi “Repository of Light”).
C’è spazio perfino per le influenze orientali, più o meno indianeggianti, di “Hashshashin Chant”, e per le distese di (delirio)pad come in “Forest of Evil” e nei sotterranei da colonna sonora di “Desert Ascetic”. Sono molto frequenti i riferimenti a tematiche naturalistiche, d’ambientazione o atmosferiche, nei titoli, suggestive vampate immaginifiche che l’ascoltatore può (o non può) cogliere, ma che senz’altro lasciano il segno. “Viento de Levante”, il deserto, la pioggia, il cielo, la sabbia, la foresta, e chissà cos’altro vogliono che ci immaginiamo!
In sintesi, tra impennate, rallentamenti, groove segnati da scontri improvvisi con il niente che li rallentano fino ad estinguerli, quasi un’odissea nel mondo di una macromolecola che si sposta all’interno di un raggio laser (“Rain & Shame”, con quel sound spettral-spaziale), prima lentamente poi sparata all’ennesima potenza ma vista comunque con una lente d’ingrandimento talmente potente da fermare anche il tempo. Sensazioni che sono ascoltando il disco ad altissimo volume possono essere comprese appieno. In sostanza un lavoro di ingegneria digitale, l’ambient come è stata concepita e come pochi ancora fanno, tra le giuste atmosfere dark e quelle che sono solamente oniriche e che non vi aiuteranno a risvegliarvi, con una dose letale di tensione che in momenti come la seconda tranche di “Eurydice” possono produrre disturbi visivi ed acustici. Ovviamente, per scherzo.
Per pazzi, e per persone soggetti alla (auto)musicoterapia.