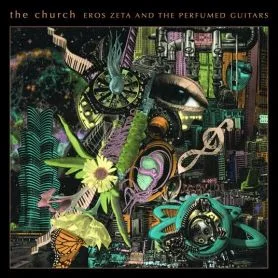Se non se ne conosce il finale, una fiaba è ancora una fiaba? Se d’improvviso tutte le tonalità narrative si rincorrono, se boschi nordici si trasformano repentini in labirinti di specchi o in sipari d’opera o in spazi desertici, ancora importa se si tratta di una fiaba? Divorare le righe ““ eppure soffermarsi su ognuna ““ diventa l’unica dimensione nella quale albergare, mentre fuori gli scenari scorrono rapidi, lontani dal poter essere classificati.
La sola chiave di lettura del complesso lavoro della norvegese Hanne Hukkelberg rimane proprio quella di perdersi in percorsi impervi, sia nelle armonie che nei sentimenti altrettanto aggrovigliati, senza dedicarsi troppo all’umana ricerca di paragoni, di schemi preconfigurati, di sapori già conosciuti.
Sebbene già abituati ad audaci sperimentazioni, dal mix avant-pop e jazz del debutto “Little Things” (2005) al caldo romanticismo di “RykestraàŸe 68” (2007) fino all’intimismo più rockettaro di “Blood from a Stone” (2009), non si riesce ad arrivare a questo ultimo “Featherbrain” davvero preparati: il capriccio stilistico sperimentale e l’eccentrico agrodolce strumentale vengono abbandonati ““ o meglio perfezionati ““ per costruire una trama matura e completa, che è però al contempo disarmante per ricchezza e complessità . Momenti di delicato tremore si trasformano sotto ai nostri occhi in corse ritmate e ruggenti, fino a ritornare silenti sotto altra forma, magari più algida e distaccata. Le prodezze vocali che riportano a una certa Regina Spektor e gli audaci chiaroscuri sonori che fanno affiorare il facile nome di Björk, rappresentano in realtà solo una piccola parte dell’universo di Hanne Hukkelberg, fatto in realtà di un’atmosfera più casalinga e meno magniloquente, con eserciti di oggetti trasformati in strumenti musicali (chi ricorda i Seabear?) e suoni sempre un po’ sporchi, come di un racconto ascoltato dalla viva voce di un attore. La stessa Hukkelberg parla di antique pop music, concetto che ben coniuga il sapore anticato e autentico di melodie che non sono mai troppo solipsistiche dal diventare inavvicinabili, anche quando un certo gusto colto le porta lontane dal sentire abituale.
Questi dualismi fanno quindi di “Featherbrain” un lavoro estremamente maturo, che coniuga altissimi lirismi in stile Joanna Newson o My Brightest Diamond a spunti più folk (Devendra Banhart?), che spinge la prog tedesca ad abbracciare eco di antichi lied germanici. La confessione ricamata nel silenzio di tintinnii meccanici (“Featherbrain”) apre il racconto trasformandosi subito in una dirompente cavalcata romantica, a tratti furiosa (“Noah”, uno dei pezzi più riusciti dell’album), che si conclude in una paranoica e febbrile dichiarazione d’amore (I sing you). Una stanza dei bottoni e dei giocattoli meccanici (“The Bigger Me”) può trasformarsi in un confessionale turbato da apparizioni mistiche e sognanti (“My devils”) e subito dopo in un bosco di ingranaggi ritmati in cui corsa e sosta si alternano (“Too Good to be Good”) o in un sabba infuocato in una notte di autunno (“SMS”). Una dichiarata immersione nel sogno privo di tempo e di spazio (“The Time and I and What We Make”) fa dubitare della realtà degli universi finora immaginati, ma l’esitazione viene subito soffocata dai richiami tribali della danza (“You Gonna”, il brano forse più commerciale à la Florence and The Machine). Rimane solo il tempo di scoprisi ai titoli di coda, ricamati sull’ultima pagina di un antico volume, dimora fantastica di pupazzi automatici e strumenti scordati (il germanico Erik, duetto con l’ottantenne maestro norvegese Erik Vister).
Anche senza conoscerne il finale, questa fiaba ““ che è stata canto epico e bildungsroman, lettera romantica e racconto gotico ““ rimane una fiaba. Semplice, ma impossibile da comprendere fino in fondo. Semplice, ma in grado di dare forma e sostanza al groviglio di emozioni che ci agita. Semplice da raccontare, ma che deriva la sua bellezza nell’atto dell’ascoltare.