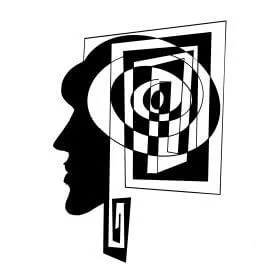In una interessantissima recente intervista al Guardian, Laura Marling parla del suo trasferimento a Los Angeles e di come abbia scoperto un fatto singolare, cioè che Americans ““ they’re just a lot more poetic. I don’t know whether I’ve sort of fallen out of love with English charm, the reservedness of it”….
Un altro passo in avanti per la giovanissima inglese, che con questo arriva a quota quattro album a soli 23 anni: un grande passo in self-confidence e in saggezza sull’amore e tutto ciò che ci gira attorno.
Come al solito, Laura opera introspettivamente: si guarda in azione, si studia e poi racconta, senza mai citarsi o dare al pronome personale “I” troppa importanza; è il “you”, piuttosto, quello che ricorre più spesso lungo tutto l’album, ossia l’altro da sè con cui bisogna fare i conti in qualsiasi “relationship”. Nella stessa intervista, Laura spiega la sua filosofia delle relazioni sentimentali, e osservando la sua storia più o meno recente arriva alla conclusione che tutti i rapporti che ha avuto (stiamo parlando in particolare di quelli con Charlie Fink dei Noah and the Whale di cui faceva parte e di Marcus Mumford che per lei suonava la batteria) sono serviti allo scopo in quel determinato periodo, sono serviti cioè a renderla una persona migliore. Tutto questo discorso serve a capire il personaggio di Once I was an eagle.
Le prime cinque tracce sono il contrario di una suite: pensate come un’unica lunga canzone ma separate al momento della scrittura su disco. Pochi strumenti, in un crescendo verso ciò che ci riserverà la seconda parte del disco. “Master Hunter” è l’epilogo di una multi traccia a volte faticosa da reggere, a volte fluida come un fiume in discesa: citazione Dylaniana al momento di it ain’t me babe, no no no it ain’t me babe. Momento clou della storia. L’atmosfera si incupisce con “Little love caster” e “Devil’s resting place”, quest’ultima a metà tra Johnny Cash e qualcosa di piacevolmente irish. Poi un violoncello chiude la prima parte. Unico momento tragico della storia, che da questo momento assume liriche “mitologiche”. “Undine” è la ninfa cui Laura si vota e a cui chiede di essere ammessa nella sua dimora acquatica: Oh Undine so sweet and pure / Make me more naive / Oh Undine, sing your love to me.
Da qui in poi è la Marling che abbiamo conosciuto nei precedenti (capo)lavori: un organetto accompagna l’arpeggio pacato e sognante molto Simon and Garfunkel di “Where can I go?”, che poi si trasforma in una cavalcata sostenuta verso”…dove? Non lo sa neanche lei: All I see is road / No one takes me home, /Where, where can I go. Il riff di chitarra elettrica in “Pray for me” ha un sound arioso in stile Fleet Foxes (solo quello, sia chiaro), “When you are happy” è Bob Dylan che passeggia con Nick Drake, mentre “Little bird” fa capire che questa ragazza è sicuramente la prima fonte di ispirazione del trio femminile The Staves.
Laura Marling ha capito molto riguardo all’amore e al suo cantarlo: Love’s not easy /Not always fun / And words are sleazy / My love is better done (“Saved these words”), e vive con la leggerezza di chi non prende quel che succede come semplice casualità , ma come occasione. Ogni momento è occasione di crescita, ogni passo porta con sè il passato e una certezza nuova sul presente; una lucidità descrittiva e lirica così adulta merita la nostra attenzione e la nostra lode: è lei la regina del folk del 21esimo secolo. La sua poesia è storia di tutti i giorni, è esperienza comune eppure fuori dal comune, perchè è semplice, ma è narrata come un capolavoro.