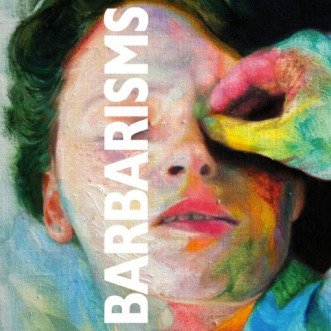Maledetta nostalgia. Confesso di aver ascoltato per la prima volta le sette tracce che compongono l’omonimo debutto dei Viet Cong carica di aspettative. Perchè sì, è vero, quello della band di Calgary è un debutto, ma un debutto tra obbligatorie virgolette.
Perchè quando ci sono di mezzo Matt Flegen e Mike Wallace, praticamente i due terzi di quel bellissimo progetto finito presto (e finito male) che furono gli Women, le aspettative si fanno sentire eccome. Perchè quella “Black rice”, che pure l’onnipotente Pitchfork aveva inserito tra le “500 songs of the 2000s”, la senti dentro ancora. E allora diciamolo subito: i Viet Cong non sono gli Women. Ma diciamo anche: “Il re è morto, viva il re”. Perchè Viet Cong, al terzo ascolto ormai completo, cresce ancora e soprattutto pare un disco clamoroso nel suo genere.
Il problema sta tutto nel definire quale genere. Etichettarlo come post-punk? Riduttivo. I quattro pescano a piene mani nell’alternativa americana anni ’90, quella dei ragazzini con i walkmen e di “Dirty” dei Sonic Youth. Ma negli oltre sei minuti di “March of progress” c’è anche l’art rock dei primi Liars. Negli undici minuti dell’ultima, splendida, “Death”, c’è il lo-fi noise e il garage dei Disappears. E forse non è nemmeno un caso che l’etichetta discografica che produce la band canadese, la Jagjaguwar, produca anche, tra gli altri, i Dinosaur Jr. di J Mascis e gli Oneida.
Cantato un po’ distorto, la batteria di Wallace in primo piano, tanta cupezza.
Relay, replay, react and respond, ordina la voce di Flegen in una “Silhouettes” dall’energia viscerale. Ed è un attimo perdersi e ritrovarsi a premere “repeat” ancora e ancora.
Dicevamo? “Il re è morto, viva il re.”.