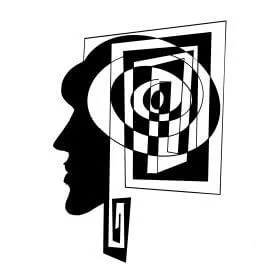Premessa: una volta ho visto suonare i Mumford & Sons in una modesta piazzetta marchigiana. Poco prima del live ho riconosciuto il suonatore di banjo Winston Marshall che passeggiava con un gelato in mano; indossava la stessa canottiera da lavoro nei campi con cui sarebbe salito sul palco, e nessuno mi ha creduto. C’era una certa semplicità di intenti nell’aria ed è stato bello (anche il concerto).
Premessa, parte II: i Mumford & Sons ora suonano negli stadi. Li riempiono proprio. Non so se mangino ancora gelati per strada, ma il loro ultimo album “Wilder Mind” è roba da spalti in odore di dollaroni. E nemmeno collaborare con Aaron Dressner dei National è stato sufficiente a salvarli da un appiattimento commerciale di mano pesantissima.
Intendiamoci, non c’è mai stato nulla di autentico nella musica dei Mumford. Hanno sempre fatto canzoni di cartapesta. Ma il fascino di questi ragazzotti londinesi, nell’anno 2009 o giù di lì, era esattamente quello di un atto teatrale riuscito. Titolo: “L’età dell’innocenza”. Il banjo e i vestiti della servitù in Dowtown Abbey li rendevano un po’ contadini avvinazzati nei giorni di festa, un po’ suonatori di strada fra americana e bluegrass (in versione alt-rock, e lo chiamammo neo-folk). I versi fregati ai sonetti più pop di Shakespeare e gli anacronismi come “puoi inginocchiarti davanti al re e dire che sei onesto?” (“White Blank Page”) aggiungevano un sapore retrò di buoni sentimenti e amori puliti, di cui forse avevamo bisogno senza saperlo. La formula insomma funzionava e in molti sono saliti sul carro del vincitore (e lo chiamammo folk-revival): Lumineers, Edward Sharpe & the Magnetic Zone, Vance Joy, ecc., tutti in classifica e in camicia rustica.
Non è una colpa cercare di uscire dalla gabbia aurea dei primi due album, non è detto che sia un azzardo, non necessariamente, mettere da parte il banjo per la chitarra elettrica. Non è certo un errore collaborare con un big producer come James Ford (Arctic Monkeys, Florence and the Machine, Haim). Per fare questo, però, i Mumford hanno pagato il caro prezzo dell’identità . Piacessero o no, questi quattro erano qualcosa di definito a linee marcate. Invece, sentiremo “Believe” o il pezzo forte “The Wolf” in ogni radio e finchè non tireremo fuori Shazam rimarrà l’incertezza che si tratti dei Coldplay, degli U2 o, peggio, di qualche altra stellina simil-rock passeggera come i temporali estivi. Roba da classifica di Rolling Stones, il che non è più un complimento dal 1990 circa.
Ciò detto, il terzo lavoro dei Mumford & Sons non è un album fatto male: si percepisce il tentativo di riempire il vuoto di contenuti con una pacchiana ricchezza musicale. La composizione è stratificata in un gioco di crescendo percussivi incalzanti al punto giusto, la voce di Marcus Mumford ancora calda e convincente. Niente di tutto questo, però, si fa portatore di un qualche valore artistico, nel vero senso del termine: piuttosto, quel che rimane è un prodotto discreto pronto al consumo e con l’etichetta del prezzo in vista.
“Wilder Mind” non è un album brutto, no, ma è un album qualsiasi di una band adesso qualsiasi, un tempo riconoscibile nel suo genere. E questa, si sa, è una colpa ben maggiore che smettere di suonare il banjo e riempire gli stadi.
Phot Credit: Roostertopgun, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons