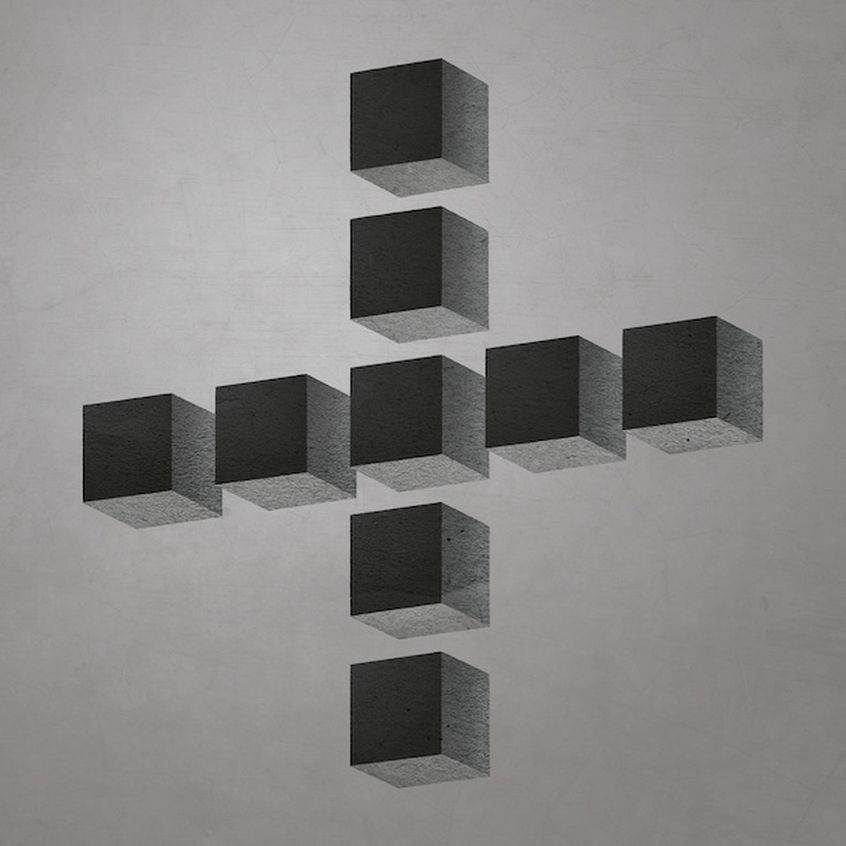Con l’imminente uscita del nuovo disco dei Ride post-reunion, va a completarsi la recente fase di rinascita che ha riguardato la “sacra triade” dello shoegaze (ovvero le tre band più in vista, tra le tantissime del genere), iniziata con il convincente “MBV” dei My Bloody Valentine e proseguita con il nuovo album degli Slowdive in questione. Sono tornati persino i Jesus and Mary Chain, seppur con l’interlocutorio “Damage and Joy”, celebrati avi di quella sorta di movimento musicale che in punta di feedback assordanti ma eterei mise in atto una rivoluzione rumorosissima eppure altrettanto silenziosa, poi spazzata via dall’avvento del grunge americano.
Gli Slowdive, dopo essersi riformati nel 2014 e dopo alcuni anni di concerti in giro per il globo, tornano quindi a dare alle stampe il primo disco dopo ben ventidue anni di assenza dal mercato musicale. Trattasi di un lavoro in studio che riesce ad unire mirabilmente un mood dimesso e sfuggente, che riflette l’inclinazione trafelata dei suoi protagonisti, alla necessità di ricercare a verticalità sempre più ultraterrene e abbacinanti slanci di eleganza aurorale. La quarta opera della ritrovata band di Reading è sì, dunque, l’opera della maturità , ma non nel senso di un imbolsimento del suono e dell’attitudine. Piuttosto, con passo tremolante eppure sicuro, riesce a riprendersi quello spazio ideale nel flusso dei suoni dell’Oggi, permettendo al quintetto di raccogliere con movenze sontuose la propria immensa eredità . Numerosissimi act nel corso degli anni ’00 e ’10 hanno cercato di emulare le intuzioni dello shoegaze primigenio oppure ne hanno tratto ispirazione, con le loro proposte originali aggiornate al nuovo sentire post-tutto. Ma non si pensava che i pionieri del genere potessero essere così in forma, vedi appunto anche la già citata band dello sperimentatore Kevin Shields.
Gli Slowdive sono rimasti nell’immaginario come, probabilmente, il gruppo più “dreamy” e trascendentale della famosa triade. “Slomo”, posta in apertura, non tradisce le aspettative “eteree”, mescolando avvolgenti sinuosità ambientali ancora memori di Pygmalion (disco che sancì, allora, la fine della band) a tenuissimi barbagli acustici, plettrate sfilacciate da delay al ralenti e solenni palpiti, a tracciare cheti solchi in orizzonti sfarfallanti di sogno.
“Star Roving”, singolo di rodaggio dell’album, mostra subito un’andatura più vivace e una fisionomia più muscolare. Volendo, potremmo definirlo come un pezzo più standard se pensiamo all’idea di energico pezzo shoegaze nell’immaginario musicale comune. Questo sulla superficie, perchè il “mestiere” dei cinque permette loro di ammantare i turbinii chitarristici di una raffinatezza difficilmente eguagliabile. Sul versante più propriamente dream-pop troviamo l’altro singolo “Sugar For The Pill”, sontuosa ascesa verso l’abbraccio di catartiche armonie di synth, una gradita “sorpresa” che proietta la band verso territori più pop, ma di un pop impossibile, come proveniente da un mondo quadrimensionale.
Non si può poi definire meno che sublime il potente refrain ascensionale della romantica “No Longer Making Time”, semplice e delicata dedica/preghiera, palpitante mix di quiete ondivaga e albeggiante sbocciare di feedback di luce, di private emozioni urbane e natura indomita a cercare nuove vie congiunturali tra l’umano e il cosmico, tra la consapevolezza del tempo sfuggente e l’eternità del sentimento che ci sopravvive.
E il tempo quest’album omonimo lo ha sconfitto. Le otto tracce che lo compongono rappresentano la rivincita dell’amore sul passare obliante degli anni. Ma anche la rivincita della pazienza, dell’umiltà e, infine, della disciplina.
Photo: Ingrid Pop