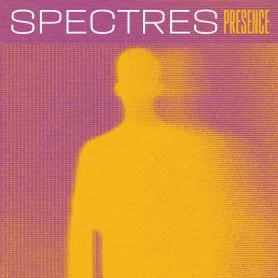Gli ultimi dieci anni sono stati alquanto difficili per Al Jourgensen e i suoi Ministry. Tra scioglimenti annunciati (e mai arrivati) e interminabili tournèe d’addio, il gruppo ha inanellato una sequela di album brutti e davvero poco ispirati che ne hanno seriamente minato la credibilità , offuscando un passato glorioso costruito su capolavori quali “The Land of Rape and Honey”, “The Mind is a Terrible Thing to Taste” e soprattutto quel “Psalm 69” che, nell’ormai lontano 1992, riscrisse per sempre le regole dell’industrial. Come se non bastasse, sul finire del 2012 l’improvvisa scomparsa dello storico chitarrista Mike Scaccia, grande amico del tatuatissimo Jourgensen, sembrava aver inflitto il definitivo colpo di grazia alla band nata a Chicago nei primi anni ’80. Citando un illustrissimo fan (ed ex roadie) come Trent Reznor, a salvare i Ministry dalla “spirale discendente” ci ha pensato però il più inaspettato degli alleati: il presidente statunitense Donald Trump, la cui incredibile vittoria alle elezioni dell’8 novembre 2016 costituisce la base sulla quale poggia l’intero “AmeriKKKant”.
La copertina dell’album rivela chiaramente lo stato d’animo di Al Jourgensen riguardo la situazione attuale del suo paese: una Statua della Libertà ferita e in imbarazzo preferisce coprirsi gli occhi piuttosto che assistere all’inevitabile declino dei nobili valori da lei rappresentati. D’altro canto una democrazia è pur sempre una democrazia, e una nazione che ha votato per diventare “vittima di un clown” che piace ai suprematisti bianchi merita di essere criticata con estrema durezza. Per farlo, i Ministry si affidano agli stessi slogan che hanno portato tanta fortuna a Trump nel corso della sua campagna elettorale: i sample delle promesse e dei proclami del tycoon si trasformano in presagi di sventura nell’angosciante intro “I Know Words”, così come le sue parole a favore della tortura fanno da contorno all’imponente, splendida marcia apocalittica di otto minuti intitolata “Twilight Zone”. Nei suoi testi Jourgensen prova a scimmiottare il linguaggio elementare e poco impegnativo dei meme, dei troll e dei divulgatori di fake news che imperversano sulla rete; usa le medesime armi impugnate dai nemici per diffamare e diffondere falsità , ritorcendogliele contro. Probabilmente è per questo motivo che, come evidenziato da numerosi ascoltatori, i contenuti scarseggiano; nonostante questo, però, il messaggio arriva sempre forte e chiaro, crudo e senza inutili giri di parole.
“AmeriKKKant” è un album militante e d’impatto, soprattutto quando prova, in maniera forse anche controversa, a risvegliare le coscienze sonnacchiose dell’opposizione liberal nel singolo “Antifa” (Brown shirt little snowflakes/Never want to admit/Terrified of the red and black flag/Antifa’s the shit). Nonostante lo spirito incendiario, i Ministry continuano a sperare in un futuro senza violenze (“Wargasm”) e in cui la verità possa tornare a essere rilevante, come sottolineato nella martellante “Game Over”: The facts will always have their way/It’s not for us to be dismissive/The truth will always have its day. Quando c’è da “menar le mani”, tuttavia, questi non più giovanissimi alfieri dell’industrial non si tirano davvero mai indietro: ecco quindi arrivare il pesantissimo beat zeppeliniano di “Victims Of A Clown” e soprattutto l’hardcore indiavolato di “We’re Tired Of It”, con alla voce un Burton C. Bell dei Fear Factory particolarmente in forma.
Come da tradizione i Ministry, da sempre i paladini antirazzisti e antifascisti dell’heavy metal, danno il loro meglio quando alla Casa Bianca ci sono gli odiatissimi repubblicani. Andando contro ogni previsione “AmeriKKKant” ce li restituisce “di nuovo grandi” e li riporta alla ribalta più incazzati che mai.