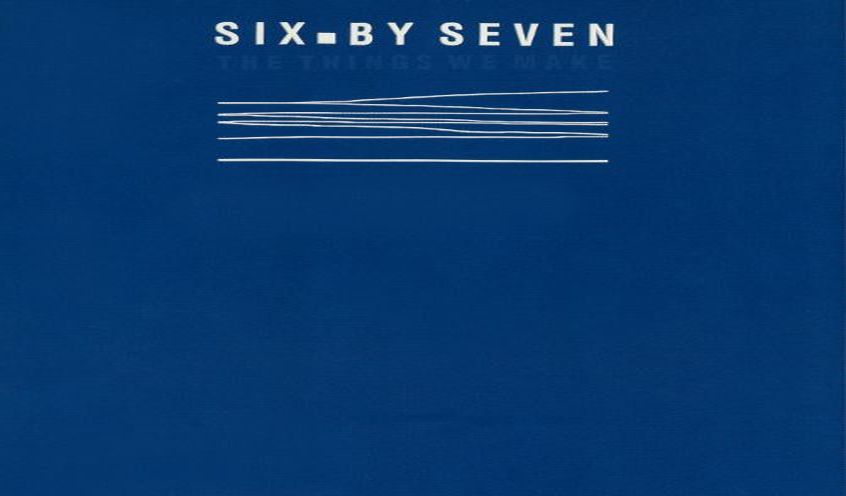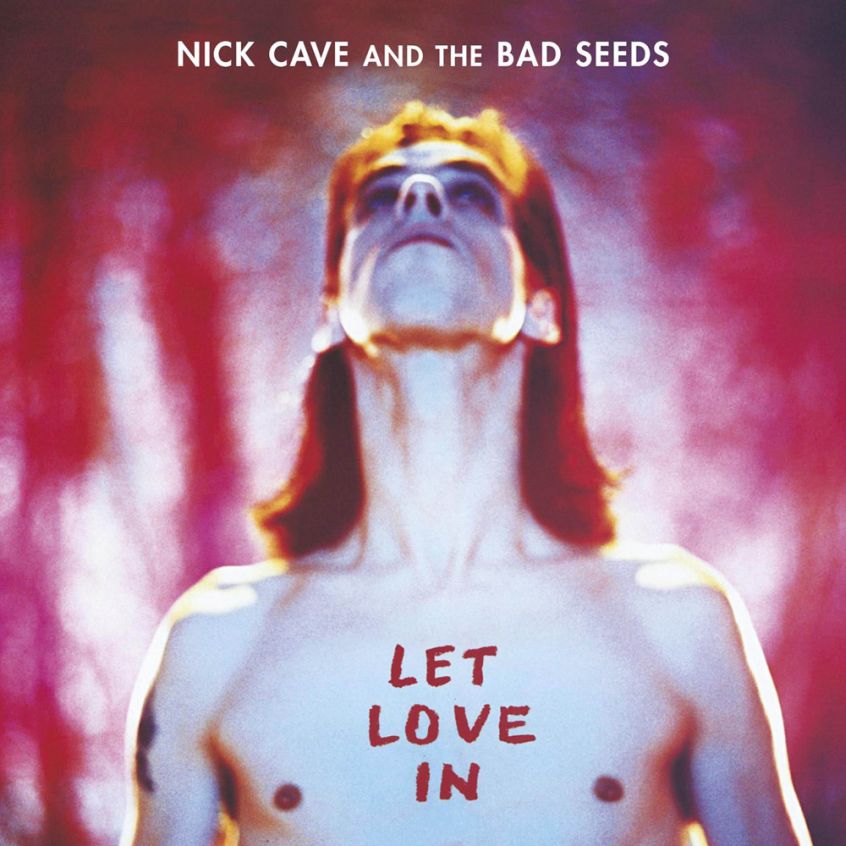Il 30 marzo, se la campagna su Kickstarter andrà bene, i Six By Seven, in quel di Nottingham, riproporranno live tutto il loro primo album. Pietra miliare, a dire poco. Occasione ghiottissima questa per riparlare con affetto e con trepidazione di un disco splendido come “The Things We Make”. Ci pensa ovviamente il “nostro” collaboratore speciale, ovvero Dario Ardias Thorre, leader degli Stella Diana, a breve protagonisti a Bologna dell’ “In a state of flux festival“, il festival shoegaze itinerante che quest’anno arriva alla sua terza edizione. Dario ha risposto al nostro invito di spendere alcune parole su un disco (e una band) che ama e noi non ci facciamo certo pregare per pubblicare il suo suggestivo articolo!
di Dario Ardias Thorre
Ci sono band che tutti conoscono, osannate, venerate, imitate, spesso definite seminali e poi ci sono gli outsider e vi garantisco che il mondo del rock sovrabbonda di questa categoria. L’outsider è tale per un sacco di motivi, troppo avanti per il periodo nel quale ha operato o magari per una formula musicale poco masticabile o forse per incapacità nel sapersi “vendere” o proporre al pubblico. Potrei star qui a dirne altre, ma ci siamo capiti. Per fortuna però, succede che la giustizia alla fine faccia il suo corso e certi suoni, certe intuizioni, qualche canzone o album interi diventino una guida, un esempio per quelli che verranno e allora la band in questione diventa capostipite e modello.
E’ capitato anche ai Velvet Underground, per citare i più grandi, pressochè nulle le vendite del primo album, diventeranno poi di culto come di culto, almeno per me, sono i Loop, gli House of Love, gli Adorable o gli Strangelove. A questa schiera appartengono i Six By Seven che esordivano vent’anni fa con “The Things We Make” (usciva il 25 maggio 1998). Il succitato gruppo rappresenta per il sottoscritto un rimpianto assoluto. Fragorosi, sopra le righe, esploratori, strafottenti, questi sono stati i SBS che hanno sparato le loro cartucce migliori nei primi due album fornendo ispirazione per chi sarebbe venuto dopo.
Provenienti da Nottingham e fondati nel 1992 dal cantante chitarrista Chris Olley insieme col chitarrista Sam Hempton, Chris Davis alla batteria, il bassista Paul Douglas e James Flower alle tastiere, sin dall’esordio dimostrano di avere idee chiare e una identità marcata e lo si vede già in “Beautiful Shape”; chitarra sinistra come intro, un crescendo inesorabile e la squarciante voce di Chris per una marcia evocativa a potente. “European Me”, lanciato come singolo, è traccia altrettanto bellicosa, lenta, cadenzata, ma suadente con voci che si insinuano tra distorsioni: un ossessivo impasto noise che si dipana per sette minuti. “Candlelight” e “For You” ci riportano su territori più “canonicamente” pop, ma mentre la prima ha chitarre offensive e una melodia di voce come una lama, la seconda si mostra più ruffiana.
I Six By Seven però, non sono fatti per una musica di facile presa e tanto per ribadirlo, con “Spy Song” ritornano a calcare lidi più spigolosi, spruzzati di post rock e new wave a singhiozzo con quel sax buttato là dove non ti aspetteresti. “Something Wild” tiene fede al titolo ed è davvero selvaggia aprendosi in bilico tra chitarra e organo. Via via si aggiungono batteria e basso per poi esplodere. “Brilliantly Cute” è squisitamente post punk, ma “Things We Make” si fa apprezzare per la sfaccettata diversità che ci propone e “Oh Dear” dimostra quanto la voce di Chris Oley non sia solo cartavetro, ma degna invece di ricamare trame romantiche ed amozionanti sostenuta da una splendida chitarra.
Lo stesso pathos lo ritroviamo in “88-92-96” (anche questa uscita come singolo, indimenticabile la prima volta che vidi quel video a MTV!!!), arricchita da un organo marziale e da un mood languido e sinistro. Scorre via il primo lavoro dei ragazzi di Nottingham con “Comedown”, un minuto e venti di lezione su come si scrive una canzone che ti si pianta in testa e non esce più, peccato solo per quegli ottanta secondi di durata.
Cos’è oggi “Things We Make”? Innanzitutto è un album che non risente del tempo che passa, suoni ancora freschi, un songwriting ispirato e una band assolutamente padrona dei propri mezzi, ma la cosa importante è che questo lavoro ci consegna una realtà che non ha faticato a stare al fianco di bands che all’epoca avevano (ed hanno avuto negli anni successivi) più visibilità e più hype. I Six sono, al pari degli Strangelove e delle altre band che ho nominato in apertura, ben lontane dal classico sound all’inglese (per quello che significhi), bensì come una di quelle perle rare e preziose che il tempo non fa che rendere perfette ancor di più.