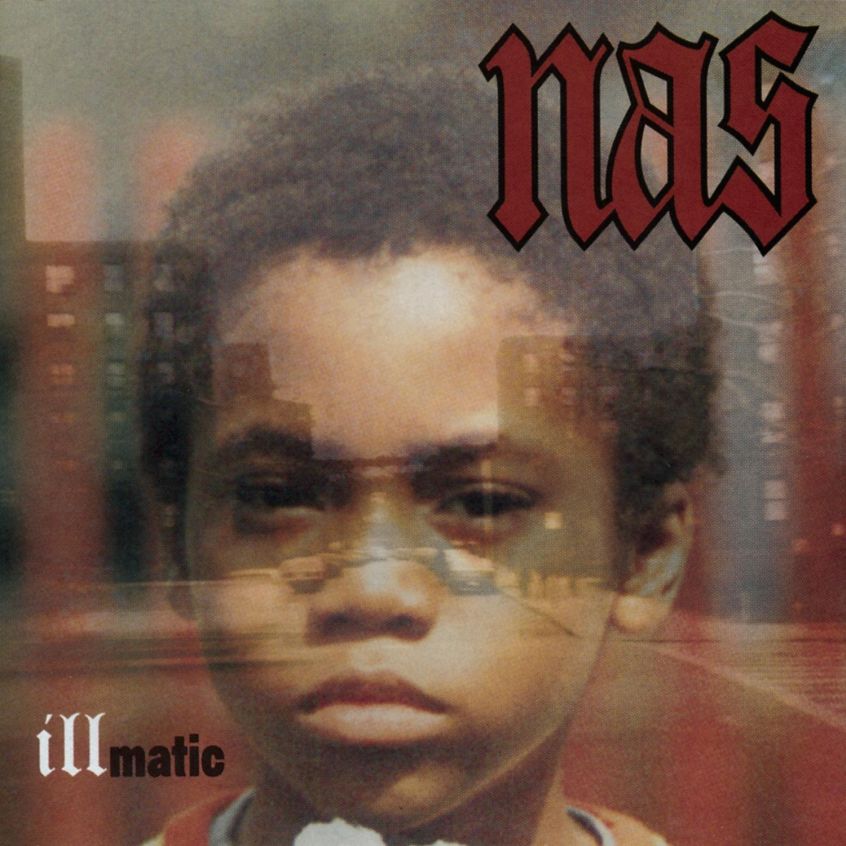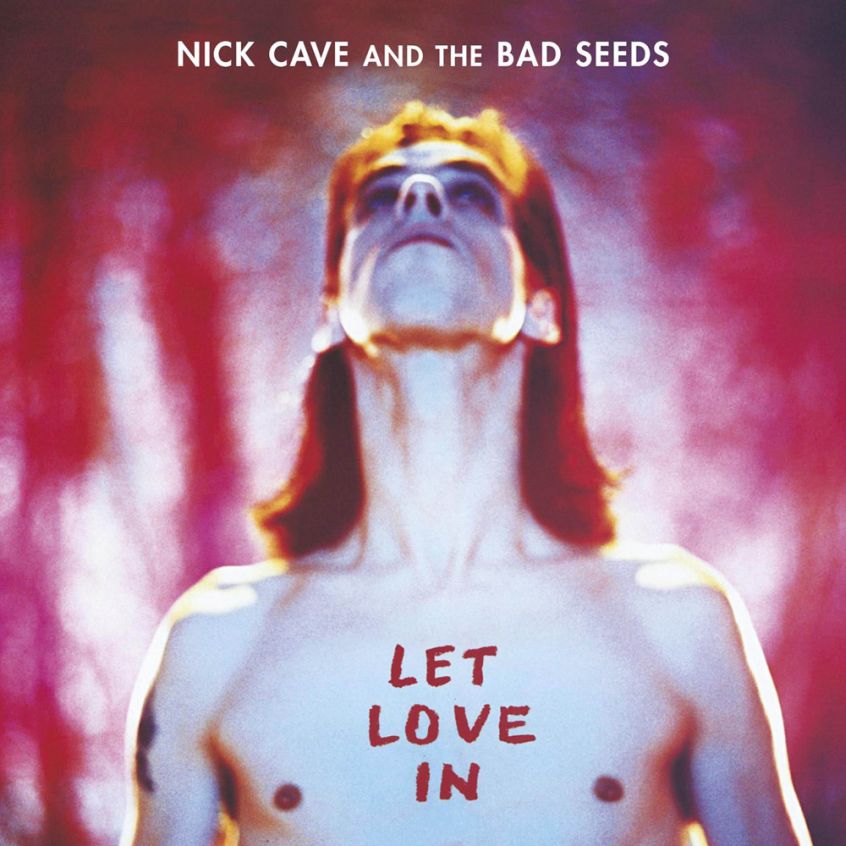Questo articolo non è un omaggio e nemmeno un epitaffio, non vuole ricordare proprio nulla nè solennizzare bensì sottolineare, semplicemente, l’opera di un artista, un musicista al quale l’appellativo di genio, silenzioso e distaccato certo, non è assolutamente peregrino.
La prima immagine che ho dei Talk Talk è quella datata 1986, avevo undici anni, della loro performance a Sanremo ovviamente in playback dato l’italico contesto, sebbene in quegli anni il festival osasse sia con ospiti stranieri che con concorrenti come Garbo, Santandrea o i Canton.
Vidi tre individui che si dimenavano tra le note marziali di “Life’s what you make it” e il cantante/pianista, che ai miei occhi di fanciullo pareva un Muppet, con occhialoni neri e caschetto era il più invasato dei tre. Rimasi ipnotizzato e pian piano, negli anni a seguire, ebbi modo di approfondire il mio rapporto con i Talk Talk. Potrei mai chiamarli meteora pop anni 80? Potrei mai definirli solo attraverso i loro singoli di più successo? Singoli peraltro di finissima fattura: “Such a Shame”, “Dum Dum Girl”, “It’s my Life” e via discorrendo.
Perle pop raffinate, mai banali, ma che già lasciavano intravedere la finezza musicale del terzetto londinese: arrangiamenti curatissimi, il basso di Paul Webb in primo piano con linee divine, testi profondi e la voce di Mark Hollis, rauca, disperata, ma fragile. Questo erano i Talk Talk che dopo essere entrati nel salotto del pop da classifica con “The Party’s Over” del 1982 e “It’s My Life” dell’84, iniziano a ragionare sulla reale possibilità di crearsi uno spazio autonomo e dare sfogo alla loro creatività . dal 1986, le cose iniziano a prendere una piega diversa. “The Colour of Spring” fa capire ai più attenti che Mark Hollis e soci stanno prendendo il largo. “Happiness is Easy”, il primo brano, non ha nulla di godereccio, è sinistro, evocativo, elegante, quasi jazzato.
Così come “I Don’t Believe in You”, Sghemba, arcana e così lontana dall’essere cantata distrattamente. Il pregio dell’album però risiede nel sapiente equilibrio di proto sperimentazione e pezzi in grado di entrare in classifica e restare immortali, tra tutti “Life’s What You Make It”, trainata da un videoclip monumentale e “Give it up”, autentico capolavoro.
Ad oggi, “The Colour of Spring” risulta l’album più venduto del terzetto. Sono le prove generali comunque. “Spirit of Eden” del 1988 destruttura tutto, annienta ogni liquame pop, allontana ogni ammiccamento alla forma canzone. Inquietante come la sua copertina, ma stranamente libero e liberato da ogni ossessione o disegno; è pura aria, respiro a pieni polmoni davanti a panorami sconfinati e ogni canzone, o per meglio dire suite, si libra senza freni vagando tra jazz, sperimentazione, rumorismi e voci sussurrate, accennate e timidamente appoggiate alla melodia.
“The Rainbow”, “Eden”, vertice assoluto, “Desire”, si susseguono incorporee e misteriche e ci consegnano una band ormai proiettata in una nuova dimensione.
La strada è tracciata e Mark Hollis, Paul Webb e Lee Harris ormai fanno musica per loro e per chi avrà la pazienza di seguirli e se qualche germe di terrestre musicalità c’era ancora stato, con “Laughing Stock”, del 1991, è definitivamente perduto.
“Myrrhman” è uno scrigno in una vecchia soffitta che si apre lentamente per liberare suoni che si cercano e provano a unirsi senza un tema apparente. “Ascension Day” sembra provenire da un’altra epoca, parte violenta poi si azzera lasciando spazio ai vocalizzi, sostenuti dall’incedere della batteria, di Mark che ormai ha preso pienamente le redini del progetto firmando tutte le composizioni. “After the Flood” è atonale, sottile, viene da lontano e ci riempie le orecchie di suoni stentorei con una voce che ricama lontana i suoi disegni. I Talk Talk stanno suonando post rock con quasi dieci anni di anticipo e stanno tracciando il sentiero per i Bark Psychosis, Mogway, Tortoise, June of 44 e si, persino i Radiohead che hanno saccheggiato emotivamente negli ultimi anni tutto quello che Mark e soci avevano già toccato.
La corsa dei Talk Talk finisce qui e in silenzio spariscono come fantasmi. Negli anni le notizie sono pari allo zero, poi, all’improvviso, nel 1998, arriva una voce dal nulla. Mark Hollis ha qualcosa ancora da dirci, l’ultima. Un disco solista che si palesa in punta di piedi, con rigore e misura come il suo autore. Basta il primo pezzo per dimostrare che il genio esiste. “The Colour of Spring”, titolo che si riannoda al passato, è una composizione asciutta, piano e voce, ricca di pathos, lenta, carica di vuoti, emozionante. “The Watershed” riporta in vita gli ultimi sperimentalismi della band, ma in modo più sommesso. “A Life (1895-1915)” è impressionista, conturbante, pianoforte che insiste sulle stesse note, spruzzate di ottoni, melodie incompiute per un brano fluttuante. Tutto il disco è così, un costante flusso informe, esile, malinconico e consapevole.
Mark ci culla con i suoi sussurri dandoci delle tracce, delle flebili impressioni interiori, umori che non richiamano monumenti acustici come Nick Drake o Sybille Baier, ma sono acquerelli in chiaroscuro senza tempo e senza ansie di dover essere compresi per forza. “Westward Bound” in questo è chiara; chitarra e voce che si incontrano se non per brevi tratti, al buio cullandoci nella ricerca di qualcosa che vorremmo vedere inquadrata, definita, ma che non lo è, non può esserlo perchè è solo musica, puro suono, pure emozioni.
Mark Hollis è morto, ma solo per quelli che ne hanno sentito vagamente parlare o per quelli che ricordano i pezzi più semplici dei Talk Talk. Io ne amo il genio cristallino, l’assoluta modestia d’artista e l’invidiabile senso della misura arricchita dal costante silenzio che lo ha sempre caratterizzato. Da ora il suo non essere più, parafrasando Montale, è mancanza e può (farmi) affogare.