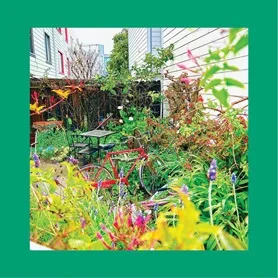Dieci anni di silenzio discografico valgono più di un semplice indizio: la spinta creativa dei Rammstein si è esaurita. E da un pezzo, per giunta: il pozzo delle idee deve essersi prosciugato più o meno ai tempi di “Reise, Reise”, uscito nel 2004. Un album con cui la band tedesca decise definitivamente di adagiarsi sugli allori di una fama tanto spropositata quanto inattesa, ai limiti dell’inspiegabile.
La loro forza? Essere riusciti a trasformare quelli che, almeno inizialmente, furono considerati punti deboli in armi vincenti: la scelta di Till Lindemann di cantare nella lingua madre, una visione dell’industrial metal dal gusto tipicamente mitteleuropeo, un’antipatia mai celata per l’America e il capitalismo e, dulcis in fundo, uno spirito controverso che emerge in maniera evidente in buona parte dei costosissimi video-kolossal prodotti.
Tutti elementi che hanno contribuito a rendere il gruppo nato a Berlino nel 1994 un’anomalia del rock mainstream di inizio millennio. Un’anomalia attraente e al tempo stesso spaventosa: i Rammstein degli esordi facevano davvero paura. Non tanto per il vocione baritonale del frontman o per la durezza della musica – da sempre tra l’altro mitigata da dosi generose di melodie orecchiabili ““ ma per l’attitudine cinica, dissacrante e letteralmente incendiaria che si palesava con forza negli spettacolari concerti, pieni zeppi di giochi pirotecnici.
Cosa resta oggi dell’antico fuoco? Il minuscolo fiammifero immortalato sulla copertina di questo settimo album omonimo. Troppo poco per riaccendere gli stimoli dei sei appagatissimi ultracinquantenni cresciuti nella Repubblica Democratica Tedesca, il cui unico obiettivo ormai sembra essere rassicurare i fan con una manciata di brani privi di sorprese ma di facile presa.
Proseguendo l’opera di smussamento e addolcimento degli elementi tipici di quella Neue Deutsche Härte che loro stessi contribuirono a fondare con classici quali “Herzeleid” e “Sehnsucht”, i Rammstein danno alle stampe un disco costruito apposta per raggiungere i vertici delle classifiche di tutto il mondo. Un disco smaccatamente pop, tanto per intenderci. Nulla di male, per carità : non è neanche la prima volta che lo fanno. Il problema è che praticamente nessuna delle undici canzoni in scaletta ““ a esclusione della possente “Deutschland”, un’epica lettera d’amore/odio rivolta al paese d’origine e ai suoi innumerevoli spettri ““ riesce a trasmettere un qualche tipo di emozione.
Nessuno trema più di fronte all’ex terribile sestetto. Prendiamo a esempio “Radio”, il secondo singolo estratto: un buon pezzo, ma il contrasto tra il muro di chitarre eretto dal duo Richard Z. Kruspe ““ Paul Landers e le tastiere “telefoniche” di Christian Flake Lorenz è qualcosa di talmente trito e ritrito da suonare alla stregua di una parodia. Cori drammatici degni dei Carmina Burana aprono l’energica “Zeig Dich”; a fare da contraltare ci pensa “Ausländer”, un vivace divertissement in odore di EBM nel quale quel burlone di Lindemann, facendo un po’ il verso al rappato del compianto Falco di “Rock Me Amadeus”, celebra il multiculturalismo dell’Europa unita con un testo che include anche un Ciao ragazza che ci riempie di italico orgoglio. Un bel messaggio da parte di una band il cui cuore, nonostante gli infondatissimi sospetti che si portano dietro da non si sa quanto, batte con forza a sinistra (ricordate “Links 2-3-4”?).
Un barlume dei vecchi Rammstein si avverte nella spaventosa “Puppe”: la tensione si taglia con un grissino, tra strofe inquietanti e ritornelli colmi di urla da ossesso. Purtroppo non è abbastanza per risollevare le sorti di un album decisamente non brutto ma abbastanza piatto, pieno zeppo di riempitivi (“Weit Weg”, “Tattoo” e “Hallomann”, tre tracce non a caso poste in chiusura, faticano a lasciare il segno) e citazioni molto poco colte: “Sex” si appiccica in testa immediatamente, ma potrebbe essere uno scarto di “The Golden Age of Grotesque” – non proprio la prova migliore firmata da Marilyn Manson. I fan duri e puri apprezzeranno. E, in fin dei conti, basta e avanza.