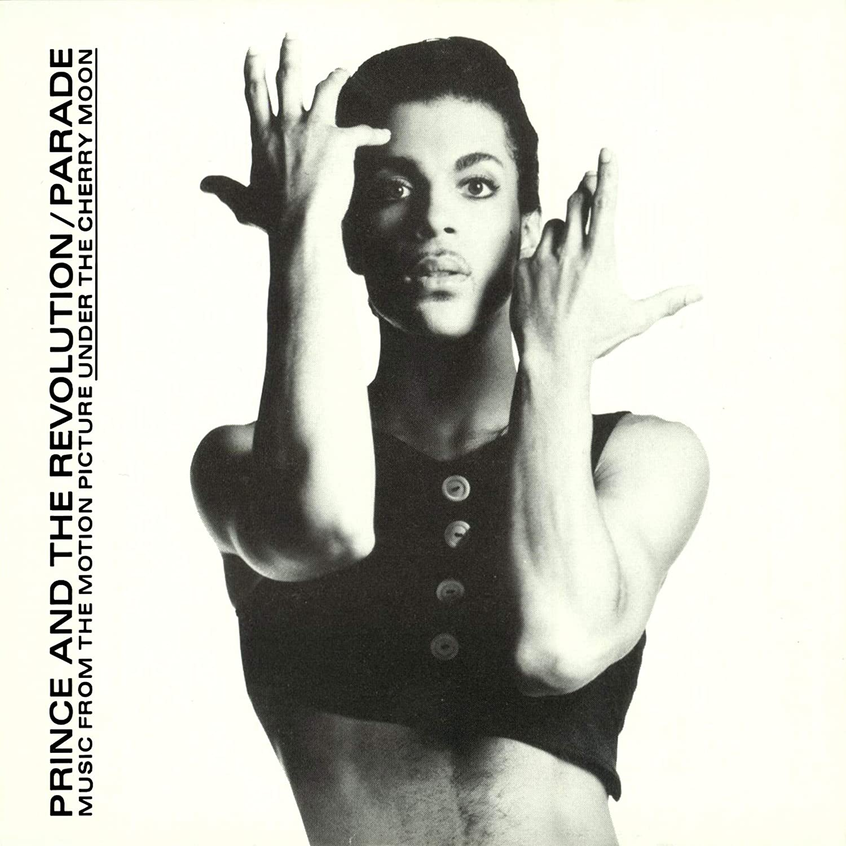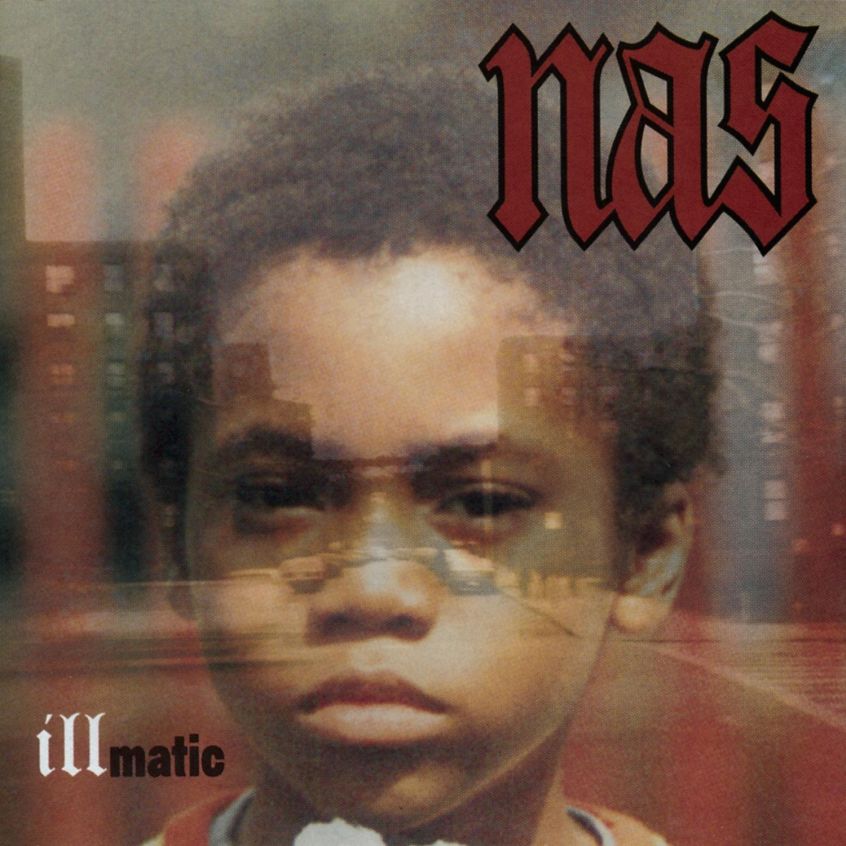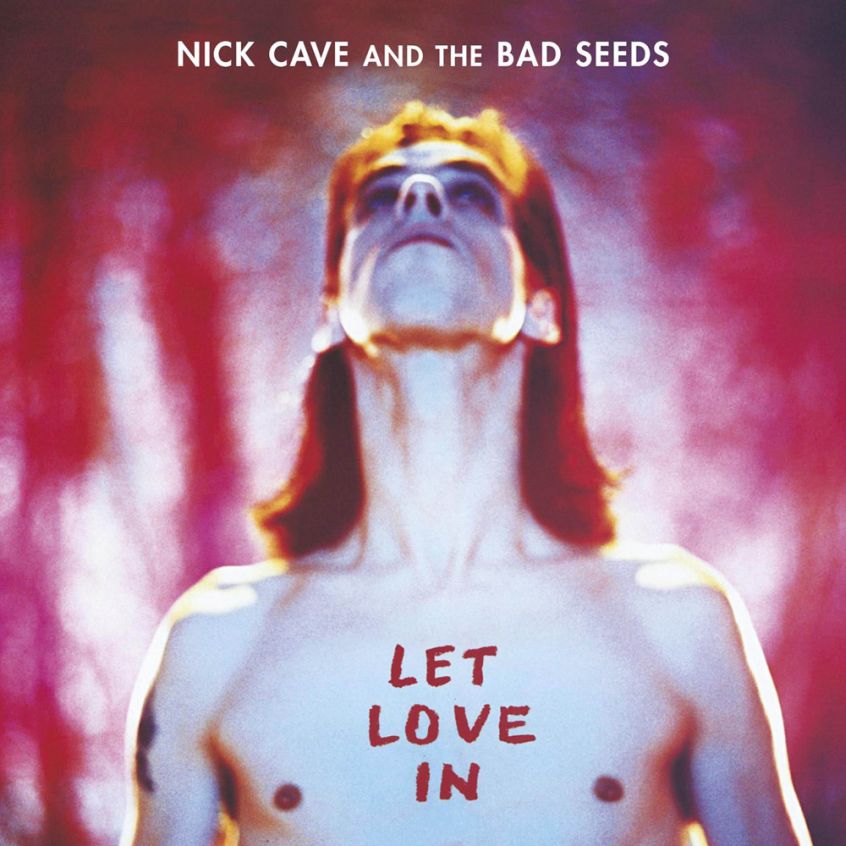La vita di Jim Morrison, e di conseguenza quella dei suoi Doors, è stata breve e fulminea, leggiadra come una farfalla, abbagliante come una cometa e in grado di lasciare un segno indelebile al suo passaggio.
Ascesa imperiosa e tonante caduta, tutto in un batter d’ali: ogni cosa compiuta tra il 1967, anno del debutto con l’epocale disco omonimo e il 1971, quando il cantante fu trovato morto in circostanze mai del tutto chiarite in un hotel parigino. Una vita letteralmente consumata la sua.
I Doors senza il loro riconosciuto leader, senza l’uomo simbolo, erano destinati ad avere poca fortuna: ci provarono ma con esiti artistici francamente trascurabili, così come la loro stanca musica stava a testimoniare.
Innegabilmente però in quel lustro seppero davvero consegnarci pagine destinate ad entrare di diritto nella storia del rock. Già , ma esattamente 50 anni fa, all’uscita del controverso quarto album “The Soft Parade”, chi erano diventati i Doors, e nella fattispecie lo sciamanico Jim Morrison?
L’impressione di un gruppo in piena crisi ci fu anche in presa diretta, tanto eclatanti erano stati i fatti accaduti a Miami in occasione di una tappa di un mastodontico tour negli Stati Uniti, divenuta celeberrima per motivi extra musicali che è pleonastico andare a rimembrare, ma che molto influirono sulla perdita di interesse e popolarità della stessa band agli occhi dell’opinione pubblica. Ma non solo, c’erano anche le conseguenze sempre crescenti di un alcolismo che a un certo punto sembrava non poter dare più scampo a Morrison, divenuto intrattabile, inaffidabile, l’ombra di sè stesso, dell’ammirato, istrionico, appassionato frontman che fino all’anno precedente sapeva mandare in visibilio milioni di fans in tutto il mondo, con la sua grande carica erotica, il suo magnetismo, le sue parole così assimilabili a vere poesie.
Eppure i 4 dovevano in qualche modo rimettersi in marcia, dopo aver giocoforza rinunciato a un’esposizione che poteva in quel momento rivelarsi un boomerang, come un’eventuale partecipazione al Festival di Woodstock. La divisione tra Jim e il resto della band, capeggiato in quel momento sempre di più da Robbie Krieger, era evidente e si sarebbe manifestata come non mai in quelle difficili registrazioni che avrebbero portato a compimento un album a conti fatti diversissimo da quanto prodotto prima. Una svolta ragionata però, se è vero che Ray Manzarek (altro leader occulto della band), pungolato dal fidato produttore Paul A. Rotchild, non ha mai nascosto come fosse condivisa l’idea e la voglia di sperimentare, di inserire elementi musicali diversi nella loro musica, prendendo così le distanze da quel sound energico, intriso di rock e blues che aveva fatto le loro fortune sin lì.
Anche Morrison sembrava attratto dalla possibilità di affiancarsi a un’orchestra, di tentare nuove vie espressive ma le sue condizioni non erano certo ottimali e fu quasi costretto a lasciare spazio decisionale all’amico/rivale Krieger, pur discostandosi fermamente su alcuni punti (celebre la sua opposizione nell’intitolare quello che doveva diventare il brano di punta dell’album “Hit Me”, fortunatamente poi sostituito con un più rassicurante “Touch Me”). Che siano state le circostanze a richiederlo, o l’evidenza delle cose, fatto sta che in un album dove per la prima volta i brani furono accreditati singolarmente, sono proprio quelli del chitarrista a fare la parte del leone, e a conti fatti, ad essere rimasti nell’immaginario collettivo della band (basti pensare, oltre alla già citata “Touch Me”, anche all’elegante “Wishful Sinful” o a una “Runnin’ Blue”, accorata dedica allo scomparso Otis Redding, dalla calda atmosfera country).
E’ invece un Morrison in tono minore quello che consegna un brano dimenticabile come “Easy Ride” (saranno molto più a fuoco in questo versante musicale alcuni suoi pezzi, passati poi alla storia, scritti per gli album successivi) e un pur interessante “Wild Child”, che però manca evidentemente del mordente e della visceralità cui ci aveva abituato. Il ruggito da giovane sciamano riecheggia invece nella paradigmatica “Shaman’s Blues” e, seppur in modo frammentario e confuso, nella traccia conclusiva, la lunga suite che intitola l’intera raccolta.
A penalizzare l’album sono a detta di molti proprio quegli arrangiamenti cercati appositamente per questo lavoro, quell’imponente, maestoso utilizzo di fiati che, se da una parte rende unica e irripetibile una canzone come “Touch Me”, baciata dall’immensa grazia dell’assolo di sax tenore di Curtis Amy, dall’altra va pesantemente ad annacquare l’iniziale “Tell All the People”, che invero avrebbe avuto tutte le potenzialità per diventare un’immortale hit del gruppo. Ma in fondo non convinse appieno nemmeno Jim Morrison, molto critico anzi per la scelta di utilizzare alcuni versi nel testo, tanto da lasciarlo accreditato al solo Krieger.
A dare un alone di negatività al tutto è proprio la percezione negativa che si aveva della band in quel preciso contesto storico, la stessa che invece sembra permeare in modo positivo, o quanto meno differente, gli episodi successivi “Morrison Hotel” e soprattutto “L.A.Woman”, album in cui i Doors dimostrarono di aver ritrovato se non altro una certa brillantezza ed energia che qui latitava paurosamente, ma di certo non la clamorosa ispirazione dei primi due album.
“The Soft Parade” è però l’esatta fotografia di com’era il gruppo in quel momento, con le sue contraddizioni, le sue debolezze e le diverse anime dei protagonisti intente di volta a volta a rappresentarlo.
The Doors – The Soft Parade
Pubblicazione: 18 luglio 1969
Tracce: 9
Durata: 33:59
Etichetta: Elektra Records
Produttore: Paul A. Rotchild
Tracklist:
- Tell All the People
- Touch Me
- Shaman’s Blues
- Do It
- Easy Ride
- Wild Child
- Runnin’Blue
- Wishful Sinful
- The Soft Parade