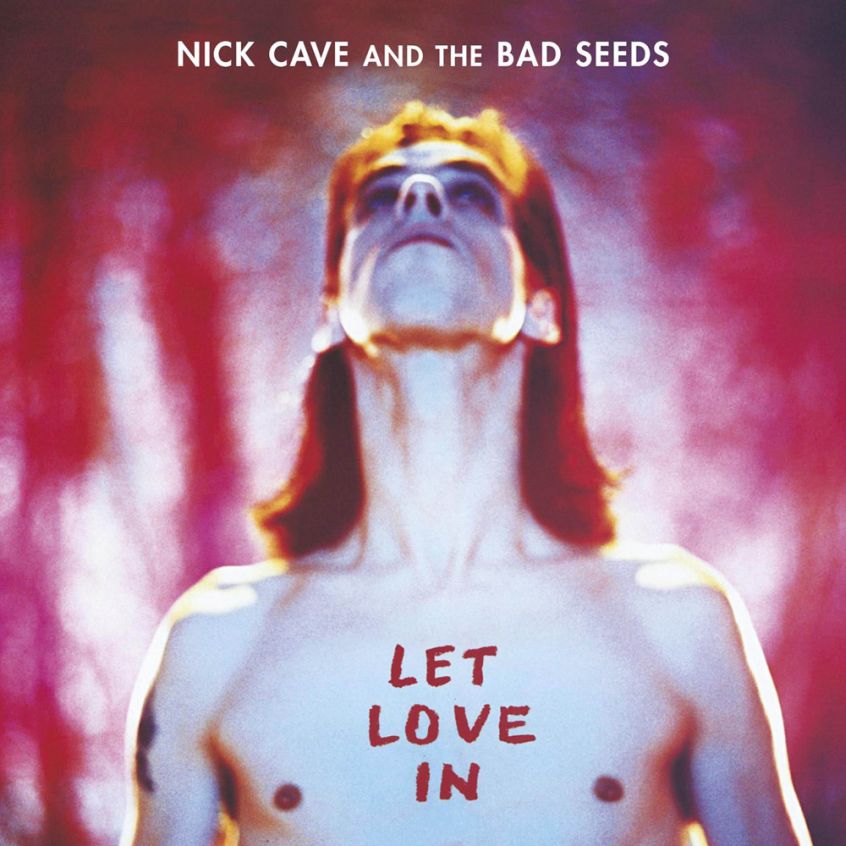Nella carriera di una band, specie in quelle di lungo corso, capita di imbattersi in dischi che, essendo rappresentativi appieno dell’anima dei loro autori, si vanno a collocare in determinati periodi cruciali, identificando talora un vero e proprio punto di non ritorno.
Sono lavori in un certo senso fragili ma che possiedono, tra le pieghe di brani autobiografici tanto salienti quanto disperati, una forza e uno spessore tali da resistere alla prova del tempo, fino a fungere, come un’Araba Fenice, da rinascita per una nuova via tutta da percorrere, corroborati dall’essere riusciti ad affrontare (e infine a superare) le più dure delle prove, sia a livello individuale che di gruppo.
Nel caso dei Depeche Mode, giù venticinque anni fa una delle band più significative e amate tout court, l’album della consapevolezza e della redenzione si chiama “Ultra”, titolo assurto con gli anni a episodio chiave per capire come i ragazzi di Basildon siano riusciti ad arrivare integri e ancora smaccatamente in forma e ispirati fino ai giorni nostri, pur alle prese anch’essi con i cali fisiologici che vanno a toccare tutti coloro che possono vantare un percorso artistico ultraquarantennale.
Senza tornare a scavare nel torbido delle gravi problematiche personali che hanno riguardato in special modo il frontman Dave Gahan (che non pare esagerato definire uno dei sopravvissuti del rock), ricordo perfettamente il clima di imperfezione e di precarietà che aleggiava sul destino dei Nostri proprio all’altezza dell’apogeo commerciale rappresentato da autentici best sellers (nonchè riconosciuti capolavori) come “Violator” (1990) e “Songs of Faith and Devotion” (1993), dopo la lunga e fruttuosa semina del decennio precedente.
Apice testimoniato oltremodo dal “Devotional Tour”, condotto però in condizioni sempre più difficili per la sopraggiunta dipendenza da eroina di Gahan e l’inevitabile quanto triste inasprirsi dei rapporti all’interno del gruppo, che avrà conseguenze irreversibili mesi più tardi, quando Alan Wilder deciderà di abbandonare stremato la truppa che nemmeno il prode Martin Gore (in quello stesso periodo alle prese con seri problemi di alcool) poteva tenere unita.
I Depeche Mode, evitato il peggio, pieni di cicatrici e conflitti ma ancora vivi, seppero estrarre dal cilindro undici nuove canzoni (dodici se consideriamo “Junior Paintkiller”, traccia nascosta che si sente in coda al disco) non solo paradigmatiche e in un certo senso urgenti, ma soprattutto profonde, vere, e con un tasso di qualità assolutamente rimarchevole.
Man mano che scorre la scaletta pare evidente l’avvenuto scarto stilistico rispetto agli illustri predecessori, con Gore che, volendo sviscerare la complessità delle relazioni umane e del proprio io, anche interiorizzando (forse mai come fatto prima) i demoni dell’amico Dave Gahan, non lesina in asprezze, volendo scandagliare il lato oscuro delle loro esistenze; nel farlo si affida a un apparato sonoro policromo, dove un ruolo essenziale è rivestito ancora una volta dall’elettronica, piuttosto che dal rock che aveva fatto capolino nei precedenti dischi.
Ovvio, non si tratta di riproporre quella musica scanzonata dei primi dischi, nè di rinverdire derive pop wave, ma di certo traspare una volontà di rimettere al centro in primis la forma canzone, contaminandola grazie all’infinita varietà di suoni sintetizzati – ma dall’anima pulsante – , veicolati dal talento del suo autore principe (il già citato Martin Gore) e dalla maestria di Andy Fletcher.
Il resto (che in percentuale è comunque tantissimo) lo fa Dave Gahan che, con la sua magnetica voce e il suo accecante carisma, rende dei classici al primo ascolto canzoni come “It’s No Good”, singolo di gran successo, l’urticante “Useless” e una “Sister of Night” dolcissima e lunare.
A colpire è soprattutto “Home”, magnifica ballad esistenzialista che non ho remore a definire tra i migliori momenti realizzati dal gruppo in tutta la sua storia; pubblicata come terzo singolo, ha inoltre la peculiarità di essere interpretata da Martin Gore (l’altro brano che lo vede impegnato alla voce è l’eterea e sognante “The Bottom Line”).
E’ il disco nella sua interezza però a meritare di essere preso in serissima considerazione in qualsivoglia disamina della vicenda dei Depeche Mode: dalla fosca “Barrel of A Gun” che apre la tracklist con i suoi toni dark, a “Insight” che la chiude con versi accorati e sinceri, passando per alcuni pregevoli strumentali come “Jazz Thieves”, il livello si mantiene sufficientemente alto, senza dare spazio a inutili riempitivi.
Nonostante non si possa annoverare tra gli album di più facile fruizione del gruppo, “Ultra” saprà facilmente imporsi nelle classifiche di mezzo mondo, issandosi fino alla vetta in Inghilterra e in gran parte d’Europa, e giungendo in quinta posizione negli Usa, il tutto senza poter contare su un tour propriamente detto, impossibile da mettere in piedi visto che, prima di tutto, si doveva pensare letteralmente allo stato di salute dei protagonisti.
Da lì in poi la strada per i Depeche Mode tornerà ad essere in discesa, con un sempre più crescente numero di sostenitori raccolti in tutto il globo, i quali in maniera fedele e devota, hanno contribuito a consolidarne il culto odierno.
Data di pubblicazione: 14 aprile 1997
Tracce: 12
Lunghezza: 60:04
Etichetta: Mute Records
Produttore: Tim Simenon
Tracklist
1. Barrel of a Gun
2. The Love Thieves
3. Home
4. It’s No Good
5. Uselink
6. Useless
7. Sister of Night
8. Jazz Thieves
9. Freestate
10. The Bottom Line
11. Insight
12. Junior Painkiller – hidden track