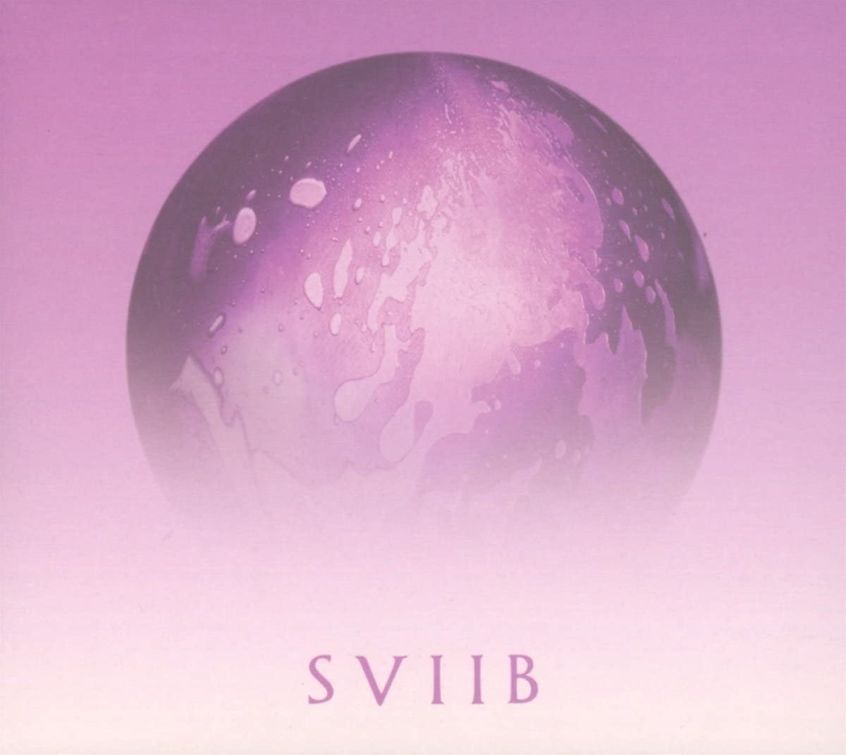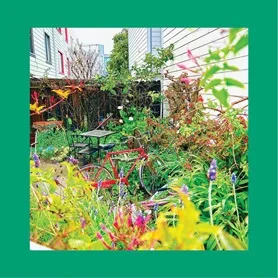Ormai lontani dai tormenti sonori dei poltergeist che infestano la letteratura tardo romantica, di questi tempi anche i fantasmi scelgono di manifestarsi secondo un armonioso e sobrio minimalismo. Abbandonato l’armamentario da parco divertimenti, tutto ululati e catene arrugginite, si presentano come puro spirito, sinfonia perpetua e riecheggiare mistico, solo a tratti più pressante. La giovane e timida Lafaye, figura centrale attorno cui si snoda l’ultimo lavoro degli School of Seven Bells ““ “Ghoststory” appunto ““ viene avvolta da un incessante tappeto sonoro esattamente come la sua vita è avvolta dai fantasmi del passato.
Fantasmi gentili, a tratti saggi, certo mai scomposti: le basi elettroniche, sognanti e distorte in un’eco infinita di chitarre, si fondono armoniche con una voce eterea a formare non un semplice muro sonoro, ma un frattale geometrico che si ripete in volute. Dal materialismo dello shoegaze all’ascetismo ipnotico del nu gaze? La sola certezza è una massiccia dose di dream pop con istinti danzerecci che, in un continuo ammiccamento anni Ottanta, fa urlare al dejavu in più di una occasione. L’ex trio newyorchese, oggi duo (la cantante Alejandra Deheza, orfana della gemella Claudia, e il musicista Benjamin Curtis) ripropone con maestria e tecnica le felici intuizioni dei lavori precedenti ““ “Alpinisms” 2008 e “Disconnect from Desire” 2010 ““ e ne approfondisce le tematiche mistiche già presenti (si ricorda una discutibile edizione limitata con carte dei tarocchi incluse nella confezione). Il risultato è però privo di originalità e, se pur di facile ascolto, non lascia dietro di sè un ricordo preciso e distinto se non una scia downtempo vagamente angelicata, come degli Zero7 deteinati e monocromatici.
Encomiabile comunque per coerenza e precisione degli ingranaggi musicali, croce e delizia in grado di trasformare storie di fantasmi in ambienti asettici, “Ghoststory” alterna pulsazioni generalmente blande a qualche traccia più concitata. “The Night” apre il disco sintetizzandone i contenuti, voce angelica di una Lykke Li il primo giorno di scuola e un allestimento eighties bon ton, che domineranno l’intero lavoro. “Love Play” segue alzando il muro sonoro con mistica ridondante e preparando a ritmi più incalzanti ed elettronici con Lafaye, l’eroina dell’album cui si dedica una delle main tracks. Il climax si raggiunge finalmente con la febbricitante “Low Times”, sei minuti strappati da un arpeggio dei Cure e dalla gola di Bat for Lashes, con un epilogo in odore di dubstep. Le emozioni finiscono qui, controbilanciando la perdita di controllo con due ballate sognanti e riempitive ““ “Reappear” e “Show Me Love” ““ che disperdono ed annacquano la parte centrale del disco, trasportandolo in pieno ambient di poca inventiva, vivacizzato da qualche abusata base synth. L’ultimo guizzo si respira grazie ai ritmi più oscuri e sincopati di Scavenger, altro incredibile clone di Natasha Khan, che recupera con uno spirito più rock e con trame più cupe l’utilizzo di chitarre distorte. L’album chiude quindi il suo spirito un po’ crossover con un sapore più rock ed effettivamente shoegaze: si salvano le drum machines e le chitarre lisergiche di “White Wind”, ma già in troppi riconoscono pericolosi furti dai My Bloody Valentine in “When You Sing”, l’ultima traccia.
Sicuramente coerenti nel non voler trasformare il loro animo mistico in synth dark dal sapore gotico e nel non farsi tentare dal lato oscuro e modaiolo degli Anni Ottanta, gli SVIIB si lasciano però sopraffare nella loro poetica sonora da una pretesa di sensibilità e fragilità che invece sembra esondare nella frivolezza e nella mancanza di contenuti originali e tangibili. La grazia e la tecnica che effettivamente si percepiscono non riescono ad arginare la sensazione finale non solo di dejavu, ma soprattutto di incompiutezza e di non finito; in questo forse riusciamo a cogliere il tema centrale dell’opera, comprendendo finalmente il ruolo centrale dei fantasmi, che ritornano o rimangono tra noi compiti ed educati, ma tormentati dal desiderio di concludere qualcosa rimasto ancora aperto, fluttuante in un limbo, mai realmente compiuto.
Credit Press: Abby Ducker