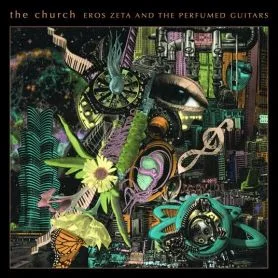Un paio di anni fa, a Roma, in una serata qualunque d’aprile, ebbi la fortuna di assistere al concerto di uno dei grandi trionfatori delle classifiche musicali redatte al termine dell’anno precedente. L’imponente John Grant, stagliandosi notevolmente sul piccolo palco del Circolo degli Artisti, cominciò uno degli innumerevoli live a supporto di un grande disco sulla bocca di tutti con, guarda un po’, un inedito. Una ballata al piano condita dal breve passaggio di un synthino sul finale, nella quale elegantemente e con la solita penna graffiante mandava a fare in culo un ex. Un signor pezzo, che nonostante non abbia sentito il bisogno di andare a ricercare nei due anni che separano questo episodio da oggi, devo ammettere sia rimasto in maniera piuttosto indelebile nella mia memoria.
Ora figuratevi voi, a tre anni di distanza da quel piccolo capolavoro che fu “Queen Of Denmark”, ritrovarsi davanti a quel brano, “You Don’t Have To”, imbastito per tutta la sua durata da un sinuoso sintetizzatore ad accompagnare la voce accademica di Grant. Allo stupore e allo scetticismo di un primo ascolto magari si oppone un po’ di resistenza a una scelta simile, salvo ricredersi che, dopotutto, non sia in fondo un danno così grosso, anzi. Se nel debutto solista dell’ex Czars già si respirava in un paio di episodi quel retrogusto sintetico, la recente notizia di un posto nella squadra del prossimo Hercules And Love Affair, ma soprattutto il primo singolo estratto dal nuovo lavoro non fanno che consolidare simili aspettative. “Pale Green Ghosts”, omonimo singolo di lancio, offre agli affezionati fan un inedito Grant suadentemente elettronico arricchito da archi e lunghi passaggi strumentali a dilatare l’atmosfera vagamente ansiogena proposta; il brano, così come gran parte dell’album, è prodotto dall’islandese Birgir àžórarinsson, già membro dei Gus Gus. E proprio a certe sonorità dell’ultimo “Arabian Horse” del collettivo islandese torna la mente in più occasioni, a partire dal suddetto singolo, passando per la seguente e meno riuscita “Black Belt”, così come in alcuni passaggi di “Ernest Borgnine”, nella quale un John Grant al vocoder svela la propria sieropositività .
A tutt’altra elettronica si rifà il tonfo di “Sensitive New Age Guy”: pessima sulle strofe, recupera vagamente al ritornello e in finale, spingendo vorticosamente Grant in un pericoloso house-pop pesantemente queer molto vicino al citato Andrew Butler, in un episodio che difficilmente affascinerà tanti estimatori del debutto. Questi ultimi possono tirare un sospiro di sollievo alle più fedeli “GMF” e “Glacier”, splendide ballate capaci di far rivivere la magia del debutto, così come nel più disinvolto folk da camera di “I Hate This Town” o della malinconica “It Doesn’t Matter to Him”; chiude il quadro l’attendibile commistione tra i nuovi guizzi elettronici e gli antichi splendori di vaga sensazione 70s, a sposarsi nel sound di una sensuale “Vietnam” che sembrerebbe rubata all’ultimissimo Tellier, o della citata “You Don’t Have To”. Nota finale: prende partecipazione ai backing vocals l’arrugginita Sinèad O’Connor, che già aveva avuto modo di esprimere il proprio plauso a John Grant coverizzando (debolmente) “Queen Of Denmark” nel recente “How About I Be Me (And You Be You)?”.
“Pale Green Ghosts” sembrerebbe dunque una buona risposta a quanti potessero sperare in un’evoluzione sonora del buon John Grant, così come per chi avrebbe preferito vedere abbracciate ancora una volta le atmosfere dell’esordio. Probabile disco di transizione, si auspica tuttavia che i divertissement più elettronici e danzerecci del nuovo Grant lascino spazio a future declinazioni solamente macchiate dall’elettronica raffinata che in parte già vive in quest’opera.