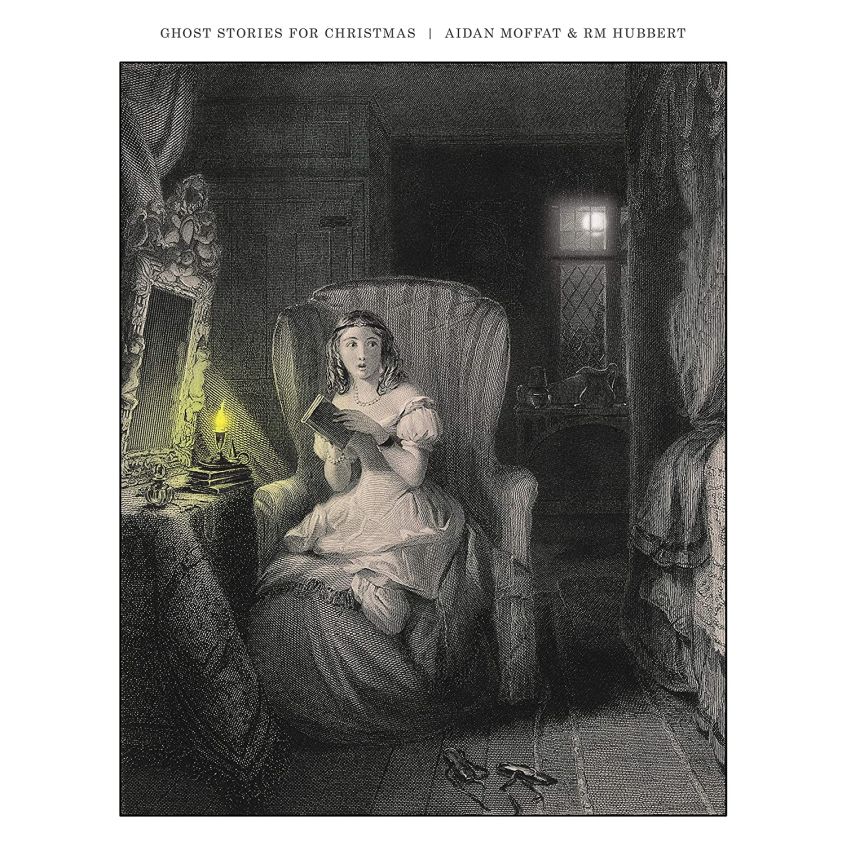La poetica di Aidan Moffat che incontra la chitarra e il gusto musicale di RM Hubbert. L’album collaborativo dell’ex Arab Strap e del musicista di Glasgow è una traversata oscura e toccante in un paesaggio il più delle volte ombroso, ma non per questo non meno ricco di momenti intensi, intimi e suggestivi, realmente da pelle d’oca, perchè quando l’alchimia tra due persone funziona, beh, tutto è possibile.
Si trova alla perfezione la chitarra di Hubbert, modellata sulle narrazioni malinconiche di Moffat, che, come spesso gli accade parla di donne, o meglio di rapporti tra uomini e sesso femminile, così come di persone che non sono più nelle nostre vite, con la solita sincerità e, perchè no, anche una piacevole punta di tenerezza e ironia, che ce lo rende così vicino, perchè sembra cantare la situazione di molti di noi, ovvero che siamo fottutamente difettati ma dobbiamo (e devono) tenerci così. I passaggi che sanno essere tanto classici (scarni eppure complessi) e pizzicati della chitarra cercano e trovano il parlato di Moffat, ma non è certo tutto qui, anzi, dalle trame vicine al Flamenco (“Cockcrow”, con la presenza di Siobhan Wilson che duetta con Moffat è semplicemente incantevole), in cui il buon Aidan canta anche in modo più che egregio, agli inserti elettronici volti a creare l’atmosfera magica mentre le voci si cercano e si sovrappongono (“She Runs”), così come tribalismi ritmici e passaggi totalmente free a sancire oscure connessioni pulsanti e tenebrose tra parole e suono (“Wolves Of The Wood”). Il disco è vitale, cangiante e non smette mai di essere stimolante e significante.
Con gente così, abituata ad usare alla perfezione le parole e a modulare i suoni in modo suggestivo, ogni particolare diventa poesia. La fine e l’inizio pastorale di “Mz. Locum”, che al suo interno è quasi solare nel suo incedere; il sax e il violoncello che ci rapiscono in “Quantum Theory Love song”; i tamburi e i lavoro ritmico invitante di “Party On”; i rumori di una sala giochi anni ’80 sullo sfondo di “Zoltar Speaks”; la dolcezza quasi alla Owen/Mike Kinsella di “Everything Goes” e la notte evocata da “Fringe”. Tutto così evocativo che pare un dipinto in musica, uno di quelli in grado di dar vita a un episodio ‘Sindrome di Stendhal’, così raro eppure inevitabile di fronte a simili magnificenze. La cosa meravigliosa è che il disco continua a crescere ascolto dopo ascolto, inesorabilmente.
Emozione vera.