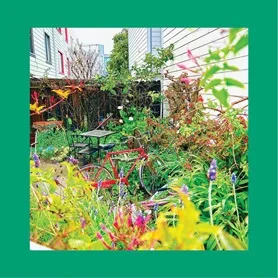Arrivati alla fatidica prova del terzo album, gli Algiers sembrano non voler arretrare un millimetro dall’indomita attitudine che ne ha caratterizzato la proposta musicale e concettuale sin dai primi momenti di vita.
L’insolita e riuscita miscela di distopia sonora “bianca” e sanguigno pathos “nero” qui sembra produrre, stando ai primi ascolti, i pezzi più afferrabili ma anche i più brucianti mai partoriti dalla penna del quartetto anglo-americano.
Con l’apertura affidata dalla title-track ci si trova subito nel centro di un’arena cybetronica costruita sulle rovine di questi miagolanti anni 20, cavalcando una bomba
Synth-gospel-punk che non lascia superstiti sul campo.
Mano a mano che ci si addentra nella scaletta, ascolto dopo ascolto, si incomincia ad avvertire la densità e l’incupimento ulteriore del sound della band rispetto ai passati lavori, già pregno di umori bui.
Questa vena “gotica” e dolente attraversa tutto l’album e ne costituisce il concept sonoro portante, donando una veste austeramente raffinata a un corpo stravolto e ridotto a un involucro di asfittici detriti psichico-organici e industriali, ma ancora sanguinante caldissimo plasma nero.
I contenuti socio-politici della band sono poi sempre centrali e mai banalmente ideologicizzati.
Il singolo “Dispossession” lascia a tratti un po’ spiazzati per la sua fisionomia abbastanza convenzionale rispetto a ciò a cui ci hanno abituati i Nostri.
Meglio del combat-gospel che ne costituisce il sottofondo musicale, fanno le parole declamate con la solita grondante passione di Franklin Fisher, che sputano visioni di apocalittica contemporaneità e incursioni in astrattismi dal vago sapore mistico.
Usciti fuori dalle atmosfere tutto sommato meditabonde del singolo inizia il vero viaggio all’interno del disco e i quattro non ne sbagliano una. L’impressione gettata sull’ascoltatore è quella di essere chiamati ad una continua guerriglia dell’anima, travolta in un tunnel di spettri capitalistici e infernali, in corsa verso la fioca luce della salvazione.
Pezzi darkissimi come “Hour of the Furnaces”, “Unoccupied” e “We Can’t Be Found” srotolano synth anneriti sulle macerie di un Armageddon annunciato, mentre “Chaka” è il parto di un Michael Jackson travestito da Black Panther cybernetica drogata di Suicide.
E Quando si pensava di aver toccato l’angolo più remoto di questo bislacco purgatorio, ci pensano i soul-blues distopici delle guardinghe “Losing is Ours” e “Waiting for the Sound” a farci restare intrappolati in un meta-sogno senza scampo, senza possibilità di risveglio.
“Repeating Night” e “Nothing Bloomed” uniscono inferni privati e melodiosità resi attraverso splendide venature soul: si va dalla voglia di ribellione della prima (Don’t forget, it’s us against them/Though we see it going down/We hold our head up high/And we’ll never bow down to their bloody sky) alla rassegnazione introspettiva della seconda (Lost when i found/What I knew was saving grace/Time spirals out/While we separate in space”…We don’t have to tear away what inside is distant/
Everything starts to fade under the weight of silence).
E allora come si può trovare la redenzione, come si può trovare una via per salvare se stessi, e riuscire ad afferrare un’idea che però raccolga anche un po’ di speranza per un mondo attorno sempre più connesso e insieme assolutamente disconnesso? Si può solo attraverso il bieco occhio obliquo della disillusione, prima che un baccanale distruttivo arrivi a fare tabula rasa di tutte le puttanate di un mondo venduto al miglior offerente, o al primo che è passato, per proiettare il madido miraggio di una via d’uscita. E quindi arriva “Void”, brado e scattante punk industriale che non arriva ai 3 minuti e che ci spinge a tutta velocità verso l’ignoto, o verso la liberazione.
A parte lo spiazzante epilogo, l’aspetto complessivo dell’album mostra fattezze che potremmo definire sontuose: ci troviamo insomma al cospetto una band che nel guardarsi indietro, o allo specchio, appare ormai elegantemente sicura dei propri mezzi e del proprio carisma.
La musica degli Algiers non è mera somma di parti apparentemente antitetiche, ma è incentrata sull’idea di “cortocircuito”, di traumatico ribaltamento della prospettiva, perchè proprio da un trauma, nonchè dall’osservazione di una privazione essa proviene. Un cortocircuito come nel concept grafico dell’album, che unisce insieme ordine e stravolgimento grafico/tipografico, caos e rigore modernista, freddezza ed euforia.
“There is No Year” sarà uno dei dischi dell’anno appena iniziato, statene certi.
Credit Foto: Christian Högstedt