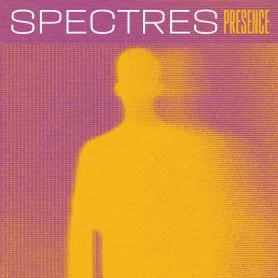Diciamolo, certa stampa non è mai stata carina (per usare un eufemismo) con i Bush di Gavin Rossdale. Non era un fatto personale o una questione di antipatia, nemmeno c’entra che abbiano avuto un clamoroso exploit sin dal debut album “Sixteen Stone”, pubblicato nel 1994.
Di certo, però, molte band emerse al calare del grunge, alcune di queste decisamente fuori tempo massimo (dopo il triste epilogo dei Nirvana, per intenderci), vennero accusate di salire sul carro e di avere poco a che spartire con le ispirazioni (e spesso i tormenti) che caratterizzavano tante figure cardine del movimento. Metteteci poi che il bel Gavin aveva una vocalità molto vicina a quella del compianto Cobain ed ecco che, da qui a passare per dei cloni, il passo fu davvero breve.
Da una parte una folta schiera di detrattori, a volte spietati, dall’altra un’altrettanto nutrita squadra di fans, pronta a far issare il nome dei Bush in cima alle classifiche di Billboard. Già , perchè con il britpop imperante di metà anni ’90, i Nostri avevano poco o nulla da spartire, cosicchè furono in pratica snobbati in patria e innalzati invece al di là dell’Oceano.
Io, come spesso accade, stavo a metà del guado, ero ben conscio che fossero venuti dopo e che mancasse loro un adeguato pedigree per farmeli inserire alla voce grunge, ma allo stesso riconoscevo alcune doti per me sacrosante, al di là del suggestivo cantato di Rossdale. Le canzoni dei primi due album (dopo l’esordio, fece altrettanto successo “Razorblade Suitcase” nel 1996) avevano la loro forza, indubbio fascino, ed erano caratterizzate spesso e volentieri da ritornelli magari non originalissimi ma di certo ficcanti, ariosi e che ti rimanevano in testa (sfido chiunque a dire il contrario riguardo a “Glycerine”, “Little Things” o “Swallowed”). Per non dire della musica, imperniata sulla chitarra del co-fondatore Nigel Pulsford e sulla batteria del portentoso Robin Goodridge.
Tanto clamore per un fuoco di paglia, visto che i Bush, pur continuando a pubblicare regolarmente – almeno dopo la crisi di inizio millennio, per cui passarono dieci anni tra “Golden State” (2001) e “The Sea of Memories” (2011) -, persero repentinamente smalto e consensi. Il nome di Rossdale rimase in auge più volte per motivi extra musicali che per altro, ma in realtà la musica rimase sempre il suo primo amore.
I Bush almeno per voce del suo leader (rimasto nel frattempo unico membro originario) erano pronti a dare battaglia, sfoderando i muscoli dopo il ben poco convincente “Black and White Rainbows”, ultimo lavoro pubblicato tre anni fa. Tradotto alla prova del campo, però, c’è da dire che il nuovo “The Kingdom” è riuscito solo in parte a realizzare gli ambiziosi proclami.
Ballava da un anno questo disco, a cui il gruppo ha nel frattempo aggiunto titoli, oltre che cambiarne quello originale, e l’attesa (mitigata dall’uscita del singolo “Bullet Holes”, inserito un anno prima nella colonna sonora di “John Wick 3”) è stata ripagata da una sorta di concept che non sembra a un primo ascolto lasciare molte concessioni al mainstream, eccezion fatta per la traccia iniziale, la melodica e pompata “Flowers on a Grave”, dai toni sinistri. Il relativo video, in cui Rossdale appare bene in forma, ci dà modo di fraternizzare con il nuovo arrivato Nik Hughes, il cui stile alla batteria differisce non poco da quello di Goodridge, facendo confluire il sound in territori metal; il chitarrista Chris Traynor e il bassista Corey Britz sono in organico da molto più tempo ma mai come in questo lavoro si sente forte la mano del primo, a rilasciare potenti riff ovunque.
La title track segue musicalmente le coordinate stilistiche del brano d’apertura, e saranno principalmente i suoni duri e obliqui a caratterizzare l’intero lavoro, con sporadiche escursioni nell’emisfero nirvaniano (ad esempio in “Ghosts In The Machine” o nella scheggia impazzita “Crossroads”).
E’ da ritenere più apprezzabile la versione intimista della band, visibile tra le pieghe dell’oscura ballad “Undone” (miglior brano del lotto) e nei contorni indie-rock della conclusiva “Falling Away”, mentre non convince del tutto l’irrobustimento delle trame musicali, che vanno ad appesantire il tutto, finanche talvolta a soffocarne le buone intenzioni, come accade nell’intensa “Blood River” o nella comunque suggestiva “Our Time Will Come”.
“The Kingdom” è un album che molto probabilmente renderà meglio dal vivo ma che, al momento, non merita gli venga attribuito più della sufficienza.
Nota di demerito per la copertina, una delle più insulse della storia del rock!