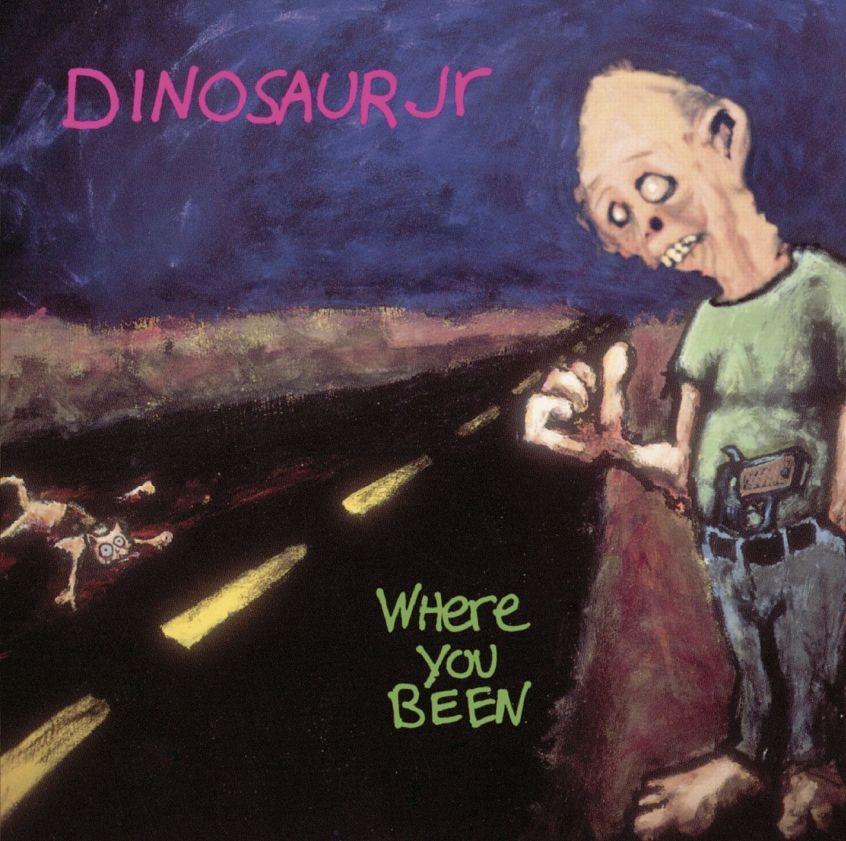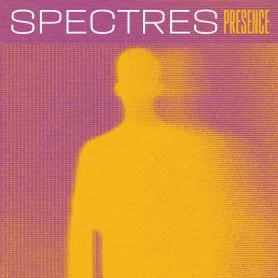Con un un pò più di tempo del solito rispetto alle precedenti uscite, da quando insomma il trio si è riformato nella formazione iniziale, siamo ancora qui a sperare che nulla sia cambiato, che la favola che accompagna i Dinosaur jr e i nostri destini sia immutata, banalmente se le alterne vicende, il fato ingrato, cose come questa pandemia stremante abbiano leso lo spirito di questo connubio inscindibile.
Mentre scrivo queste righe sto ascoltando “To be waiting”, quarto brano di questo “Sweep it into space” e credo fermamente che anche per questo giro non ce ne sia per nessuno, le vibrazioni rimangono invariate, sopravvivono quei momenti di variabile durata all’interno del brano dove il combinato disposto fra il languido cantato di Mascis, l’impasto delle taglienti chitarre e il drumming di Murph fanno alzare le orecchie, girare la testa, ti portano via in un romanticismo indie tuttora insuperato e credo insuperabile. Succede qui in questa canzone, in “Hide another round”, in “I expect it always”, le migliori del gruppo, ma tutto l’album (ad eccezione forse dell’esperimento di “Take it back,” controverso tentativo di introdurre anche una linea di mellotron, sembrano quasi la Band e c’azzecca poco col resto) si pone a livelli molto alti, più amalgamato del pur buono precedente “Give a glimpse of what yer not”, una coesione e una maggiore ispirazione a cui forse lo stato pandemico e pare anche il contributo di Kurt Vile in cabina di regia hanno fatto emergere.
Ma alla fine, al di là di piccole variazioni da disco a disco, noi esigiamo proprio questo dai Dinosaur jr, una fedeltà a se stessi, il perpetrare quello che sanno fare meglio, restare vivi e vegeti per farci sentire ancora parte della scena, ora che la scena non c’è più o meglio non la riconosciamo più: quella cosa nata a fine anni ’80, la nascita dell’alternative rock, il permanere dentro i solchi comunque canonici di un certo tipo di produzione musicale fuori dai circuiti, giocando a suonare, vivere e portare avanti un’idea di musica personalissima e disturbante, perchè così potenzialmente vicina a entrare nel maggior numero di case possibili, ma anche così tremendamente ed irrimediabilmente con poco appeal per avere diritto al successo. Non fosse anche che per la nota indifferenza verso qualsiasi creazione di una invitante immagine esterna, quando invece emerge un’idea di mollezza, di trasandato come forma mentis, il mascherarsi dietro una vita “normale” fatta di cose incredibilmente semplici e mai protese verso la fama, tutto socchiuso dentro la più indolente provincia americana, tutto così gelosamente da noi difeso come uno dei pochi ultimi baluardi della nostra appartenenza.
Non ci fermeremo mai di amare questi 3 slackers, questi portatori della verità nascosta, che rifanno da 30 anni più o meno lo stesso disco, che ci insegnano implicitamente il piacere del ritrovarsi come se ogni loro produzione fosse una rimpatriata fra amici di vecchia data: ed è per questo che forse la storia oramai dei DJ sta diventando sempre più miracolosa e ineguagliabile, mi vengono in mente i REM che per 30 anni hanno tenuto la barra dritta di fronte, loro sì, ad un successo planetario, per poi, a dire il vero, cedere nella qualità delle loro ultime uscite, ma insomma il paragone ci sta: Mascis che chiama Lou, lui che sta preparando il suo album solista , dà i soliti due pezzi al gruppo (questa cosa dei soliti due pezzi di Barlow dentro ogni disco dei DJ ha un che di contrattuale ma è tipico dell’universo DJ), chiamano Murph che dormiva sul divano, si trovano a fare skate, poi chissà , fino a che entrano in studio.
Al solito anche qui in “Sweep it into space” la sensazione è che a Mascis le canzoni escano come dei fluidi, in una eterna condizione narcolettica di una riconoscibilità empatica ed ogni volta emozionante, liriche ristrette, quattro versi ermetici su percezioni di rapporti, di relazioni, riflessioni sul personale, a volte col piglio della ballata, a volte col riff di una chitarra divina, Lou lo soccorre e ci va sopra, Murph accelera, parte il riff ed il gioco è fatto: ecco, da 30 anni succede questo, ogni volta celebriamo qualcosa di più grande di queste parole, una ripetizione religiosa che ha dei momenti di sacro gral del rock, non per tutti, ma meglio così, tanto a Lou, J e Murph, ma soprattutto a noi ce ne fregherà mai niente.
Voglio dire, quando mai nascerà più un gruppo come i Dinosaur Jr, non se ne vedono all’orizzonte, anche se forse è solo un riflesso nostro, di chi è cresciuto con questa roba qui, camerette e finestrini abbassati ad ascoltare gli Husker du, i Pixies, ma anche i Cure, musica forte e sotterranea, musica come rifugio, come tempio dove trovare la propria salvezza, un porto di coincisione di punti di contatto che ha a che fare forse col generazionale, fatto da un microcosmo di fruizione e di immaginario che non esistono di più tanto che quasi pagherei affinchè ci fossero ancora in giro altri personaggi capaci di aggregare in questo modo povere anime sensibili, capaci di far girare la giornata, il presente, insomma quasi tutto, con quelle melodie sghembe che hanno le canzoni di Barlow, ogni volta sfuggenti, ogni volta ti cullano senza sapere dove ti portano, col semplice twist di un falsetto di J che guarda la luna e dondola, come un teenager fuori quota dalle spalle pesanti in un difficile, ma naturale equilibrio umorale.
Credit Foto: Cara Totman