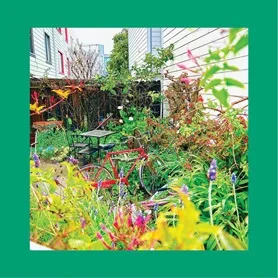Ritornare all’essenza, partire da qui per andare avanti, si saranno detti Brett Anderson e soci alle prese col nuovo album che sicuramente è un punto di arrivo obbligato dalle riflessioni imposte dalla pandemia, ma è un risultato laborioso e composito, non esplicito, che si inserisce alla perfezione all’interno della carriera degli Suede che avevano bisogno di ritornare a proporre qualcosa che si avvicinasse maggiormente ai loro esordi, per rinvigorire lo spirito degli albori e contemporaneamente appunto uscire dopo questo periodo buio con rinnovata energia.
“Autofiction” centra questi intenti, riuscendo a conquistare subito con la sua urgenza, il suo carattere dirompente, il ritmo dentro e fra le canzoni, come fosse una splendida cavalcata glam di risveglio delle emozioni, un contenitore brillante di quasi tutte hit, da cantare e portarci addosso in questo inverno, da accarezzare e tenerci stretto, come suggerisce il leader di spalle nella struggente copertina.
Ecco, al solito Anderson indulge frequentemente nel giocare con il romanticismo, a volte struggente del ricordo della madre come la toccante iniziale “She leads me on”, a volte rinsalda i cuori con il lirismo a getto tipico del suo repertorio un pò ovunque diffuso, come se giocasse all’eterno dandysmo adolescenziale, ma siccome questo gioco da solo non sta in piedi, bisognava sostenerlo con suoni forti e puri che neanche il rimpianto ex chitarrista Bernard Butler avrebbe forse potuto intravvedere in questo 2022: “Autofiction” scuote con la frequenza da KO dei primi album degli Strokes, con martellate brevi e concise di un glam grezzo dal fortissimo impatto live tanto che in più occasioni si sentono rumori da soundcheck in corso o chiusure tagliate dei pezzi, con in più deviazioni in ambiti post punk, che mutano il sound alt rock in territori simili ai migliori Horrors, per dire.
Il risultato è un disco che, al netto di un paio di episodi di fisiologico calo, è la migliore cosa che questo gruppo potesse fare oggi in 30 anni di carriera, una sorta appunto di auto narrazione che ha a che fare con una sincera volontà di analisi dell’esigenza di questa musica, di un romanticismo esteticamente debordante certo, che si discosta da quello sanguigno ad esempio dell’ultimo notevole Afghan Whigs, per sfoderare invece un’altrettanto forte appartenenza sul filo dell’idealizzazione, non meno potente, non meno importante di cui gli Suede sono sempre stati alfieri.
Anderson riesce a scolpire in modo conciso e diretto il suo universo composto di amori dolorosi, cuori infranti, riuscendo plasticamente a farci entrare come se diventassimo anche noi degli di heartbreakers che vivono nelle oscurità (“Oh, they stay in shadows, all the heartbreakers/Oh, they stay in shadows, all the troublemakers/
It’s always the quiet ones”), custodi lui e noi di questo feeling di desiderio in uno spirito ecumenico di immutata stimatissima potenza; si trova in queste canzoni una estrema facilità di connessione con il sentimento puro di scoperta e disagio, con l’ebbrezza dolceamara delle delusioni e delle gioie, in un modo apparentemente naive, oltremodo utilizzato, ma che solo a tale carismatica personalità viene concessa, in virtù del primo articolo della musica rock per cui le contraddizioni sono alla base del successo, una specie di linfa vitale. Anderson tutto questo lo manifesta sfoderando una straordinaria performance vocale, unendo pensieri e ugola di un ragazzino, il timbro invariato, alternando falsetti, cori e chiaro/scuri con un pathos unico, inconfondibile che si stacca ancor oggi dalla stragrande maggioranza dei coetanei e non solo.
A ben vedere quindi, “Autofiction” è talmente coeso e sfrontato, da rimanere quasi un pò fuori moda, da rock pre millennium, forse anacronistico, forse desueto, ma ancora una volta necessario, perchè se gli Suede sono in forma è sinonimo di conforto generalizzato, stiamo tutti bene.