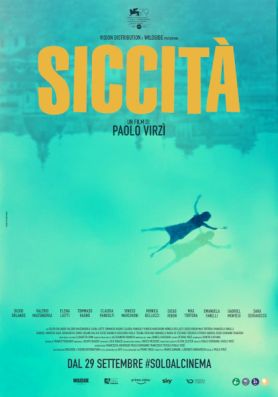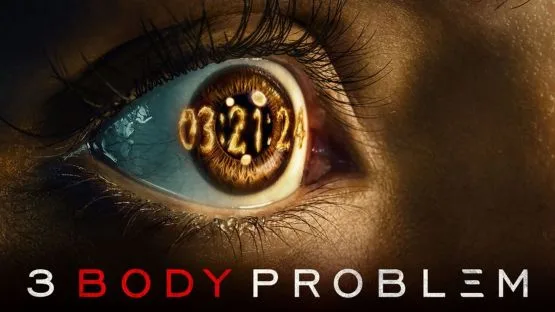A cura di Koc
Se siete dei cinefili non più giovanissimi, guardando “Siccità ” di Paolo Virzì potrà accadervi quanto successo a me. Sono rimasto rapito dalla trama del film per tutta la prima ora, poi ““ però – ho ricordato una cosa e la magia è in gran parte svanita.
Ma andiamo con ordine. Roma, ai giorni nostri: non piove da tre anni e la situazione è naturalmente grave. In mezzo ai disordini e al caos dato dalla corsa all’approvvigionamento, iniziano a comparire tutta una serie di personaggi le cui vite non sono o non sembrano essere correlate. Intanto sono da sottolineare la concreta prova attoriale dei vari interpreti (su tutti Silvio Orlando) e una regia molto “americana” ““ belli gli effetti speciali che mostrano il Tevere completamente asciutto ““ che, insieme, coinvolgono lo spettatore nella storia fin dall’inizio. E’ un film corale, dove tutte le figure che appaiono, dalle maggiori a quelle di contorno, cercano di emergere: in una città senz’acqua la gente pare letteralmente affogare nei propri problemi.
La siccità è un fattore che acuisce le percezioni, ma non è la protagonista del film. La stessa Roma, colta nei suoi aspetti decadenti, è già oggi così, pur con il suo fiume ancora pieno. Astutamente, Virzì riesce a togliere il disastro naturale dal primo piano, anche perchè l’interruzione dell’erogazione dell’acqua è imminente ma non è ancora avvenuta. Nel frattempo, tra tante persone che sgomitano per affermare la propria esistenza, vediamo gli scarafaggi ““ ormai tantissimi – che ad ogni inquadratura si affannano per sparire dalla vista degli umani e dallo schermo. Ho pensato ad una potente metafora: solo più avanti ho scoperto come gli stessi facessero parte della narrazione a tutti gli effetti.
Sebbene la sceneggiatura sia efficace nell’evidenziare le sfaccettature della personalità dei singoli, ogni tanto la descrizione scade nel manicheo: la TV è sempre cattiva, concentrata sul sensazionalismo o sul fenomeno del momento; fenomeno che è pronto ad essere accantonato se emerge qualcosa di più allettante. Oppure il leader politico del centrosinistra, uno dei vari fantasmi che si materializzano nell’auto di Loris (Valerio Mastrandrea), invariabilmente moscio e ipocritamente inclusivo.
Arriviamo a metà film, con la sensazione di qualcosa davvero ben costruito e recitato, ma da qui in poi le cose non mi hanno più convinto tanto. Innanzitutto, scopriamo che gli scarafaggi sono portatori di una nuova pandemia: il regista, infatti, la usa come escamotage per incrociare le storie dei vari personaggi, e farne ritrovare alcuni all’ospedale è stata la soluzione. Ma c’era bisogno di aggiungere alla siccità un’altra sciagura di questi anni?
In realtà la nuova epidemia è un altro degli elementi del caso che si abbattono sulle vite dei protagonisti: lo stesso caso che li fa incontrare, talvolta per pochi secondi e in modo occasionale, talvolta facendoli scontrare, con effetti alternativamente devastanti o salvifici. E qui mi si è sbloccato un ricordo: il tema degli sconosciuti che incrociano le proprie vite (o i cui rapporti sono a noi sconosciuti) è davvero somigliante a quello usato in “Crash ““ Contatto Fisico”, film del 2004 di Paul Haggis, così come si ripete l’idea del destino beffardo: per il film italiano vedasi la morte in acqua in una Roma completamente in secca. Mi è parso poco originale e pure poco originale mi è sembrata la chiusura, con tante vicende che rimangono aperte ma che vengono riunite tutte nel finale sotto una piuttosto scontata pioggia torrenziale, che va a concludere un film ben impostato ma non perfetto.
Per carità , rimane apprezzabile il tentativo: credo Virzì abbia voluto tastare il polso degli italiani dopo due anni di caos pandemico. Secondo me l’espediente della crisi idrica in sostituzione al Covid era ideale e sufficiente. Così, invece, il motivo della siccità è rimasto un po’ a secco.