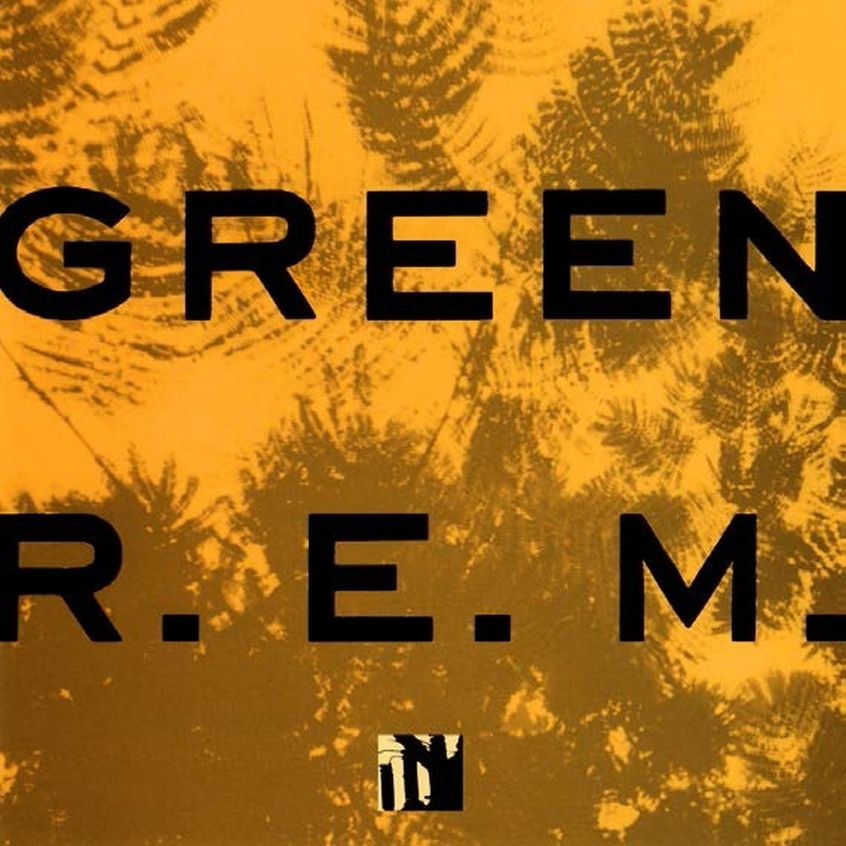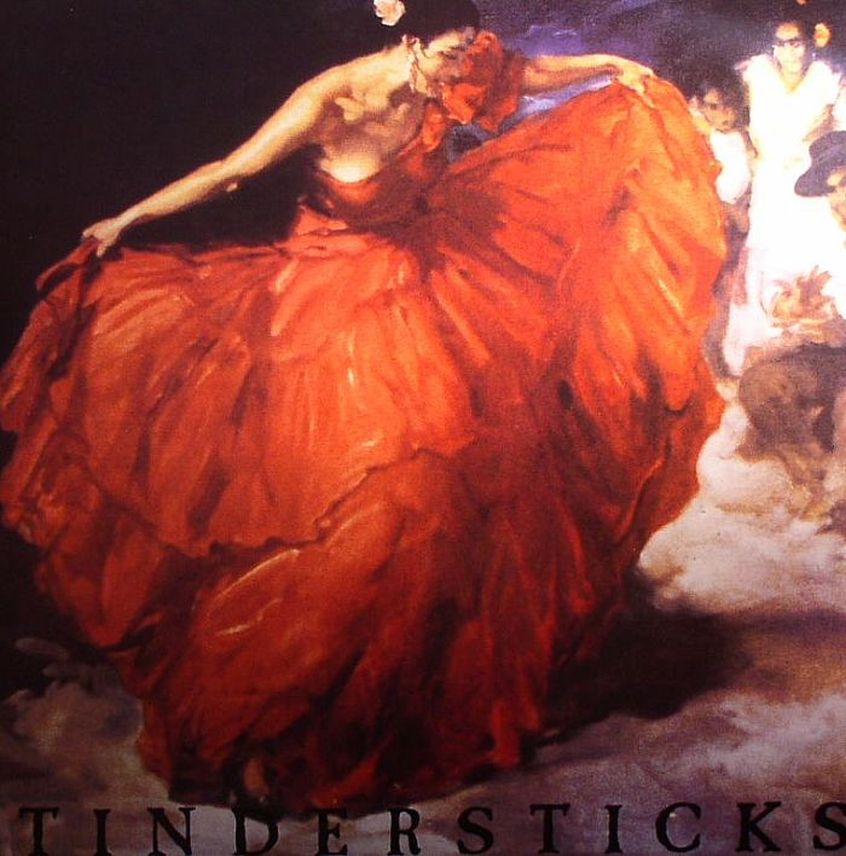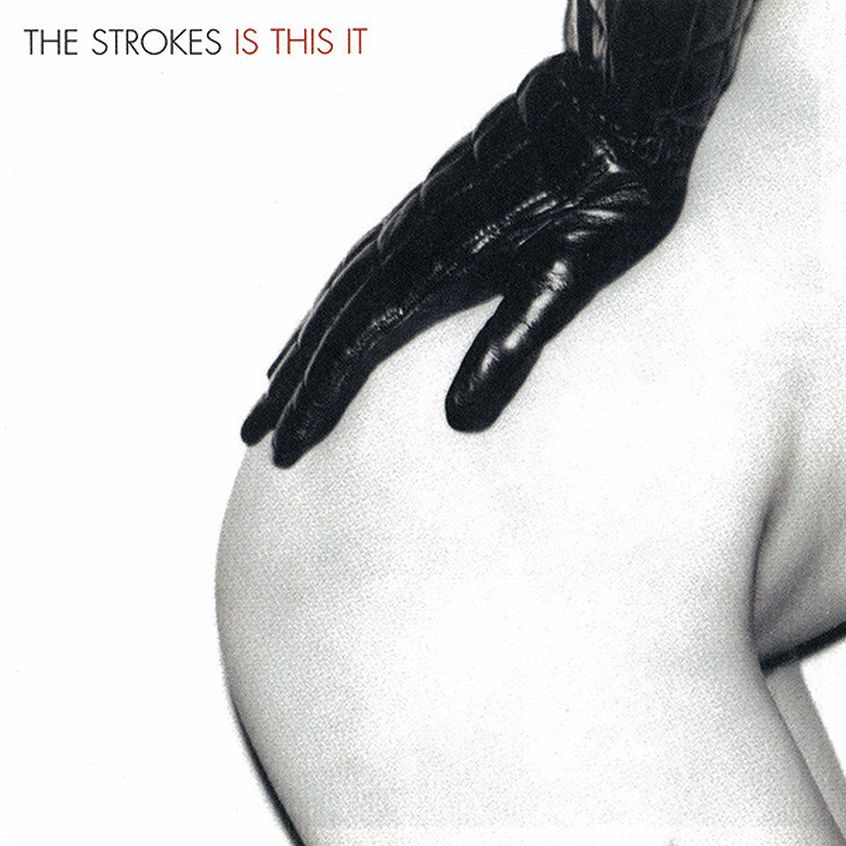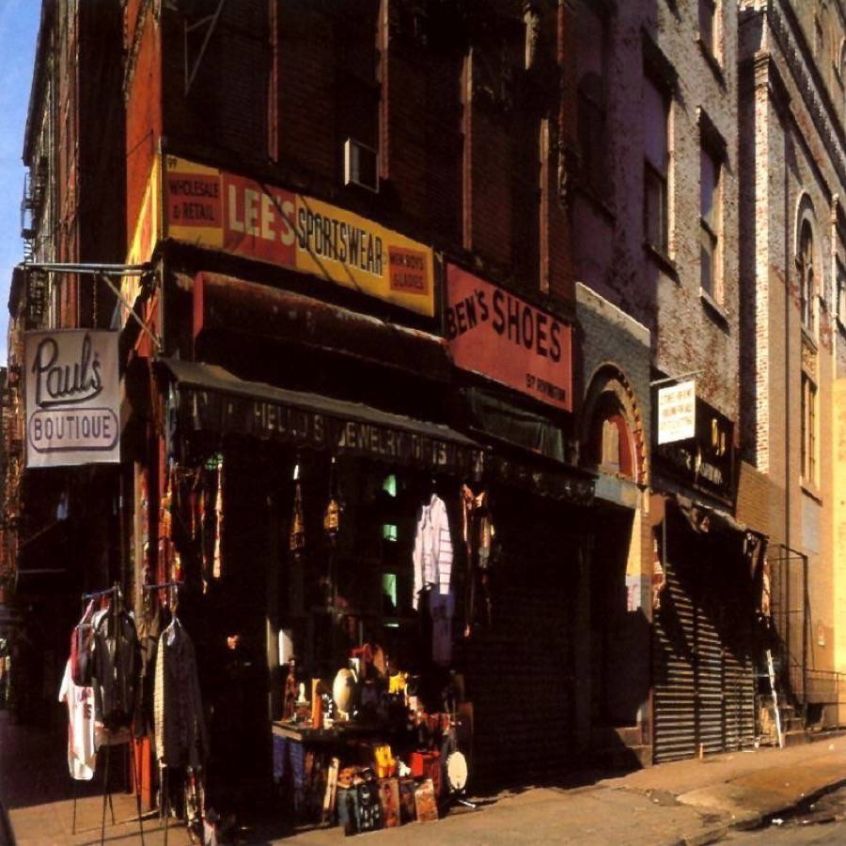Non avevo nemmeno 16 anni quando “13” uscì sul mercato.
Ricordo nitidamente i giorni precedenti a questa pubblicazione: il fenomeno britpop aveva ancora una cassa di risonanza nonostante i venti cominciassero a farsi agitati, tant’è che non c’era l’hype che qualche anno prima aveva contraddistinto l’attesa di “The Great Escape”, ma più una curiosità dovuta anche al fatto che i Blur erano ancora – almeno concettualmente- gli antagonisti degli Oasis, in quella che era soltanto una delle tante sfide dicotomiche oggetto di discussione continua in quegli anni. Non che ci fossero necessariamente buoni o cattivi, heel o face, la questione era più di stile che di contenuti: gli Oasis erano l’impatto scenico, la spavalderia, indisciplinati, quanto eleganti nei loro super ritornelli; i Blur l’irriverenza, il sarcasmo, accattivanti, freschi e trascinanti.
E se “Be Here Now”, seppur qualitativamente inferiore ai precedenti capitoli di casa Gallagher aveva confermato nei crismi quanto sopra, l’omonimo album dei Blur del 1997 aveva già fatto intendere che Albarn e soci potessero deviare per altre strade, staccandosi dal gruppo per cercare nuove traiettorie.
“13”, in questo senso, ne sarà la conferma più concreta.
E cadere nel fraintendimento sarebbe pure facile, perchè poche settimane prima dell’uscita dell’album comincia a girare in heavy rotation il super singolo “Tender”: un inno gospel e folk, intimo ma magniloquente, che vola subito in cima alla UK Chart (secondo dietro soltanto a “…Baby One More Time” di Britney Spears, sigh) e che più che di rotta sembra più un semplice cambio di direzione teso a spaziare nell’alveo creativo del songwriting chitarra in braccio, influenzato da sentimenti personali ed interiori (la canzone, come gran parte dell’album, è ispirata dalla rottura tra Albarn e Justine Frischmann delle Elastica); questa sensazione viene peraltro rafforzata dalle successive tracce dell’album, che nel mentre è uscito sul mercato: se “Bugman” ha tutti i connotati di una “Song 2” più corrosiva e fuori controllo, “Coffee & Tv” è una ballata che sembra studiata, al netto dell’assolo acido di Coxon, per il passaggio radiofonico e diventerà uno dei brani (aiutato da un video che ha fatto anch’esso storia) più canticchiati dell’anno.
Ma già dalla traccia successiva, ecco la sterzata netta, l’uscita completa dal seminato, la rivoluzione della quale già il precedente eponimo album di due anni prima aveva mandato un’avvisaglia: i Blur irriverenti e scanzonati dell’era britpop, si sono staccati dalla flotta.
Sarà che l’album è profondamente Justine-centrico e quindi contagiato da quello che una storia d’amore finita porta con sè, sarà il tocco elettronico e sovvertitore di William Orbit chiamato in cabina di produzione, sarà la registrazione tra Londra e l’Islanda con il relativo effetto ambientale spiazzante ed estraniante, sarà che – soprattutto in Albarn e Coxon – la voglia di creare in proprio e non sotto l’ombrello Blur si stesse facendo più urgente, ma il resto dell’album smonta, ribalta, addirittura delude le aspettative di chi si aspettava un album di matrice brit rock con i requisiti già sopra descritti e che avevano fatto conoscere, ed amare, il gruppo inglese.
Lo stato di confusione, disorientamento e disordine, come a scombussolare i nostri credo, ci viene subito trasmesso dalle successive “Swamp Song” con il suo noise conturbante e disturbato, “1992” col suo lento macabro e desolato prima, tempestoso ed alieno nel finale, “B.L.U.R.E.M.I.” e quel punk lo-fi sconclusionato e graffiato da sintetizzatori, vocoder, autotune, o ancora dai bassi profondi e ruvidi della lunga e perturbata “Battle”.
Fu difficile, almeno per me, comprendere al tempo questo passaggio fondamentale che ad oggi è invece molto più chiaro: i Blur non stavano più cercando la l’effetto, la melodia, il motivo caratteristiche tipo della prima produzione (e del britpop tutto), ma stavano lavorando sull‘effetto, sulla melodia, sul motivo: li stavano smontando, rimontando, amputando, piegando, pure evitando. Stavano creando con la materia, stavano sperimentando. Più per loro, seguendo le proprie pulsioni, che per avere un prodotto popular.
Il disegno è ancora più nitido con le successive tracce: la meno stordente ma pur sempre nevrotica “Mellow” col suo sitar, l’incursione nelle galassie underground e trip-hop di “Trailerpark” ed il suo strascico di chitarra minacciosa ed oscura, la sedativa “Caramel” con il suo finale tribale, drogato, decostruito e quel colpo di coda techno-rock, il breakbeat folk di “Trimm Trabb” che deraglia nel caos e nel rumore, snervante, contorto, a tratti indecifrabile.
Fino al vero diamante grezzo dell’album, “No Distance Left To Run”: un blues stremato, una ninnananna affranta e disperata che ci riporta però su frequenze umane, lucide, con quel coro angelico e il falsetto di Albarn a chiudere la storia e dare la buonanotte, dove la strumentale “Optigan 1” suona difatti come un più sereno risveglio dato dai suoni di campanelli ed operetta. La fine della storia con Justine, verrebbe da dire: o più universalmente, quella dei Blur con gli anni 90 e col britpop. Perchè da “13” in poi, le cose non sarebbero state più lo stesse, e ad oggi abbiamo la fortuna di essere cronisti di quello che Albarn, più che gli altri componenti, sta creando all’interno della scena musicale inglese e non solo.
“13” raggiungerà la vetta della UK Chart e della European Chart, e sarà numero 1 anche in Irlanda e Norvegia, disco d’oro in Canada, platino nel Regno Unito, Giappone e Nuova Zelanda.
Un disco che, anche e soprattutto ad oggi, risulta terribilmente moderno.
Blur – 13
Data di pubblicazione: 15 Marzo 1999
Tracce: 13
Lunghezza: 64:09
Etichetta: Food Records/Parlophone (Emi)
Produttori: William Orbit
Tracklist:
1. Tender
2. Bugman
3. Coffee & TV
4. Swamp Song
5. 1992
6. B.L.U.R.E.M.I.
7. Battle
8. Mellow Song
9. Trailerpark
10. Caramel
11. Trimm Trabb
12. No Distance Left to Run
13. Optigan 1