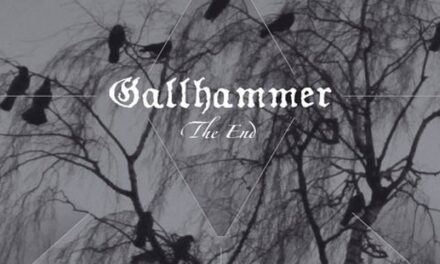Mark Kozelek non realizza più album, ma audiolibri. Interminabili audiolibri nei quali declama qualsiasi cosa gli passi per la testa, trascinando le parole con l’aplomb di un narratore brontolone che è appena stato tirato giù dal letto. La musica resta all’angolino, ridotta a semplice sottofondo sul quale l’ex leader dei Red House Painters recita straripanti monologhi su argomenti che vanno dal tanfo dei bagni chimici nei festival europei a una breve chiacchierata estemporanea con uno sconosciuto a bordo di un SUV a Buffalo. Da quando ha deciso di aprire i rubinetti della coscienza e lasciarsi sballottare da una corrente di pensieri spesso campati per aria, il cantautore dell’Ohio ha iniziato a farcire di frasi il suo fragile folk intimista fino a trasformarlo in un polpettone difficilmente digeribile.
L’ennesimo capitolo di questa prolissa odissea nella vita di Mark Kozelek raggiunge tali vette di solipsismo e narcisismo da rendere inutile il tentativo di nascondersi dietro il moniker Sun Kil Moon. Un disco talmente tanto peculiare da essere parte indissolubile del suo autore: “Mark Kozelek” è Mark Kozelek, con tutti i suoi pregi e difetti. Gli arpeggi di chitarra ripetuti in loop e le armonizzazioni vocali in stile Crosby, Stills & Nash fanno da contorno davvero poco ingombrante agli ormai tradizionali sermoni chilometrici del nostro, spalmati su brani ad altissimo minutaggio privi di una vera e propria struttura. La sei corde di Kozelek disegna trame complesse e allo stesso tempo delicate, dando vita a un avvolgente folk di grande atmosfera che, per quanto ricco e raffinato, alla lunga farà calare la palpebra anche al più stoico degli ascoltatori.
Volete evitare l’abbiocco? Procuratevi il libretto dei testi (o cercateli su internet) e iniziate a seguire il fumantino songwriter in un (poco) eccitante viaggio nella sua (ancor meno) spericolata vita da star della musica alternativa. In “This Is My Town” il buon Mark, con la verve di un cantastorie sonnacchioso e un po’ stonato, ci aggiorna sui suoi gusti letterari (recentemente ha finito di leggere “La luna è tramontata” di John Steinbeck, adesso vuole iniziare “L’urlo e il furore” di William Faulkner) e televisivi (gli piace guardare “Eastbound and Down” e gli incontri di boxe con Tyson Fury). In “Live In Chicago”, oltre a rimuginare sulla morte di Tom Petty e sulle stragi di Orlando e Las Vegas, ci fa sapere di aver fatto un salto da Wal Mart per comprare arance e banane. “The Mark Kozelek Museum” rende omaggio ad Ariel Pink (se fossimo nel 1975 “sarebbe famoso come David Bowie“) e a Steve Howe, già chitarrista degli Yes, celebrato con un bell’assolo Steve Howe-style. Non è abbastanza? E allora skippate al minuto 6:30 e godetevi un coro degno dei Beach Boys ripetere allo sfinimento diarrhea, diarrhea, diarrhea, diarrhea.
In “My Love For You Is Undying” si riaffaccia un tema ricorrente nel canzoniere kozelekiano: la catena di fast food Panera Bread, al centro di un piccolo scambio di battute tra l’ex Red House Painters e la commessa di una libreria “liberal-vegana” di San Francisco. La tristezza del passato riaffiora in maniera prepotente in “Weed Whacker”: Kozelek si rende conto di essere diventato solo l’ennesimo “tizio che fa musica per Spotify”, non riconosce la propria voce mentre ascolta i Sun Kil Moon in una caffetteria e ci confida che l’ipotesi del pensionamento è più che concreta. Magari potrebbe campare di rendita affittando case. Il testo di “Sublime” (proprio come la band: c’è un riferimento alla morte di Bradley Nowell) è stato scritto con “”‘Tis a Pity She Was a Whore” di Bowie nelle orecchie e un avocado nel microonde. In “soli” cinque minuti fanno la loro comparsa in ordine sparso: la descrizione della poco accogliente camera d’albergo dove sta registrando (It’s like a Hitchcock film in here); la cronaca di un litigio tra un clochard e una salvadoregna fuori il Java Beach Cafè; una manciata di versi nei quali ammette di non sapere come continuare, ma pur di non fermarsi decide di prendere in prestito un paio di battute da 2Pac (!); un’intervista della CNN ad Al Gore in merito alle strane convinzioni di Donald Trump sul cambiamento climatico. A chiudere c’è il fantasma di Bon Scott degli AC/DC che sorvola i cieli di Perth, mentre “il sole tramonta e la nebbia copre la Terra”.
In “Good Nostalgia” scopriamo che a ogni Natale in casa Kozelek si guarda “Shining”; la passione per gli horror trova spazio anche nella successiva “666 Post”, nella quale vengono citati “Rosemary’s Baby” (più precisamente la scena in cui Mia Farrow viene “posseduta” da Satana), “La casa del diavolo” e “Ed Gein ““ Il macellaio di Plainfield”. Non lasciatevi spaventare però: nello stesso brano un Kozelek particolarmente burlone ci regala una filastrocca nonsense (The oranges are yellow, the lemons are green and the cable car goes vroom-vroom) e una serie di imitazioni un po’ imbarazzanti dei versi di papere e gatti. “The Banjo Song” – nonostante il titolo, non c’è alcun banjo: il nostro tiene a farcelo sapere (This is my banjo song, though there’s no banjo in this song at all/In fact, the guitar in this song is a nylon-string guitar made by Yamaha) ““ include un piccolo tributo a New Orleans e ad alcuni suoi nobili figli (Louis Armstrong e Fats Domino, ma anche Lil Wayne e Phil Anselmo). Bella città , ma non ci vivrebbe: l’area paludosa al confine con Ponchatoula è talmente spettrale da fargli tornare in mente la decadente America rurale della prima stagione di “True Detective”.
Il tempo di addentare un Po’ boy (panino tipico della Louisiana) in un locale dove è appesa la foto di un giovane Riddick Bowe – neanche a farlo apposta, il brano in questione si intitola “Young Riddick Bowe” – e siamo di nuovo in strada, diretti verso l’aeroporto di New Orleans. Per uno come Mark Kozelek la notizia della probabile cancellazione del volo di ritorno per San Francisco è un argomento sufficiente per scriverci sopra un pezzo di nove minuti; e allora ecco a voi “I Cried During Wall Street”, una lunga ballata nata nel tedio di una sala d’attesa. Nella mente di un Kozelek annoiato e stanco si affollano immagini e pensieri senza alcun nesso logico: tre gatti randagi incontrati poche ore prima (ci dice anche i nomi: Biscuit, Creampuff e Angryface), una sauna fatta in mattinata, una scena per lui particolarmente toccante di “Wall Street”, il padre ormai anziano al quale prima o poi dovrà dire addio e il compleanno di Muhammad Ali.
Il flusso di coscienza si interrompe con una telefonata di Caroline, la sua fidanzata: ha appena controllato su internet lo stato del volo ed è tutto ok, può finalmente partire e tornare a casa. è il 17 gennaio 2018, canzone e disco sono quasi finiti e Mark si appresta a salutarci. Si accomoda sul suo sedile (se vi interessa è il posto 10D, accanto a un uomo di mezza età in tuta da ginnastica che sta giocando a un videogame), riprende la lettura di “Una banda di idioti” di John Kennedy Toole e, arrivato al capitolo 7, mette il segno e si appisola. Per quest’anno la visita guidata nella testa di Mark Kozelek si ferma qui; le vetrine del museo strabordano di souvenir e cimeli inutili, ma per fortuna qualcosa di buono la si trova sempre.