Grandi celebrazioni in casa Deftones. Si festeggia il ventennale di “White Pony”, disco di una certa importanza che, agli albori del nuovo millennio, diede una svolta cruciale all’evoluzione dell’alternative metal, allontanandolo dal pantano nu in cui lo stavano trascinando i Limp Bizkit per arricchirlo e nobilitarlo con le più disparate influenze. Nel capolavoro di Chino Moreno e compagni è possibile individuare elementi di post-hardcore, shoegaze, new wave e dream pop, uniti tra loro in un prodigioso e rivoluzionario (almeno per l’epoca) esempio di crossover tanto pesante quanto flessibile; uno sforzo di anima e muscoli in costante bilico tra pathos e aggressività . Una vera e propria pietra miliare che ha lasciato un segno importante nei cuori non solo di ascoltatori e critici, ma anche di innumerevoli epigoni che, ancora oggi, provano a riprodurne le caratteristiche.
Non sono da includere in questa cerchia gli artisti contattati dai Deftones per reinterpretare a modo loro le undici tracce del classico datato 2000. Con l’obiettivo di allontanarsi il più possibile dal modello di riferimento, la versione remix di “White Pony” è stata concepita e realizzata non con lo scopo di creare qualcosa di complementare, ma di assolutamente contrastante. Da qui il simpatico titolo “Black Stallion”, che in una sua maniera evoca l’immagine di un gemello cattivo che si oppone al fratello bello, buono e amato da tutti.
E allora, vi chiederete voi, com’è questo doppelgänger elettronico del masterpiece deftonesiano? Diciamo subito che non si tratta di un cavallo vincente. Non sulla lunga corsa, almeno. Perchè la decisione di far revisionare le canzoni a nomi tanto diversi tra loro, per forza di cose, ha portato alla nascita di una bestia che soffre tremendamente sotto il peso di una disorientante eterogeneità . Non fraintendetemi però: non è tanto la natura composita del lavoro a rappresentare un problema. Sarebbe difficile considerare un difetto la presenza di visioni ed elementi differenti in un’operazione di questo genere.
Il fatto è che non tutti i protagonisti coinvolti sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda sul versante dell’ispirazione. E questo riguarda sia chi ha deciso di stravolgere totalmente e rendere irriconoscibili i brani originali, sia chi ha preferito limitarsi a qualche minuscola manipolazione. Nel primo gruppo inserirei la “Feiticeira” di Clams Casino, ridotta a una breve intro dal sapore hip hop, e la “Change (In The House Of Flies)” di Tourist, trasformata in una serena e rilassante “galoppata” digitale che spazza via tutta l’intensità e la potenza drammatica che apparteneva al pezzo.
Nel secondo invece ci mettiamo la “Passenger” di Mike Shinoda, che si becca una non particolarmente brillante rilettura in chiave Linkin Park, e purtroppo anche la “Teenager” rivista e corretta da Robert Smith (sì, proprio quello dei Cure): le uniche differenze rispetto alla versione di “White Pony” stanno nella rimozione della drum machine e nell’aggiunta di suggestivi inserti di pianoforte che, oltre a dare un pizzico di atmosfera in più a questa soffice ballad, non fanno poi molto.
I remix migliori di “Black Stallion” sono quelli in cui, nonostante le modifiche più o meno evidenti, viene lasciata inalterata l’espressività tipica della musica dei Deftones. DJ Shadow regala una veste scarna, sporca e “urbana” a “Digital Bath”, ma non tocca in alcun modo l’interpretazione da brividi di Chino Moreno. Blanck Mass traduce la furia di “Elite” in un inferno electro-industrial estremamente eccitante. Le sottili voci femminili che affiorano tra le note di “Street Carp” (Phantogram) e “Knife Prty” (Purity Ring) infondono un po’ di leggerezza e respiro a tracce originariamente di grande impatto; qui le troviamo rimodellate sotto le forme inedite di un’elettronica tanto elegante quanto sognante.
“Black Stallion”, come era facile immaginarsi, è un’opera fatta di luci e ombre. Un album minore, ricco di aspetti positivi e negativi, che probabilmente riuscirà a incuriosire solo i fan dei Deftones e di “White Pony”. A loro consiglio a tutti i costi di godersi la “Pink Maggit” di Squarepusher, spezzettata e ricomposta in un’entusiasmante cavalcata glitch metal della durata di dieci minuti. Una degna chiusura per un disco coraggioso (nel bene e nel male).





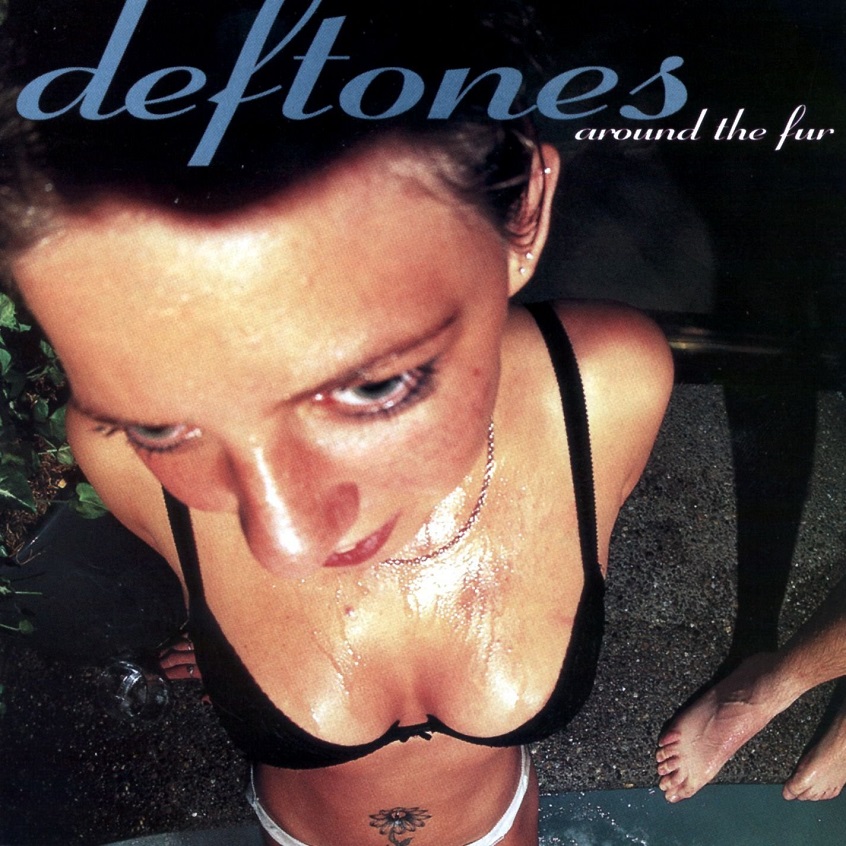






![Betty Davis – Nasty Gal [Ristampa] / Is It Love Or Desire? [Ristampa]](https://www.indieforbunnies.com/wp-content/uploads/2010/02/betty1.jpg)






