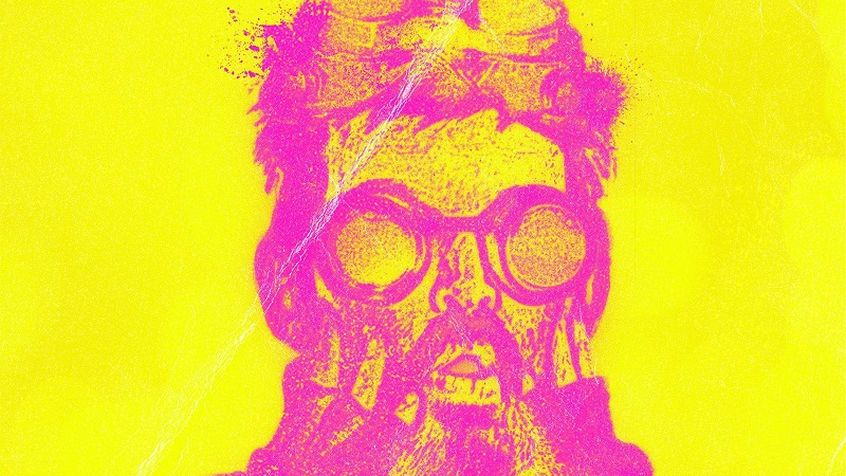Dodici canzoni nuove di zecca per rompere un silenzio che, almeno per quanto riguarda le composizioni originali, si trascinava dal lontanissimo 1999. Con la sua sola pubblicazione “The Zealot Gene”, il ventiduesimo album dei Jethro Tull, si candida a diventare uno dei principali eventi dell’anno in ambito progressive rock. Non che la creatura di Ian Anderson sia mai stata ferma negli ultimi due decenni, anzi: tra tournèe, compilation e release celebrative (ricordiamo, tra le altre cose, le preziosissime edizioni deluxe dei vecchi classici remixati da Steven Wilson), la band ““ ormai, più che altro, one man band – nata a Blackpool nel 1967 è riuscita a concedersi un breve periodo di riposo solo dopo lo scioglimento del 2011.
Una pausa alquanto rigenerante per l’acciaccaticcio Anderson che, rotti definitivamente i rapporti con l’altro ex membro storico Martin Barre, ha ritrovato l’entusiasmo necessario per rivitalizzare i dormienti Jethro Tull e ritagliare loro un nuovo spazio in un mondo ancora tormentato dalla pandemia. Emergenza sanitaria che, è giusto farlo presente, ha complicato e ritardato di molti, molti e molti mesi le registrazioni di un album realizzato in parte in studio, in parte a casa.
I brani elaborati in smart working (tanto per usare un’espressione abusatissima, al giorno d’oggi) sono riconoscibilissimi perchè privi delle parti di batteria di Scott Hammond. Proprio questi ultimi, tutti contraddistinti da una comune radice folk acustica, rappresentano la parte migliore della ricca offerta di “The Zealot Gene”: “Jacob’s Tales”, “Sad City Sisters”, “Where Did Saturday Go?”, “Three Loves, Three” e soprattutto la commovente “In Brief Visitation” colpiscono in maniera particolarmente positiva per la presenza di melodie dalle sfumature assai suggestive, l’inserimento di richiami colti a musiche dal gusto antico e classicheggiante e l’ispirazione di un Anderson che, nonostante le condizioni di salute precarie, riesce a emozionare anche con quel filo di voce che ormai si ritrova.
Il flauto traverso, come da tradizione tulliana, ricopre il ruolo di incontrastato protagonista anche nelle tracce più vicine all’hard rock, molte delle quali purtroppo soffrono per lo scarso peso riservato alla chitarra elettrica di Florian Opahle. Vale però la pena consigliare l’ascolto della title track, di “Barren Beth, Wild Desert John”, della drammatica “Mine Is The Mountain” e dell’avvincente “Shoshana Sleeping”, a mio modesto parere l’episodio migliore di “The Zealot Gene” sul versante puramente prog.
I tempi di “Thick As A Brick” sono lontanissimi: non aspettatevi pezzi da dieci/venti minuti o soluzioni troppo spericolate dal punto di vista tecnico. Le ricercatezze stilistiche ci sono (vedi i sapori barocchi di “The Fisherman Of Ephesus”) ma non occupano un ruolo predominante. Discorso opposto per le tastiere “brillantinate” e dal suono un po’ antiquato del pur bravo John O’Hara, alleato fondamentale per uno Ian Anderson in vena di rispolverare i ricordi degli anni ’80 in una canzone energica come “Mrs. Tibbets”, dal piglio anthemico e dal vaghissimo retrogusto AOR.
Luci e ombre sulla seconda vita dei Jethro Tull: “The Zealot Gene” è un album coraggioso nel suo spaziare tra generi e umori diversi ma purtroppo davvero poco incisivo, poichè incapace di aggiungere alcunchè alla storia del gruppo britannico. Non che ce ne fosse bisogno, d’altronde. Mettiamola così: se volete gustarvi del grandissimo progressive rock dalle tinte folk, andate a recuperare dagli scaffali le vostre copie di “Aqualung” e “Stormwatch”. Altrimenti accontentatevi di questo disco che, nel suo piccolo, sa farsi apprezzare.
Photo Credit: Latam Windsor