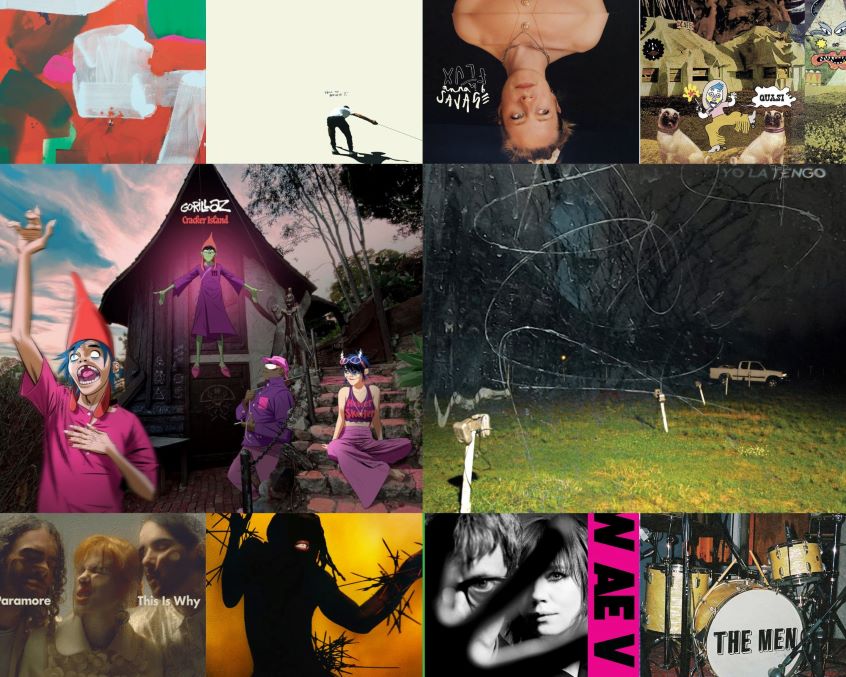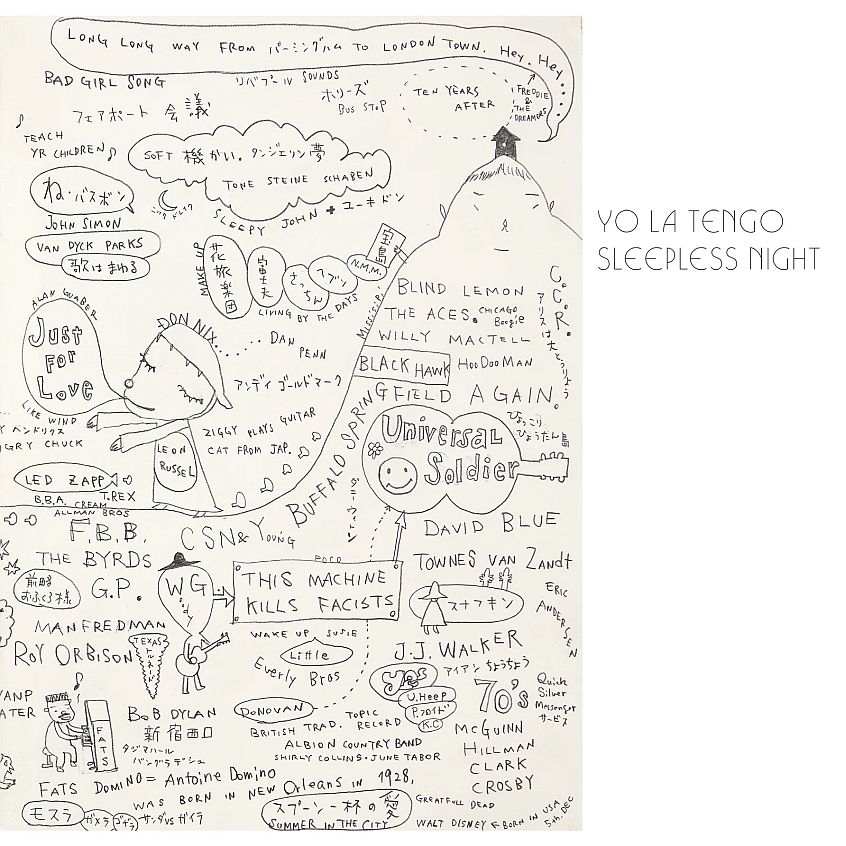Ad ascoltare questa ennesima prova sulla lunga distanza, sembra proprio che l’era pandemica abbia giovato alla qualità del trio newyorkese, alle prese con considerazioni non proprio così lusinghiere verso una realtà meschina, incontrovertibilmente rinunciataria a capire la propria direzione, stupida perché non riesce a cogliere il senso del tempo, come dice l’amarissimo ironico epitaffio del titolo di copertina di questa splendida nuova produzione.

L’album restituisce in un colpo suono i migliori YLT da anni, i soliti temi perfetti, la solita pulizia dei suoni, in un mix riuscitissimo fra abrasione e classicismo, fra durezza e eleganza, noise con dominio della chitarra che rimanda ai Sonic Youth periodo “Washing Machine” (“Sinatra Drive Breakdown”, dove il senso del white noise brilla nella sua forma di ecosistema di appartenenza) ma anche ai MBV meno furiosi (“Fallout”, la perfetta canzone indie, sbilenca nelle accordature, magnifica nell’armonia appena sussurrata), per poi passare a ballad di un candore e naturalezza unici (“Apology Letter”, “Aselestine”): come successo a molte band post covid, anche gli YLT ripartono da dove sono nati, un’intrinseca e solida preparazione concettuale sulla propria posizione nel music business che si traduce in quella amatissima combinazione fra leggerezza bucolica, irridentismo post adolescenziale, isolazionismo intellettuale, il rumore come antitesi della condizione del silenzio per permettere allo scorrere del tempo di attraversare le nostre preoccupazioni in modo più consono.
Se non bastassero le prime due canzoni a esemplificare tutto questo bengodi, si prenda anche la titletrack, 5 minuti di distorsione con ritmo marziale, come se il fantasma del Lou Reed più elettrico si fosse materializzato in sala di registrazione strimpellando “All Tomorrow’s parties”, solenne ed imperiale ma allo stesso tempo con la grazia di una sottostante recita solo enunciata, in cui la calma consapevole delle frasi con cui si sottolineano le briciole di ciò che ci rimane si scontra con le allucinazioni catastrofiche della struttura sonora.
E’ inoltre immediato constatare che rispetto al passato i brani nel loro complesso sono più assimilabili dopo i primi ascolti, vi è una maggior empatia anche in quelli meno diretti e una maggior concisione che rendono “This stupid world” un album decisamente compatto, senza sbavature e sena il bisogno di niente di più o di meno di quello che contiene, frutto evidentemente di mirate ed essenziali sessions in studio che restituiscono una dimensione quasi live nei brani, buona la prima o giù di lì: il trio è riuscito a rinnovare il perenne mood indie così prezioso e identitario, rimanendo fedele alla tradizione ma dando comunque l’idea di nuovo inizio, dove gli elementi classici del suono YLT vengono valorizzati da una maggiore attenzione ai suoni, dal perfetto amalgama dell’interazione fra melodie e musiche, dalla grazia espressiva istantanea.
Ci si lascia così, con un disco che già da ora prevediamo di vedere nelle classifiche di fine anno con una “Miles Away”, struggente ballata elettrica, una ninna nanna dolce e vibrante che sarebbe piaciuta molto ai Low degli ultimi lavori, che esemplifica più di ogni altro discorso la capacità di queste canzoni di rappresentare ciò che di più prezioso e caro possiamo desiderare per interpretare questo presente. La musica come panacea, rifugio in un mondo dove gli amici se ne vanno via, e si rimane lì ingarbugliati nell’attesa di qualcosa che non succederà.
Più di così, difficile volere, soprattutto più di così non bisogna dire, ascoltiamo questa maestria musicale, questo mondo sarà pure stupido ma se va così, teniamocelo stretto stretto.