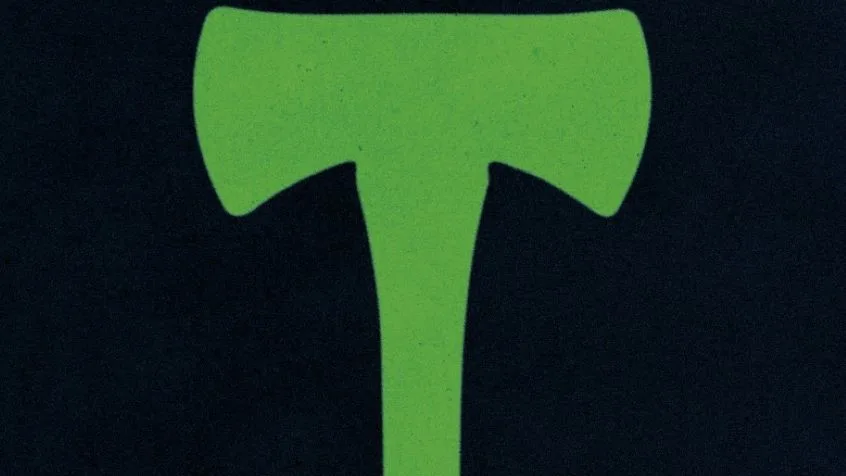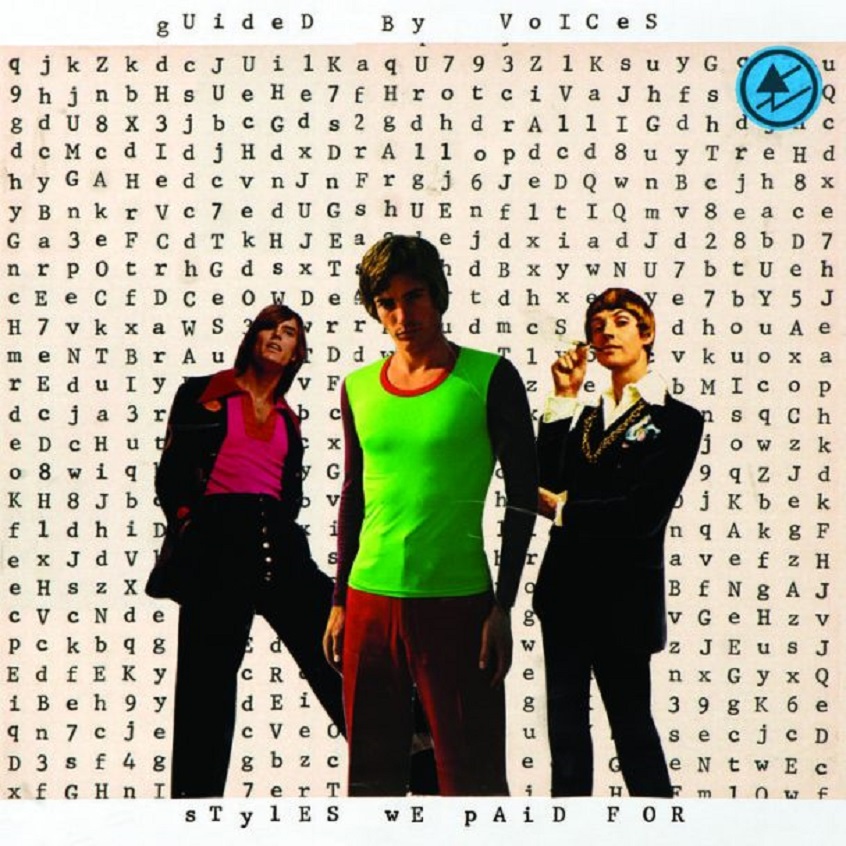Che gli possiamo dire al buon Robert Pollard, uno che solo nel 2020 ha fatto uscire ben tre album a nome Guided By Voices (ormai sempre più una sua emanazione diretta)?
Di certo ci ha saputo accompagnare in questi mesi precari e impervi sfornando canzoni a getto continuo, sfruttando al massimo il lockdown per canalizzare lungo dischi molto omogenei fra loro una sorta di compulsione creativa che da sempre comunque alberga in lui.
Allargando il cerchio direi che tutti e tre sono ben inseribili in un filone indie rock che ha contraddistinto il gruppo dell’Ohio nella sua ormai lunga carriera.
L’ultimo in ordine di arrivo, “Styles We Paid For”, pubblicato un paio di settimane fa, si differenzia solo per il fatto di essere stato scritto e composto interamente quest’anno, quindi non ci sono all’interno ripescaggi o rielaborazioni di vecchie idee. Per il resto, però, poco aggiunge al valore e al percorso di un gruppo che lungo quasi quattro decenni ha saputo declinare in ogni forma il verbo del rock a stelle e strisce.
Nel disco prevalgono i brani mid-tempo, alcuni invero molto brillanti (da “Endless Seafood”, che nelle sue intenzioni dovrebbe richiamare echi prog, a “Never Abandon Ship”, passando per la più cadenzata e sbilenca “Electronic Windows to Nohwhere”) ma non mancano episodi più corposi quali la marziale “Stops” o una “They Don’t Play the Drums Anymore” ammaliante e dai toni ironici.
Altrove è decisamente la melodia a farla da padrone, sia che le tematiche abbraccino contesti universali, con l’utilizzo di ficcanti metafore (nella perentorietà di “Liquid Kid”, forte di un bizzarro arrangiamento nel finale), così come quando si lasciano andare a momenti introspettivi, vedi l’intensa ballad “In Calculus Strategem”.
In ogni caso, anche se spesso sembra che il comandante della truppa guidi col pilota automatico nello sfornare brani che indifferentemente passano da atmosfere country ad altri alt-rock, fino a sfociare nel pop lo-fi (attitudine che permea tutto il lavoro), figurano nel contesto momenti ben ispirati, sin dall’opener in odor di blues urbano “Megaphone Riley”.
A conti fatti, per essere un autore così prolifico Robert Pollard non sembra essersi ancora adagiato sugli allori: per lui la musica è ancora qualcosa di straordinariamente vitale e necessario; certo, magari di questi tre album pubblicati nell’arco di dodici mesi se ne poteva ricavare uno solo di ottimo livello.
Così facendo, invece, si sono un po’ disperse le idee migliori e se devo attenermi soltanto a questo singolo episodio, non si può certo gridare al miracolo, pur riconoscendo la bontà del lavoro.