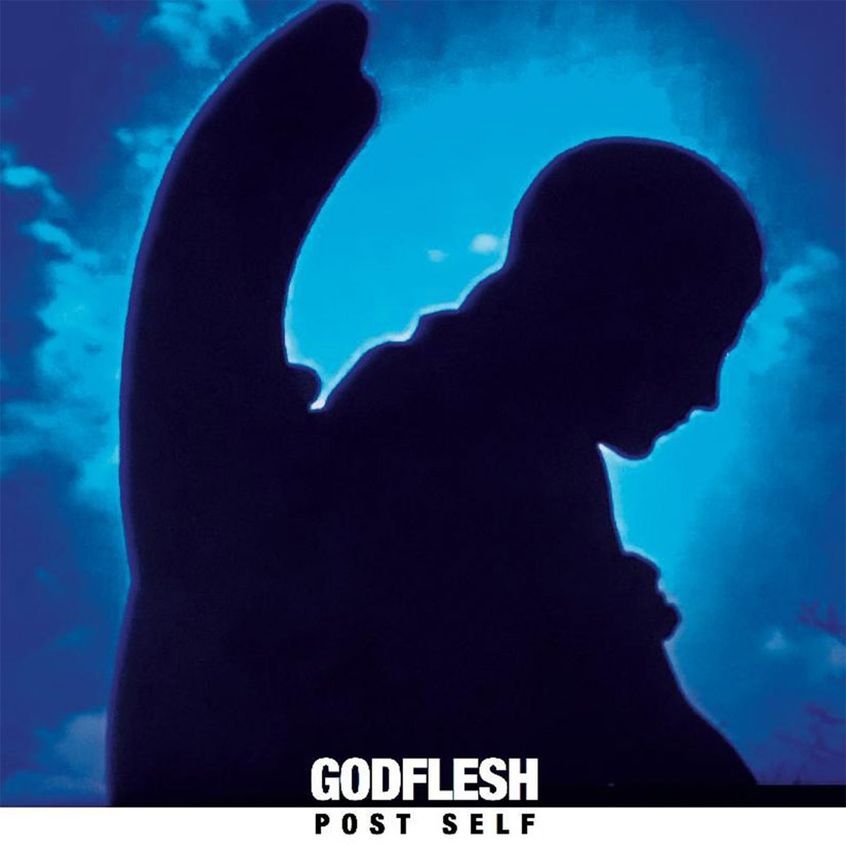di Enrico Sciarrone
Mi capita ancora spesso di vivere visceralmente gli eventi musicali a cui assisto. Non solo l’evento in sé, ma anche tutto quel che precede e segue. Mi piace la fase di approccio e di avvicinamento alla location, quando fantastico o pregusto mentalmente ciò che immagino sarà o che vorrei che fosse.
Quando poi si arriva davanti all’ingresso è sempre un momento particolare. L’impatto con il pubblico in attesa, la ricerca di punti di riferimento, (come lo sguardo complice tra fan, una t-shirt che rimandi epoche e fasti) , delle conferme a conforto delle aspettative o il prendere atto di ciò che non ti aspetteresti. Quel che destava infatti immediatamente all’occhio nel pubblico da grandi occasioni, presente mercoledi all’Alcatraz di Milano per il primo dei due sold out in Italia, per il grande ritorno tanto agognato sulle scene degli Slowdive era la sua straordinaria trasversatilità. Se infatti è legittimo pensare ai Slowdive come ai maestri consacrati di un sound tra i più distintivi degli ultimi 40 anni come lo shoegaze, quindi ad un seguito atto rigorosamente di giovanotti attempati (come il sottoscritto) è un dato di fatto che la loro musica ha catturato negli anni l’immaginazione anche di un’intera nuova generazione di fan che si è approcciato al genere riconoscendo agli stessi Slowdive la loro progenitura. Ecco quindi che via via che mi addentravo all’interno della sala, facendomi largo tra folla, capitava di incrociare non solo i tanti fan della prima ma anche tanti millennials, e-girls, ragazzi hipster con tanto di mamme e papà indie al seguito.
Ecco che diviene quasi consequenziale che ad aprire la serata sia una giovanissima band di supporto i Pale Blue Eyes, evidentemente cresciuti anch’essi a pane e shoegaze, fortemente voluti dalla loro madrina Rachel Goswell, che hanno la ventura di salire sul palco di un Alcatraz, già quasi stracolmo, per presentare il loro ultimo lavoro “This House“ da cui attingono a piene mani per un set live di circa mezz’ora convincente e coinvolgente ricco di energia e di sonorità distorte, quasi a preparare idealmente il terreno per ciò che verrà a breve.
Non serve infatti attendere molto per fortuna, mentre prendi sempre più consapevolezza di non poterti più muovere, sono le note serene di “Deep Blue Day” di Brian Eno, con un sapiente spettacolo di luci psichedelico e uno sfondo a proiettare prominenti immagini caleidoscopiche e geometriche ad accogliere l’ingresso sul palco dei Slowdive, in un clima di attesa emotiva crescente, che i nostri provvedono immediatamente a squarciare con “Shanty”, la traccia di apertura del nuovo lavoro “Everything is Alive “ un
perfetto connubbio tra melodia, elettronica e una fitta nube di chitarre aeree. Potremmo definirlo la traccia madre attorno a cui ruoterà tutto il concerto, parte di un tour promozionale dell’ultima produzione sopracitata del gruppo, arrivata dopo 7 anni dall’ultimo album omonimo ( 2017) da cui la band sembra prendere le distanze per tornare ad un approccio piu’ sintetico e minimale piu’ assimilabile a “Pigmalion” (uscito nel 1995 prima dello scioglimento della band) una sorta di compendio tra un evidente voglia di sperimentazione senza rinunciare ad una matrice pop molto intima, quasi introspettiva legata anche alle vicende personali di alcuni dei membri della band.
Questo però traspare poco durante la performance, la band infatti opta in generale per una sorta di “omogeneità “ della scaletta , un sottile equilibrio tra materiale vecchio e nuovo, pescando dall’ultimo lavoro solo 4 brani piu’ affini alla produzione Slowdive (oltre alla già citata “Shanty”, “Skin in the game”, l’osannato singolo “Kisses”, che ha conquistato il cuore di tutti i
presenti e la salute di qualche malcapitato tra il pubblico e un futuro classico come “Chained to a Cloud”) tralasciando alcuni pezzi piu’ intimi probabilmente per il timore che sarebbero potuti apparire troppo piatti o scarni dal vivo, inclusa “The Stab” formidabile epilogo dell’album, inspiegabilmente tenuta fuori. Sta di fatto che a farla da padrone è la riproposizione di ben 5 brani dal monumentale “Souvlaki” (“40 days” , la struggente “Alison”, “Dagger”, le acclamate con autentiche ovazioni “Souvlaki Space Station” e la meravigliosa “When the Sun Hits”, l’unica ad esser stata cantata in coro da tutti i presenti ) mentre l’omonimo album vede solo 3 episodi riproposti (la magica “Slomo”, “Star Roving” e “Sugar for the Pill”). Tocca a “Catch the breeze” il compito di ridestare il magone, la nostalgia per un esordio tormentato come quello di “Just for a day” del 1991, mentre l’epilogo finale è affidato ad una sorta di porta fortuna per la band che fin dagli esordi ha amato rielaborare, la cover del brano di Syd Barret, “Golden Hair”.
Non mi soffermerò sullo stato di grazia della band, mi piace piuttosto sottolineare un aspetto : il riscontro emotivo dato dal gradimento del pubblico, rimane pur sempre un fattore chiave per tutte le band che approcciano un attività live, (spesso più remunerativa di quella in studio) anche per una navigata come Slowdive, consapevole dei nuovi orientamenti musicali e del percorso di sperimentazione in fase di sviluppo. Mi è sembrato quasi come se il tour fosse anche, e non solo, la ricerca di una conferma, di un feedback della bontà delle scelte intraprese.
Non sarà sfuggito il candore, l’imbarazzo genuino con cui Rachel Goswell, vocalist del gruppo insieme a Neil Halstead, ha accolto con enormi sorrisi e parole di ringraziamento i tributi d’amore, gli abbracci ideali provenienti da un pubblico, che seppur eterogeneo per generazioni, ha saputo dare . Siano essi un’ovazione, un coro, un’esplosione d’applausi o una generata levata di braccia con tanto di iphone in mano, sicuramente quella degli Slowdive è la strada giusta per una band che vuol guardare oltre e non rimanere a specchiarsi sul proprio passato.
Ps: nota di merito anche per i suoni all’ Alcatraz. Io stavo sulla sinistra del palco e devo dire che la resa sonora è stata molto soddisfacente: non ho avuto l’impressione di frastuono o suoni fin troppo “impastati”. Avevo visto la band anche all’aperto, negli spazi dell’ Ypsigrock e temevo che il contesto al chiuso potesse penalizzarli. Niente di tutto questo.