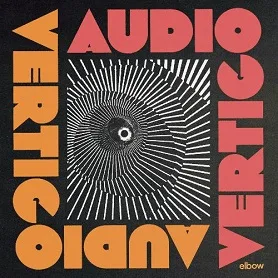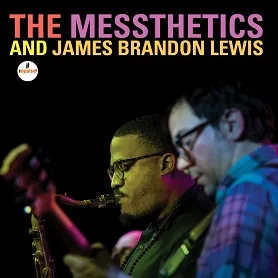Gli Afterhours sono vivi e battono il colpo.
Manuel Agnelli è tipo che si annoia ben presto se fa due volte la stessa cosa e la sua discografia è l’eloquente manifesto di una continua voglia di sperimentazione. Provare, ma, sempre con i piedi ben piantati nel rock’n’roll. E così dopo un album classicamente rock, fatto di canzoni solide con poche cadute di tono, rieccoci di nuovo proiettati in un viaggio straniante, che richiede assoluta attenzione nell’ascolto e poco pregiudizio. L’ammirazione verso chi non sguazza nel terreno del suo piccolo recinto è comunque sconfinata, anche se, come vedremo, il cambiamento richiede assestamento e comprensione.
La prima cosa che risalta all’orecchio è una meravigliosa resa dei suoni, limpidi, potenti, costruiti dando spazio ad ogni strumento senza sovrapposizioni confusionarie, così che pare di essere proiettati in una gigantesca stanza bianca, confortevole, piena di luce e libertà eppure vorace di solitudine. Il disco è una babele di riflessioni, citazioni, rimandi, suggestioni, commistioni di stili e autoreferenzialità , che come filamenti fluorescenti brillano anche dopo il passaggio della cometa. Ci sono sequenze che hanno una eloquenza tragica, votate alla claustrofobia come nella tripletta iniziale, laddove al termine di un duro e fine lavoro di cesellamento Agnelli tira fuori riff di chitarra netti, identificativi, quasi indimenticabili dove spicca tra le altre “E’ Solo Febbre”, istantanea di due occhi impauriti da un’angoscia inspiegabile, che trova la sua calma nel sapiente incastro tra musica e parole.
In “I Milanesi Ammazzano Il Sabato” danzano allegramente il pop circolare dei Beatles, la schizofrenia degli Husker Du, il rock veloce degli Who, le trovate dei Rolling Stones e tutto il cantautorato italiano di classe. A tenere insieme i pezzi è la grande verve poetica di Manuel, in forma più che mai nel seminare testi abrasivi, piccole schegge di luce, ora amare, ora acute come filastrocche nere per bambini insonni, ma sempre attraversate da una sottile linea di pessimismo e di pungente ironia. Quello tra i testi e la musica è un ballo a due, un tango dove l’uno accoglie l’altro in un abbraccio inscindibile d’amore.
In mezzo a questo magma si scorge tra le righe il certificato di band internazionale assegnato agli Afterhours, frutto delle lussuose collaborazioni con Brian Ritchie dei Violent Femmes, con Stef Kamil Carlens già visto insieme ad Agnelli nello splendido progetto “Songs With Other Strangers”, con l’ormai settimo Afterhours Greg Dulli e con l’impeccabile produzione del quasi italiano John Parish.
Più che un album di canzoni, questo sembra una raccolta di 14 bozzetti di terrore visionario, costruito con geometrica potenza, velando abilmente il lato emotivo o comunque domando ogni istinto passionale che viene incanalato in rigorosi cunicoli razionali. Vorrei dire che questo disco non mi convince in pieno, che in più di un’occasione rimanda troppo smaccatamente o a canzoni precedenti degli stessi Afterhours, come in “Musa Di Nessuno” che riprende gli umori galleggianti in “Bianca” dall’album “Non è Per Sempre”, o fa il verso ad altri gruppi come in “Neppure Carne Da Cannone Per Dio” dove la sezione ritmica è ripresa con rigore quasi filologico da “No One Knows” dei Queens Of The Stone Age; ma ogni volta che smetto di ascoltarlo, come un amore torbido che inquieta il cuore, non riesco a scrollarmi di dosso le atmosfere e i motivi che s’intrecciano perfetti in questi pezzi. In mezzo a questi due sentimenti contrastanti, c’è la consapevolezza che il contemporaneo non comprende quasi mai la modernità , la travisa, la respinge quando lo strattona e si finisce per errare nel giudizio.
Nonostante vi sia la sensazione che gli Afterhours abbiano fatto di meglio nel corso della loro carriera, ci troviamo di fronte comunque ad un bel disco, che merita di essere ascoltato più volte per coglierne appieno tutte le numerose sfumature. Buon ascolto.