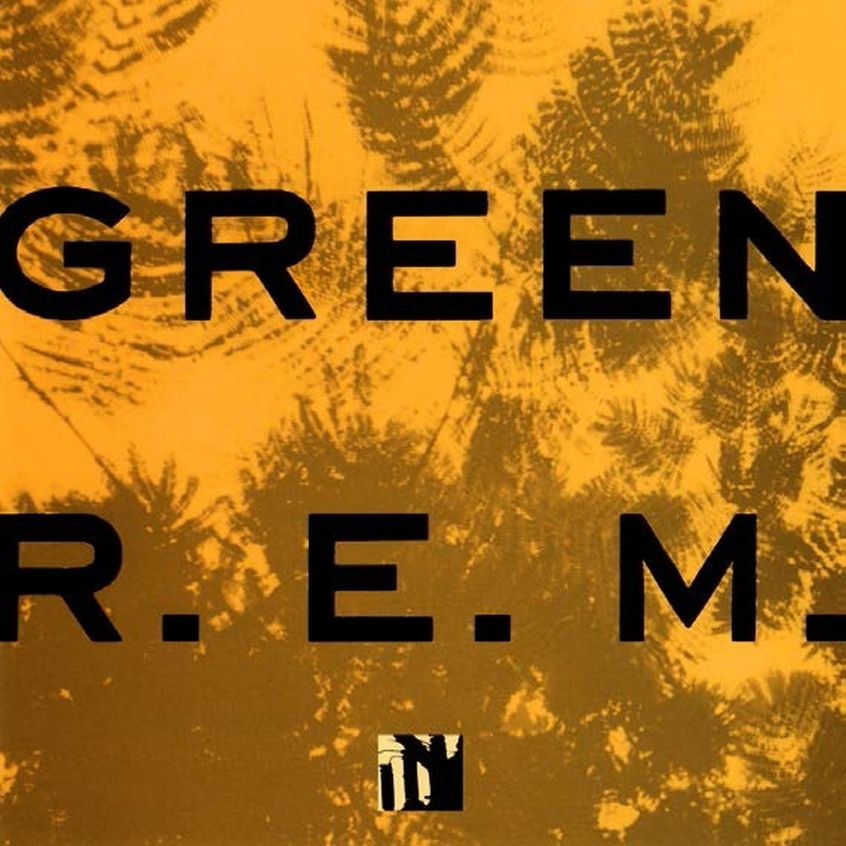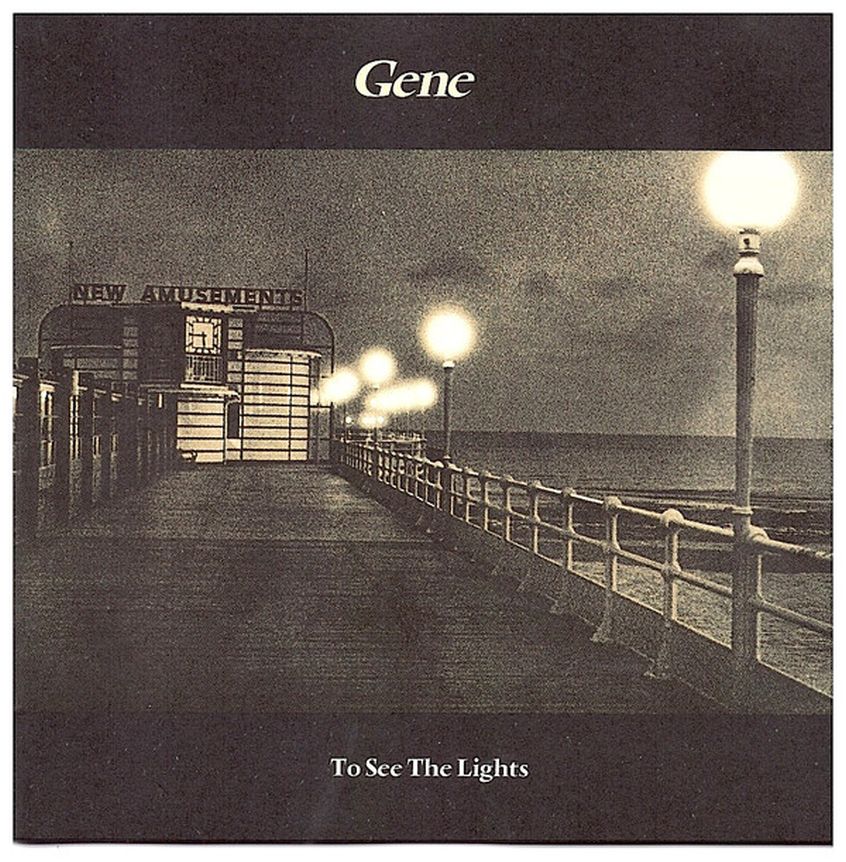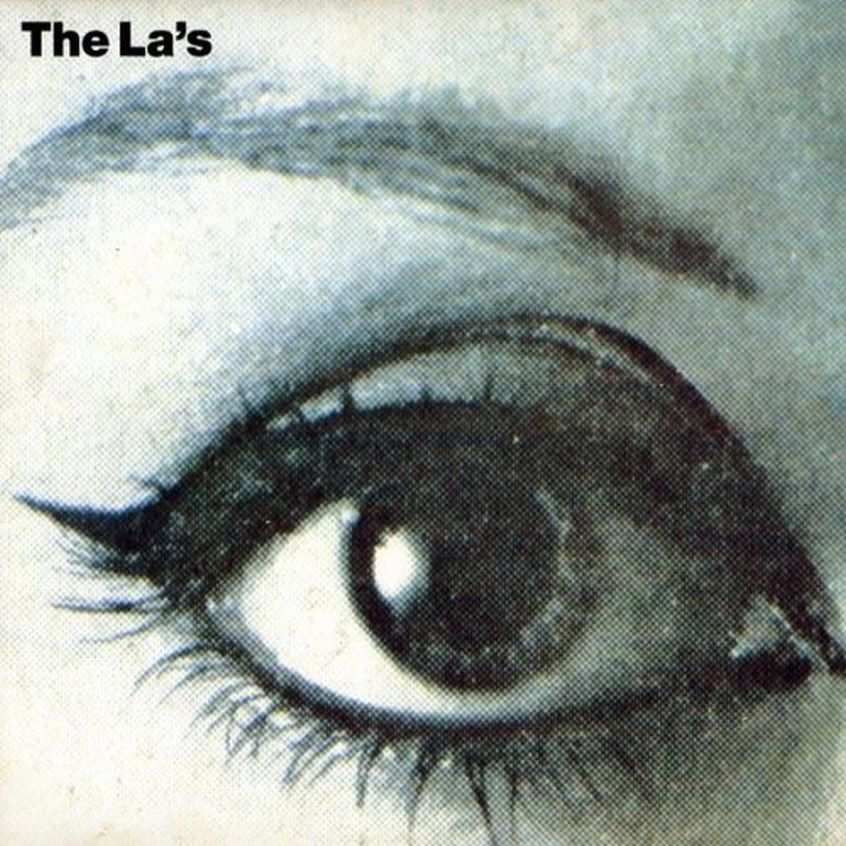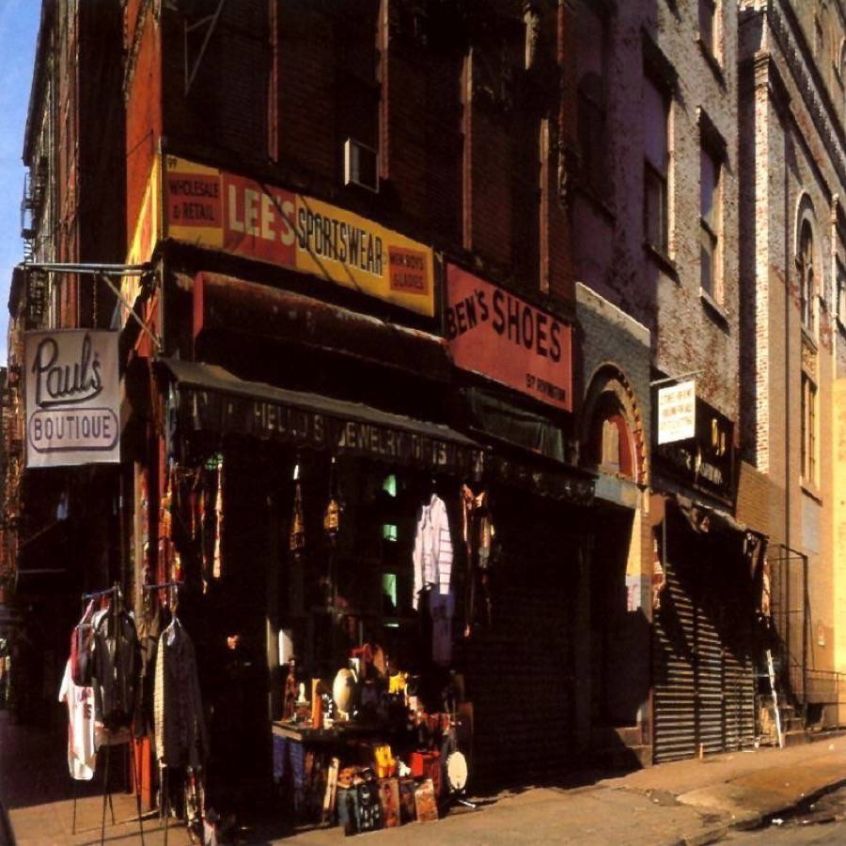In epoca britpop ci fu una band capace di scalzare gli Oasis dal primo posto delle charts britanniche, proprio nel momento in cui i fratelli Gallagher erano all’apice del loro successo commerciale (vale a dire nel ’97, all’altezza della spasmodica attesa esercitata da “Be Here Now”): essa risponde al nome di Ocean Colour Scene.
Un caso emblematico quello dei quattro musicisti, tutti cresciuti dalle parti di Birmingham (precisamente dal quartiere di Moseley), in quanto – esplosi dopo una buona gavetta e assurti a veri e propri idoli in Patria – non riuscirono assolutamente a fare breccia oltre Manica.
E la cosa in effetti fa specie, se consideriamo che, al di là dei pesi massimi Blur, Verve, Suede o Pulp, anche altri gruppi che magari in Inghilterra godevano di minori riscontri rispetto agli OCS, seppero sfruttare l’ondata e ritagliarsi una buona fetta di fans in varie parti d’ Europa.
Uno potrebbe rispondere candidamente che la loro musica non era a quanto pare molto esportabile ma, ascoltando anche a distanza di venticinque anni “Moseley Shoals”, il motivo suddetto pare alquanto fragile, visto che questo secondo lavoro contiene al suo interno autentiche gemme.
Chiudiamo qui la parentesi dedicata a considerazioni simili, anche perchè ci si arrovellerebbe senza arrivare a una soluzione, e mettiamoci comodi nell’esplorare invece i tanti fattori positivi che hanno contribuito al loro successo nazionale, preparando di fatto il terreno, dopo un solo anno, a “Marchin’Already” titolare dell’exploit citato nell’introduzione.
In “Moseley Shoals” gli elementi sonori cari alla band, così come le loro influenze, si amalgamano perfettamente, creando un sound indubbiamente retrò (debitore com’era delle migliori esperienze britanniche avvenute nei magici sixties, tra Beatles, Who e Rolling Stones) ma che, in un movimento britpop che affondava le sue radici in “quel” passato, aveva assolutamente una sua peculiare ragion d’essere.
Erano reduci da un fragoroso flop con il disco di debutto, ancora lontani dal raggiungere un equilibrio formale, ma poi ci furono degli endorsement importanti che indubbiamente contribuirono ad accendere la lampadina sul loro nome: infatti gente come Paul Weller, per non dire di Noel Gallagher, si espose in prima persona per assicurargli spazio e una chance da giocarsi a briglie sciolte.
Gli OCS quelle occasioni le seppero sfruttare nel migliore dei modi, collaborando col primo e aprendo concerti per gli Oasis, proprio quando i preparativi per il lancio del fatidico sophomore erano giunti alla fine e si trattava di passare alla gloria o all’oblio (in un’epoca di concorrenza spietata non vi erano mezze misure!).
Nel frattempo però i quattro amici erano cambiati, di certo avevano accumulato esperienza e ottenuto consapevolezza di cosa volessero esprimere attraverso le proprie canzoni: la loro proposta voleva in pratica rinverdire certi fasti, senza necessariamente aggiornarli ai tempi attuali. Insomma, facevano spesso e volentieri musica anni sessanta o settanta, come se proprio si fosse ancora in quei mitici decenni.
Il loro classic rock, che si muoveva amabilmente tra istanze mod e bagliori pop, risultava così del tutto calligrafico ma in ogni caso genuino e spontaneo, e la cosa fece innamorare come detto flotte di appassionati in terra d’Albione che riconosceva nel cantante e chitarrista Simon Fowler, nel chitarrista e pianista Steve Cradock, nel bassista Damon Minchella e nel batterista Oscar Harrison i veri eredi di quegli esponenti che contribuirono a forgiare la coscienza musicale di un’intera nazione, esportandola nel mondo.
L’ispirazione volta alta in “Moseley Shoals”, sin dal riff iniziale che caratterizza “The Riverboat Song”, brano che si dipana meravigliosamente teso e obliquo, lasciando poi spazio al candore dolente della beatlesiana “The Day We Caught the Train” e all’elettrica ballad “The Circle”, una delle vette del disco.
I tratti sono già ben delineati, e somigliano molto allo stesso tipo di recupero storico e musicale compiuto dal loro padrino d’adozione Paul Weller che solo un anno prima aveva pubblicato “Stanley Road”, allineandosi inconsapevolmente con i gusti di un pubblico che sembrava davvero pronto ad assimilare questa sorta di revival in musica.
Scorrendo le varie tracce, si sentono chiari e forti gli echi dei già citati Stones, sia nella loro versione più sporca (in una ruggente ed emblematica “40 Past Midnight”) che in quella più morbida e crepuscolare, rappresentata da una splendida “Lining Your Pockets” che un po’ ricorda le atmosfere struggenti di “Wild Horses”).
Altri episodi che si stagliano nel contesto di un album piacevole e ispirato sono la semi-acustica e polverosa “One for the Road”, “It’s My Shadow” con i suoi toni epici e la romantica e soffusa”The Downstream”.
Non mancano dei momenti meno a fuoco ma il tutto rientra in un’ottica di urgenza creativa, esemplificata una volta di più da “Get Away” che chiude l’album mettendo in scena un’autentica cavalcata sonora la cui lunga coda strumentale, dove deraglia l’assolo di chitarra di Steve Cradock a contornare il canto liberatorio di Fowler, sembra indicare distanze siderali dalla scintillante melodia pop imperante in tanti gruppi coevi.
La carta vincente degli Ocean Colour Scene sarà a conti fatti proprio quella di rimanere fedeli a se stessi e a certa estetica datata ma assolutamente credibile, lontani dalle mode e da certi effimeri clichè.
Data di pubblicazione: 8 aprile 1996
Tracce: 12
Lunghezza: 54:27
Etichetta: MCA Records
Produttore: Brendan Lynch
Tracklist
1. The Riverboat Song
2. The Day We Caught the Train
3. The Circle
4. Lining Your Pockets
5. Fleeting Mind
6. 40 Past Midnight
7. One for the Road
8. It’s My Shadow
9. Policemen & Pirates
10. The Downstream
11. You’ve Got It Bad
12. Get Away