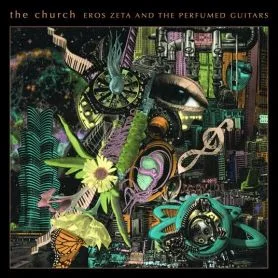Con la sua voce delicata e suadente, torna Lana Del Rey con un album che attraversa tutte le fasi della sua vita. E nel farlo, proprio al suo fianco, ci sono artisti e produttori di alto calibro che cercano di accompagnarla fuori da un tunnel che sembra infinito.

Con il nono album in studio, la cantante americana lascia di nuovo il segno nella discografia internazionale con un album che non è niente di nuovo ma che comunque fa bene alle orecchie. Perché siamo sinceri, un po’ tutti questi nove album sono gli stessi dal punto di vista vocale con, sicuramente, una buona dose di innovazione a livello di produzione e strumentalità nelle basi.
Ed è proprio riguardo alle produzioni che vorrei soffermarmi di più del solito, perché sono loro ad esaltare non solo i testi ma la stessa monotonia vocale oramai ben conosciuta. Partendo proprio dalla prima traccia, “The Grants”, che sfoggia una bellissima sfumatura gospel data non solo dal coro a cappella iniziale, ma dalla commistione proprio di questo genere con quello di Lana.
Un altro genere che troviamo è quello dell’elettronica mischiata all’hip hop in “A&W”: sembra quasi una base che trovi su Garage Band e che non c’entra niente con il resto della traccia, eppure riesce bene a fondersi con tutto il contesto e a dare un’ottima fine alla canzone stessa, con la cantante che inizia quasi a rappare (a modo suo, sia chiaro).
Forse per la prima volta non vengono inserite solo canzoni orchestrali o, banalmente, a pianoforte: forse per la prima volta, quindi, andiamo un attimo oltre prendendo le strade non solo delle commistioni di generi ma anche dei featuring di alto spessore. E in questo disco ce ne sono un po’.
Tra i featuring significativi troviamo “Candy Necklace” con Jon Batiste, pianista americano che ha avuto l’onore di partecipare a progetti con Prince, Steve Wonder o Lenny Kravitz; andando avanti troviamo “Paris, Texas”, con SYML, che dal suo intro potrebbe ricordarci una musica di un film ben nota (a chi indovina pago una birra), ma che riesce a salvarsi per fortuna in corner anche grazie alla delicatezza dell’apporto strumentale proprio del cantautore americano; “Let The Light In” è forse un pezzo non di Lana Del Rey bensì del suo accompagnatore ovvero Father John Misty: è pazzesco come i due universi si siano incontrati e fusi perfettamente per creare una ballad sincera e funzionale a tutto il concept dell’album; con il progetto Bleachers, la cantante si unisce vocalmente al suo produttore Jack Antonoff per un’ennesima ballad che, per carità, può anche piacere ma stanca e che prende il titolo di “Margaret”; e per finire, penultima traccia, “Peppers” con Tommy Genesis ovvero la bruttezza in persona, musica e tutte le altre forme esistenti nel mondo.
Non possiamo dire che sia un brutto album, ha i suoi lati negativi e positivi ovviamente: ci sono tracce che ci fanno sperare in un salto di qualità, ovvero uno step avanti verso nuove contaminazioni. Per il resto, si parla sempre di un album di Lana Del Rey. Anzi, si parla sempre di un album di Lana Del Rey arrivato alla sua nona, identica alle altre, edizione.