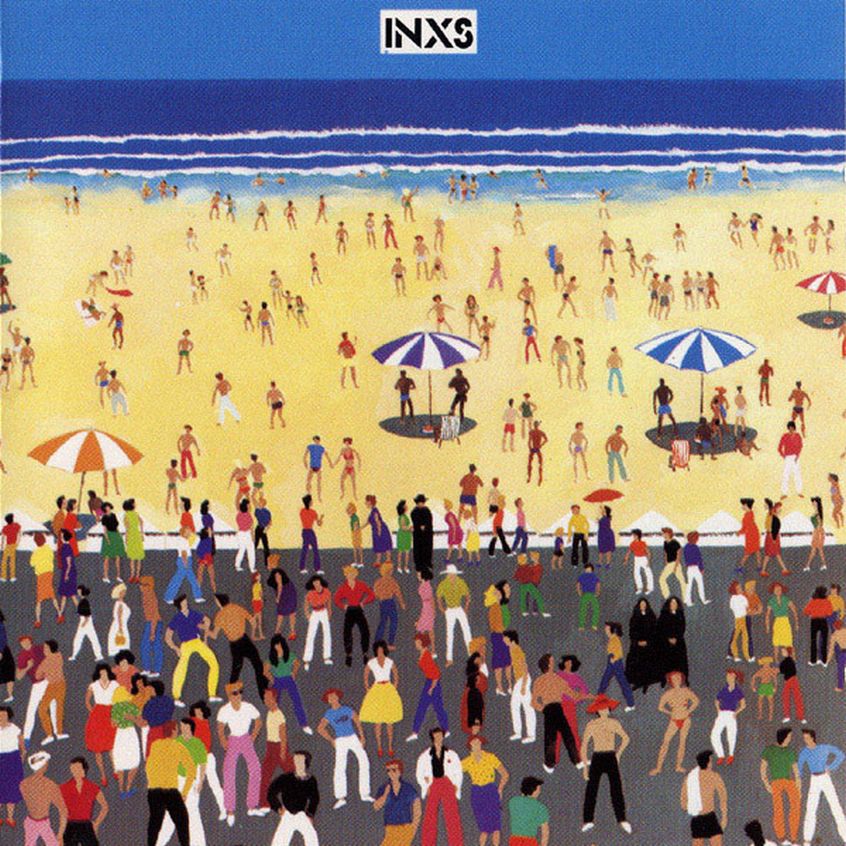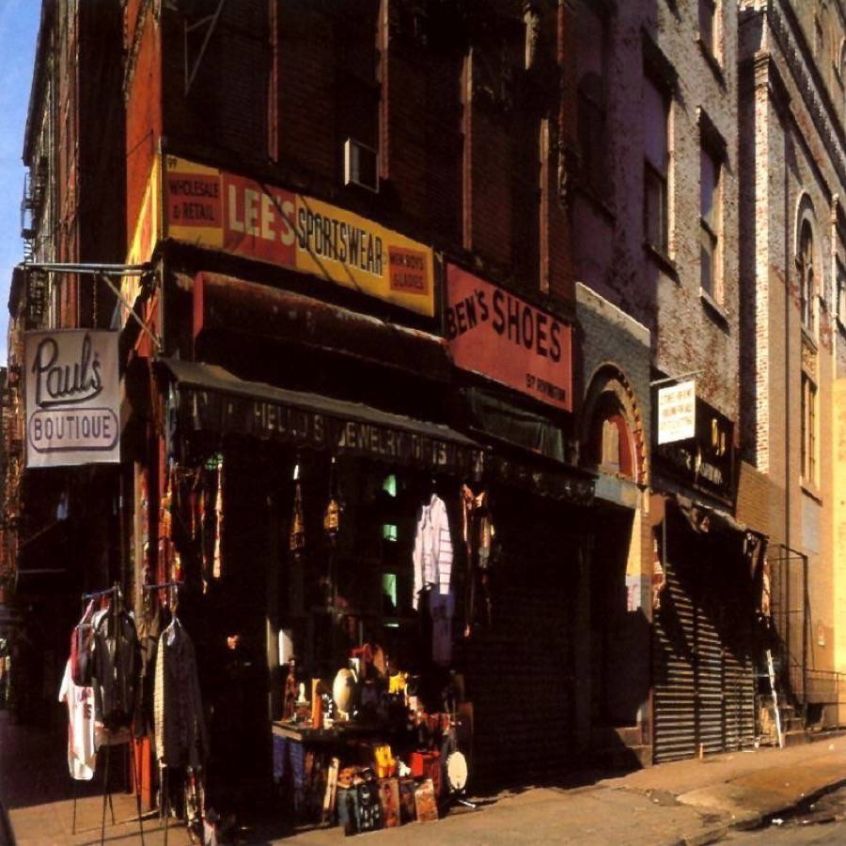Avevo 11 anni quando sentii per la prima volta l’artista afro-americana Tracy Chapman che in quel 1988 con la sua musica era riuscita ad arrivare al cuore di tantissime persone, anche al di là degli Stati Uniti, da cui iniziò la sua imperiosa ascesa.
Un’età verde, se non verdissima per “capire” la musica nei suoi significati più profondi e ovviamente anch’io in un primo momento venni attratto più che altro dalle melodie cristalline e delicate di quelle canzoni, oltre che da una voce che faticavo a ritrovare in altre cantanti che tanto andavano per la maggiore all’epoca.
La mia fortuna, nel crearmi un primo background di tipo musicale, fu quella di essere cresciuto in una famiglia molto appassionata e, nella fattispecie, sia mia madre che mio padre – pur partendo da gusti spesso differenti – erano concordi nell’attribuire a questa giovane esordiente grande valore, cosicché quella cassettina, con in copertina il viso un po’ fanciullesco della sua autrice, girava molto per casa e soprattutto stava spesso accesa nello stereo, con il sottoscritto che ne veniva conquistato ad ogni ascolto.
Un sentimento condiviso come accennato in apertura, se è vero che il disco in questione riuscì a vendere qualcosa come venti milioni di copie nel mondo, e lo fece nella maniera più spontanea e naturale possibile, grazie cioè alla forza delle canzoni che lo contenevano, alle sue parole, ai messaggi che arrivavano dritti in faccia all’ascoltatore, senza troppi fronzoli o elucubrazioni, in un periodo, ricordiamolo, in cui spesso e volentieri la forma prevaleva sui contenuti, premiando in classifica tanti artisti effimeri, il più delle volte dichiaratamente disimpegnati.
Però il primo disco della Chapman fu pubblicato nella seconda metà del decennio edonista per eccellenza, in cui stavano già avvenendo nel mondo (e l’eco partiva proprio da gli Usa governati all’epoca da Ronald Reagan) dei cambiamenti sociali.
Si stava in pratica assistendo a un generale risveglio delle coscienze, e sembrava proprio che la gente avesse nuovamente bisogno di credibili portavoce, qualcuno che potesse rappresentarli e in cui immedesimarsi.
Tracy certe ingiustizie le aveva vissute sin da quando era bambina, in quanto nella natia Cleveland – ma il tema del razzismo riguardava un po’ tutti gli Stati Uniti – le differenze tra bianchi e neri erano ancora enormi, e le disuguaglianze dettate esclusivamente dal diverso colore della pelle non potevano certo essere accettate in maniera sistematica da una giovane studentessa di Antropologia come lei, che infatti ben presto decise di impegnarsi per combattere queste forme di discriminazione contro la sua gente.
Oltre ad essere attiva nei convegni e nelle piazze, aveva cominciato ad esibirsi armata della sola chitarra acustica nei bar della zona universitaria, e in una di queste occasioni il suo compagno di corsi Brian Koppelman (futuro apprezzato regista e sceneggiatore), figlio di Charles, proprietario della indie-label Sbk, ne rimase folgorato, al punto da volersi spendere in prima persona per aiutarla a essere ingaggiata presso una importante major.
D’altronde credo che assistere per la prima volta all’appassionata “Talkin’bout a Revolution” fosse stata proprio una bella botta emozionale, e in embrione quando la Chapman firmò infine per il colosso Elektra vi erano in fondo già altri titoli immortali che avrebbero contornato il suo album di debutto decretandone il successo istantaneo.
Il punto di forza di quelle prime composizioni di matrice folk– arrivate intatte ai giorni nostri a 35 anni di distanza – è da trovarsi nel connubio tra l’accentuata componente melodica (unita a una semplicità di fondo che le rendeva accessibili a tutti) e il messaggio sociale forte che ne deriva, declinato in un modo così sincero e viscerale, senza alcuna sovrastruttura – tanto che sembra di ascoltare un demo, seppur di ottima fattura – che ti faceva davvero empatizzare con la giovane cantautrice.
E difatti per lei si spesero da subito paragoni ingombranti (uno su tutti con l’immensa Joni Mitchell), che la Nostra riuscì a gestire continuando per una strada che ormai si era fatta in discesa, considerati i copiosi riscontri raccolti in ogni parte del globo.
Era diventata una sorta di simbolo, che a distanza di poco tempo dalla sua apparizione sulle scene, si ritrovò a parlare di diritti civili e di uguaglianza a fianco di gente come Nelson Mandela, Ziggy Marley e ad essere impegnata in importanti attività benefiche, una su tutte per il tour Human Rights Now! organizzato da Amnesty International.
La sua stella continuò a brillare, ma non fu mai più così accecante – sul piano squisitamente artistico – come in questo epocale esordio composto da undici brani per una durata di poco più di trentasei minuti.
D’altronde a mettere in fila titoli come l’orecchiabile “Fast Car” – uno dei più bei singoli dell’intero decennio – la dolce “Baby Can I Hold You”, la paradigmatica “Across the Lines”, la cadenzata “She’s Got Her Ticket” o l’accorata “For My Lover” sembra di scorrere un greatest hits e si rimane a bocca aperta, tanta è la qualità racchiusa in quei versi e in quelle note, senza tralasciare i toni innodici della già citata “Talkin’ bout a Revolution” e l’intenso spoken di “Behind the Wall”.
Spetta infine alla struggente “For You” l’onore di chiudere il disco lasciando nell’ascoltatore la certezza di trovarsi al cospetto di un talento fuori dal comune.
Tracy Chapman “Tracy Chapman”
Data di pubblicazione: 5 aprile 1988
Tracce: 11
Lunghezza: 36:09
Etichetta: Elektra Records
Produttore: David Kershenbaum
Tracklist
1. Talkin’ bout a Revolution
2. Fast Car
3. Across the Lines
4. Behind the Wall
5. Baby Can I Hold You
6. Mountains o’ Things
7. She’s Got Her Ticket
8. Why?
9. For My Lover
10. If Not Now…
11. For You