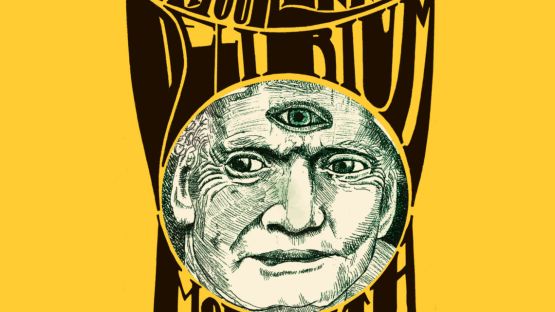Il deserto come luogo mentale da dover ripartire, da dove far crescere la speranza possibile, una metafora dell’asperità, ma anche della lucidità senza vie di scampo e in piena incomprensione dell’affrontare la quotidianità senza se e senza ma.

La band di Detroit parte da qui, dai tormenti divenuti ancora più pressanti per Joe Casey, che usa il simbolismo del titolo per ancora una volta estirpare la massa delle proprie riflessioni che crescono nell’aridità del presente, in personaggi anonimi alle prese con l’enormità universale delle piccole grandi cose, nella sua unica amorevole forma di performance, ai confini dello spoken grezzo e brutale, intenso e viscerale, peculiarità del suono Protomartyr che ormai supera tutte le derivazioni e assume una sua originale fisionomia.
“Formal growth in the desert” fa tesoro di questi presupposti, per una band che al sesto album ha assunto a pieno titolo il livello di fuoriclasse nell’interpretazione moderna di un post punk obliquo, fedele ai canoni fine primi ’80, ma in grado di incorporare quella vaghezza malinconica così wave inglese, così accattivante e magicamente inserita nel contesto umorale del cantato di Casey; qui in particolare, ma a ben vedere questo si potrebbe dire anche per tutti i precedenti album, è come se la band giocasse in un territorio totalmente a suo agio, dentro ritmi serrati, strutture con parti telluriche che vanno poi a scemare per così dire in splendide code autoriali, brani che cambiano in un lampo con un’energia che si trasforma e che si sposta immutata con una naturalezza primordiale.
Siamo sempre a livelli di altissima forma compositiva, con le prime 4-5 canzoni che vanno come un treno in corsa, ma in generale tutti i brani non lasciano spazio a ripensamenti nè deludono, intensi e densi come lo sono i cambi perfetti, le rasoiate e i riff da urlo, la batteria ritmica metronomy driven che neanche il Pop Group, il post punk che si trasforma nel personalismo dal colore ombroso a cui i Protomartyr ormai ci hanno bene abituato, e questo album ce lo conferma perchè ascolto dopo ascolto, dopo lo scossone del primo approccio, si insinua sotto pelle nei dettagli meno sbraitati, nelle linee di intarsio delle chitarre, nei momenti di livore meno accanito, passando da una rivisitazione a spron battuto dei Fall a momenti riflessivi del tutto originali.
Questo album solidifica se prima ce ne fosse stato bisogno, quella sensazione quasi di riscatto che si ha quando si ascoltano le canzoni di questa band, che riescono a rendere tangibile il senso della difficoltà delle nostre azioni, ma anche la resurrezione beffarda e amara che si prova nel superarle, quella vitale soddisfazione che ti coglie quando si percepisce di avere la rabbia o semplicemente la forza di volontà cieca per superare le avversità, una zona in cui essere catapultati in una prospettiva diversa di valutazione delle cose, e ti giri indietro a guardare ciò che è stato, con un senso di straniamento, di incredulità nel riconoscere l’appartenenza ad un vissuto che si fa fatica a considerare proprio.
E allora non ci resta altro che chiedere consolazione, affetto e qualcosa che ci faccia un pò sentire più umani e desiderati (“kiss me before I go/kiss me before I go” ) nella finale “Rain garden”, come se stoicamente ed egoisticamente ci si accorgesse solo alla fine che abbiamo bisogno di poco più di un bacio per ripartire.
Un’esperienza musicale di redenzione, che album dopo album continua a essere medicinale indispensabile, a marchio registrato Protomartyr, al momento senza scadenza ed effetti collaterali negativi.