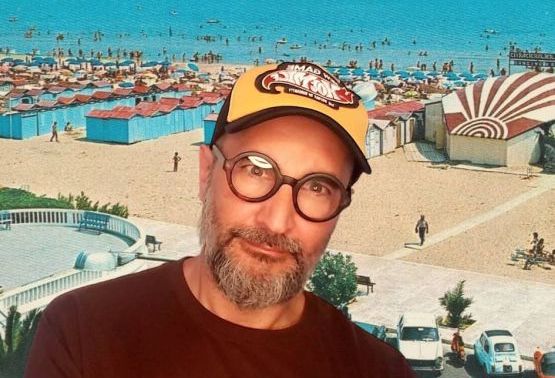Per quelli della mia generazione (quarantenni o su di lì), il nome di Umberto Palazzo è legato indissolubilmente a un periodo fulgido del rock italiano (gli anni novanta), quando l’artista abruzzese si era reso protagonista a più titoli, prima contribuendo in maniera decisiva a far avviare l’esperienza dei Massimo Volume e poi mettendosi in proprio con Il Santo Niente, in pratica una sua diretta emanazione. In più la realizzazione della colonna sonora di un film generazionale come “Tutti giù per terra” e, prima ancora, il suo notevole apporto, quando era ancora un curioso studente universitario giramondo, in alcuni gruppi underground.
Insomma, un talento in pieno fermento, che però sembrava a un certo punto non trovare più il suo posto nel mondo musicale italiano, tanto da allontanarsene volontariamente per dedicarsi ad altro.
In realtà Palazzo, che nel frattempo anche grazie all’utilizzo dei social network, ha forse in maniera inconsapevole rinverdito il suo nome, non ha mai smesso di amare la musica; anzi, ne ha usufruito a piene mani, ascoltandola, assorbendola, e soprattutto divulgandola, impegnato negli anni nell’attività di dj.
Il rock sembrava però essere finito ai margini della sua esperienza e, se da un lato è pur vero che a trionfare nel nuovo millennio sono altri suoni ed immaginari, dall’altra capita a tutti prima o poi di fare i conti (anche) con il proprio passato.
Palazzo aveva già pubblicato a suo nome un lavoro decisamente interessante, specie da un punto di vista poetico e concettuale, se mi concedete i termini, come “Canzoni della notte e della controra” che segnava in un certo senso un ritorno a casa, letteralmente, dopo tanto girare.
Sono passati da allora altri nove anni e, a sorpresa, in questo 2020 così anomalo e destinato, suo malgrado, a entrare nei libri di storia, il Nostro ci consegna un album nuovo di zecca, concepito in scioltezza proprio durante le fasi del lockdown (citato in un verso dell’opening track), in maniera potremmo dire del tutto naturale.
Mettersi all’ascolto di queste otto canzoni che compongono “L’Eden dei lunatici” (a proposito, titolo davvero azzeccato), rappresenta davvero un’esperienza molto piacevole, appagante. E’ un disco questo che trasuda passione per gli aspetti più autentici della vita, per cose anche semplici ma che fanno parte di noi, della nostra storia. Per quanto sia estremamente personale, nei ricordi e nelle immagini del suo autore, è un disco che riesce a evocare un mondo magari lontano ma che ci suona assai familiare.
Che Palazzo ci abbia abituati da tempo al suo eclettismo e al suo essere mutevole è cosa risaputa, ma è bello ritrovarlo così ispirato e a fuoco, in un album che finisce per rappresentarlo pienamente proprio da un punto di vista musicale. L’apparato che si è divertito a esplorare, infatti, è quello che si colloca tra un certo cantautorato al confine col pop d’autore, quel filone che lui stesso da ascoltatore ha sempre dichiarato di ammirare.
Si sentono quindi gli echi di mostri sacri quali i due grandi Lucio della canzone italiana (Dalla e Battisti, quest’ultimo a ben vedere più nella fase post-Mogol), ma anche di Enzo Carella e Ivan Graziani, in brani dove a farla da padrone sono in ogni caso le chitarre, intessute però in uno scheletro pop, funky e latino (citiamo in tal senso la placida “La Baia”, la paradigmatica title track, dalla melodia cristallina e l’acustica “Rita Qualcosa”, con il suo delicato ritratto di gioventù).
Il mood dell’intero lavoro è però ben esemplificato nel micidiale uno-due posto in apertura e che potrebbe finire per candidare “L’Eden dei lunatici” a Disco per l’estate 2020.
Sia l’iniziale “Il moscone” che la più ritmata “La riviera” sono caratterizzate da irresistibili giri musicali e delineate da toni autobiografici, in bilico tra dolcezza, ironia e malinconia; quest’ultima però è ben camuffata, come si evince anche in “L’unica ricchezza”, riferita a quel mare del sud, evocato magistralmente anche in “Mare di notte”, che chiude in maniera riflessiva la raccolta: “chi è cresciuto al mare è mezzo umano e mezzo pesce / non sarà mai uomo di città “.
Un’ultima nota la vorrei dedicare al cantato di Umberto Palazzo, forse mai così pulito, fluido e… rassicurante, proprio ciò che ci voleva per rendere al meglio canzoni dal sapore agrodolce, che ti entrano sottopelle per non abbandonarti.
Credit foto: Umberto Palazzo