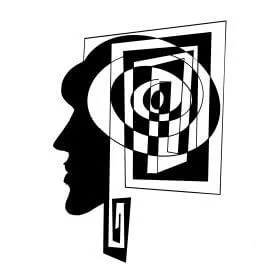Che impresa dare un voto a questa nuova fatica degli a-ha. Che detta così fa già paura, ma andiamo con calma.
Adoro la formazione norvegese ed è innegabile che questo disco rappresenti una nuova “mutazione” nel suono, così arioso, iper-arrangiato e, a tratti, bucolico come non mai: la cosa in realtà non ci dovrebbe sorprendere, visto che nella loro carriera non possiamo certo dire che il terzetto sia rimasto ancorato al synth-pop degli esordi, ma ha sempre voluto (e saputo) sperimentare, aprendosi a sound diversi, (di)mostrando a tutti, critici e fan, che certe etichette non avevano motivo di esistere. Quindi, da questo punto di vista, mi sento tranquillo e non vedo grossi scossoni.
Quello che un po’ mi fa storcere il naso è, semplicemente, una scrittura che mi pare, a tratti, più attenta a una forma impeccabile, trascurando le emozioni vere. Quello che gli a-ha hanno spesso fatto nella loro carriera è stato di emozionarmi, indipendentemente che mi facessero ballare o mi piazzassero il lento strappalacrime. Ecco, qui mi posso complimentare per gli ottimi arrangiamenti, tanto di cappello alla Arctic Philharmonic, ma poi mi pare che, nel lavoro, manchi una buona continuità nello sfornare dei ritornelli che entrino non solo in testa, ma anche nel cuore. Forse il fatto che le musiche servano da sfondo alle immagini (c’è, infatti, anche un film/documentario con lo stesso titolo dell’album) fa si che solo con l’abbinata tutto funzioni alla perfezione, eppure mi pare che, in alcuni frangenti, la band non riesca ad andare oltre a un (pur piacevole) manierismo orchestrale di fondo. Sicuramente se amate un certo sound anni ’70, piuttosto easy listening, beh, credo che apprezzerete assai il disco, ma io francamente faccio un po’ fatica a rientrare in quell’ottica, lo ammetto. Che tutto scorra via senza intoppi è innegabile, ma i guizzi (ripeto in fase di scrittura, non tanto come arrangiamenti, decisamente curati) importanti, ecco, quelli non sempre arrivano a dovere.
Il problema più grosso però è tutto nella partenza. “I’m In” è una canzone pazzesca, forse uno degli apici della band in assoluto: una canzone sublime, evocativa, potente ma nello stesso tempo così toccante. Impossibile ascoltarla senza avere la pelle d’oca, anche per questo messaggio così semplice eppure così profondo. Purtroppo, cominciare un disco con un brano così è, in realtà , una pietra tombale per tutti gli altri pezzi successivi, che rispetto a questa perla assoluta, avranno sempre il fiato corto. Parere personale, ovvio, ma io non l’avrei mai messa come incipit. Già con il secondo brano, “Hunter In The Hills”, le cose si fanno più leggere, quasi lounge music. La canzone è piacevole e scorrevole, così come “As If” che procede sullo stesso mood, delicatamente sbarazzino. Forse il pezzo più pop dell’intero lotto insieme a “Bluest Of Blue”, altro brano leggero e andante, che trova una melodia zuccherosa grazie al bel lavoro sulle voci e a un ritornello furbetto. Niente di memorabile, ma tutto funziona in modo rodato e aggraziato quando si toccano questi lidi pop. Arpeggi delicati per “Between The Halo and The Horn”, che però pecca nella ritmica elettronica che semplicizza fin troppo il brano, che risulta il più “asciutto” e meno ricco nel sound, la melodia comunque è buona.
La title track ci lascia interdetti. Quale sarebbe il senso di rifare “Stay on These Roads”? Intendiamoci, è una bella canzone questa “True North”, ma l’abbiamo già sentita nel 1988. Ma è una specie di cover? Un auto-tributo? Un auto-plagio? Non saprei, sta di fatto che la mente va a quel brano classico e da li non si schioda.
“Bumblebee” ha un mood simile a “Hunter In The Hills”, gli a-ha guardano ancora musicalmente indietro e io mi posso immaginare a un bar, a sorseggiare un drink mentre converso amabilmente con la fanciulla di turno, basette lunghe, pantaloni a zampa e camiciona a fiori col collettone. Vi dirò, non mi ci vedo molto bene per un brano da sottofondo e nulla più. “Forest For The Trees” ha quasi un piglio alla James Bond, sempre dettato dagli onnipresenti archi, che danno un taglio deciso: uno dei pezzi che preferisco, anche per il ritmo incalzante. Il finale va a strappi. La “synthetica” “Make Me Understand” lavora sul ritmo, e sembra quasi un ponte tra anni ’70 e ’80, a suo modo interessante. La delicatezza e la fragilità di “You Have What It Takes” fanno centro. “Summer Rain” invece si fa apprezzare per il suono del piano che crea la giusta atmosfera, ma mi pare andare poi col pilota automatico, mentre “Oh My World” è una chiusura gentile, certo, ma totalmente debitrice di Burt Bacharach, a dire poco.
Riparto all’inizio. Che fatica dare un voto al disco, perchè c’è un capolavoro, cose belle e altre più o meno carucce ma nulla più. Vado per un 7. Mi pare il giusto compromesso.