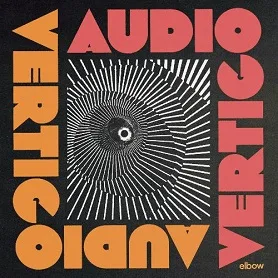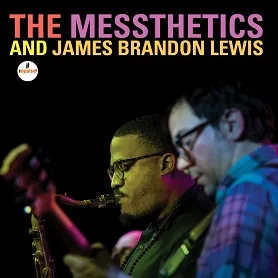Tra certezze assodate e qualche novità interessante, gli Slipknot di “We Are Not Your Kind” convincono senza stupire. Arrivata al sesto album prodotto in poco più di vent’anni di carriera, la band di Des Moines continua a giocare con il proprio riconoscibilissimo sound, evitando tuttavia qualsiasi tipo di scossone in grado di aprire nuove prospettive evolutive. L’impressione è che, dopo il successo epocale dei primi due lavori e la rivoluzione melodica di “Vol. 3: (The Subliminal Verses)” nel 2004, i nove mascherati abbiano in qualche modo deciso di adagiarsi sugli allori. Formula che vince non si cambia, in parole povere.
In queste quattordici tracce trovano spazio davvero tutti gli elementi caratteristici dei nostri, alcuni dei quali provenienti dai rabbiosi e luridi esordi nu metal: l’alternanza tra voci pulite e parti urlate, i solidi intrecci ritmici tra la batteria di Jay Weinberg e le percussioni di Shawn “Clown” Crahan, i riff affilatissimi dei chitarristi Mick Thomson e Jim Root e, ultimo ma non ultimo, il ruolo centrale giocato dai ritornelli all’interno di brani sì strutturati piuttosto tradizionalmente, ma assemblati in maniera tale da infondere grande respiro alle idee più originali.
Non a caso, “We Are Not Your Kind” contiene alcune tra le composizioni più lunghe mai scritte dagli Slipknot: il dilatarsi del tempo a disposizione consente al gruppo di muoversi con gusto e assoluta nonchalance tra momenti pesantissimi e parentesi più soft. Il modello viene sfruttato sapientemente in “A Liar’s Funeral” e nell’eccellente “Not Long For This World”, due intensissime semi-ballad ricche di pathos e sfumature, ma imprime un marchio importante anche su canzoni dal sapore leggermente più classico, come “Critical Darling” e “Nero Forte”. Quest’ultima, con il suo refrain cantato in falsetto, probabilmente farà storcere il naso a qualche fan duro e puro, nonostante il bel riffone alla System Of A Down che irrompe sin dalle primissime battute.
I richiami al passato più heavy non mancano di certo: “Red Flag” e “Orphan” sono due bei macigni carichi di odio e veleno, ma solo “Birth Of The Cruel” e la superlativa “Solway Firth” riescono a tramortirci e sorprenderci contemporaneamente. La prima lo fa invertendo il consueto schema strofa urlata/ritornello melodico; la seconda mettendo in mostra un carattere epico dalla potenza unica, rafforzato dall’interpretazione da pelle d’oca gentilmente offertaci da Corey Taylor.
Lo stupore prosegue nel singolone “Unsainted”, con il suo coro di voci bianche alla “You Can’t Always Get What You Want” dei Rolling Stones, e nelle due tracce elettroniche presenti in lista. Sto parlando di “Spiders” e “My Pain”, curiosi esperimenti in chiave industrial/trip hop che, pur non colpendo in maniera particolarmente positiva, hanno il merito di confermare la ritrovata essenzialità del turntablist Sid Wilson e del tastierista Craig Jones, un po’ defilati nelle uscite più recenti. In fin dei conti, un album ben fatto: fin quando continuerete a suonare così, cari Slipknot, sarete sempre i nostri tipi. La prossima volta, però, tagliate fuori qualche intermezzo di troppo: oltre che ad allungare il brodo, servono a poco nulla.