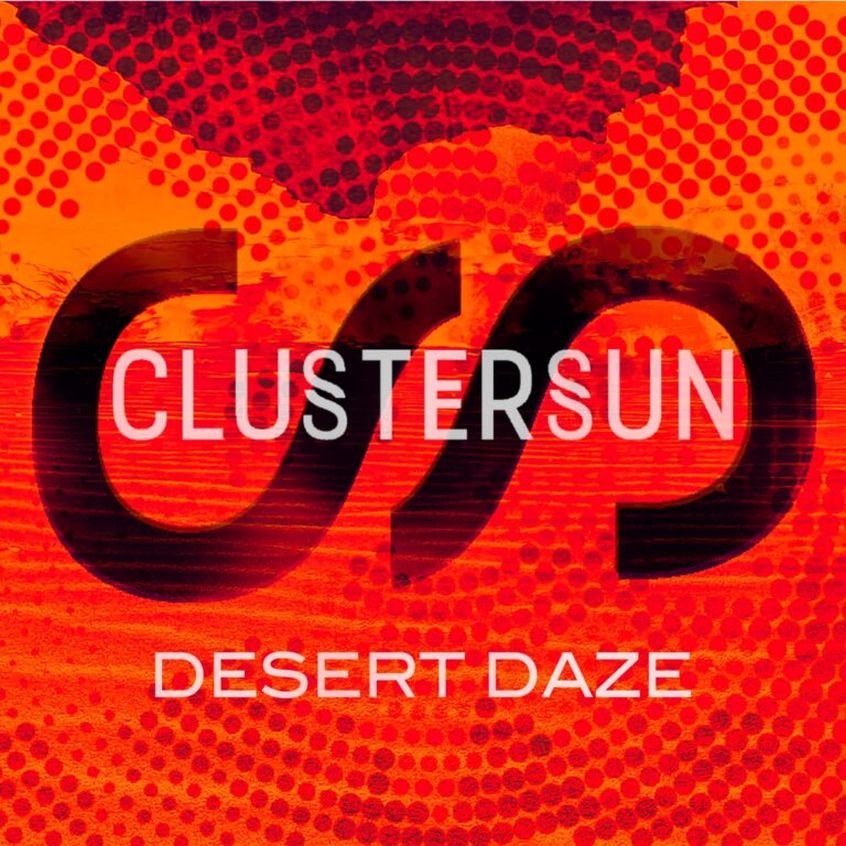Al deserto dobbiamo la gratitudine del silenzio. Un silenzio fatto di sale, di solitudine e di sabbia; un silenzio sacro, che è un viaggio muto attraverso le nostre contraddizioni ed i nostri conflitti interiori; mostri ostinati ed invisibili che, agitandosi dentro di noi, fanno sì che il vaso di Pandora al rovescio, nel quale avevamo rinchiuso i nostri sogni e le nostre passioni, vada, finalmente, in frantumi, liberando il suo prezioso contenuto tra le morbide dune delle nostre anime inquiete, trasformandosi, di conseguenza, in quella scintilla primordiale e selvaggia dalla quale il fuoco liquido di “Desert Daze” può, nuovamente, espandersi ed invadere il mondo.
Un mondo di ombre ostili, rese ancora più malevole, morbose e minacciose dall’ultimo anno e mezzo trascorso tra lockdown ed impossibili quarantene; un mondo che ha la voce dei migranti, dei rifugiati, degli emarginati, delle guerre che si perdono in un passato remoto, crudele e rabbioso, che continua, sprezzante, a reclamare il suo prezzo di carne, di lacrime e di sangue; un mondo arido e contorto nel quale le sonorità oscure ed accattivanti, lisergiche e vibranti, selvagge ed introspettive di “Avalanche”, il nuovo album dei Clustersun, assumono il valore prezioso ed inestimabile della “fottuta pioggia” che lava, purifica e guarisce le nostre antiche, distopiche e disperate ferite.
Non sappiamo quanto tempo abbiamo a disposizione: questo, magari, potrebbe essere il congedo finale. Un congedo nel segno dell’alchimia tra le sonorità acide e visionarie di “Avalanche (Legion 5)”, quelle incalzanti e mordaci di “Barricades”, quelle morbide e nostalgiche di “Sinking In To You” e quelle amare e desertiche di “All Your Pain”, la quale assume i contorni di una preghiera eterna alla Luna; l’ultimo, amorevole tentativo di un indomito e ribelle Prometeo di rubare il fuoco agli dei, mentre, nel frattempo, ogni sua relazione sembra dover andare a rotoli, ogni suo rapporto interrompersi in modo brutale, le sue stesse costellazioni, quelle di “Closer/Deeper”, spegnersi velocemente, una dopo l’altra, accompagnate dalle grida fameliche e feroci dei suoi aguzzini, dei suoi carcerieri, dei suoi padroni, dei suoi temibili demoni interiori si fanno via, via sempre più insopportabili e penetranti.
“Juggernaut” sposta l’orizzonte verso i meandri misteriosi ed inesplorati dello space-rock, laddove ogni nostro riferimento materiale si sgretola, ogni percezione fisica svanisce, l’oblio cosmico divora i nostri resti mortali ed un filo incorporeo ed immateriale unisce la band catanese al pianoforte a coda della pinkfloydiana “Nobody Home”.
E’ così che deve finire? Mentre continuiamo a scalare, imperterriti ed ignari, questo gelido ed astioso muro di dolore?