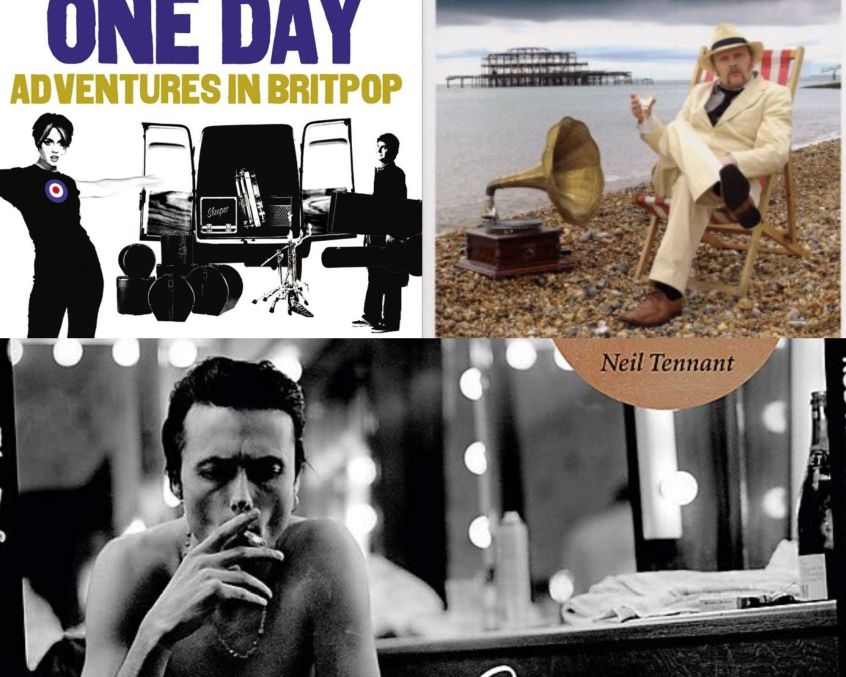Il 10 febbraio la Cherry Red Records ha riacceso i riflettori sugli Auteurs, creatura musicale di Luke Haines, pubblicando “People Round Here Don’t Like To Talk About It – The Complete EMI Recordings“. I 6 CD che ripercorrono la strada percorsa dalla band negli anni ’90 sono racchiusi in un Box che ha il merito di tenere viva la memoria di un progetto tanto raffinato, suggestivo e amato dalla critica quanto, purtroppo, non baciato dalla fortuna di vendite eccelse, forse proprio a causa di quel carattere schivo e non incline alle etichette che sempre ha caratterizzato Haines, che si vedeva tutt’altro che un astro nascente del Britpop. La pubblicazione, se per i completisti della band può anche risultare superflua, per noi è invece spunto per una bella e lunga chiacchierata con un artista così intrigante, che mai si è adagiato sugli allori.
(L’interista, nella sua forma orginale è stata pubblicata sul numero 510/febbraio 2023 di Rockerilla)
A dialogare con Luke Haines è Francesco Sciarrone, che ringrazio ancora per il fondamentale supporto che ha dato per la realizzazione di questo articolo.
La telecamera del laptop di Luke Haines è puntata sul suo studio, mi collego qualche minuto prima dell’incontro fissato e ho il modo di scorgere una telecaster, una 12 corde acustica, un farfisa e un microfono. Dopo qualche minuto appare Luke, si scusa per l’abbassamento di voce (come se di per sé non avesse già la voce bassa…) a causa di una recente influenza. Gli chiedo se è il suo “home studio” e mi conferma che è proprio “Where the magic happens”. Non mi sarei aspettato diversamente: riservato, accogliente, più “home” che “studio”, perfetto per un personaggio come lui.
Partiamo dall’inizio: 1992. Gli Auteurs sono sulla bocca di tutti, ma senza nessun contratto in mano e nonostante questo decidono di entrare in studio e registrare il loro debutto, “New Wave”…
Esatto. In quegli anni le cose erano diverse, e incidere senza etichetta non era così anomalo. Avevamo un manager che si impegnava a trovarci delle date, e pian piano sono uscite sempre più recensioni sui nostri live, sempre positive. Quando la stampa ti mette un occhio addosso sai che di lì a poco avrebbe bussato alla tua porta qualcuno con un contratto in mano, quindi abbiamo deciso di registrare il disco a priori. Per farci trovare pronti.
Come siete approdati alla Hut?
Avevamo qualche persona dell’industria discografica che aveva provato ad avvicinarci, ma erano state solo chiacchiere, forse se avessimo lasciato passare più tempo avremmo aumentato l’hype e ce ne sarebbero state di più. Il talent scout della Hut è stato il più diretto: semplicemente una sera, dopo un concerto, si presenta e senza tanti giri di parole ci chiede “Volete firmare con la nostra etichetta?“, quindi mi sono detto: “Perché attendere oltre?” Col tempo posso dire che è stata un’ottima decisione. Forse è stata una scelta impulsiva ma vedendo il nostro percorso sono contento della scelta.
Sei sempre stato considerato la figura principale della band. Quanta di questa “autorità” c’è nel debutto?
È una bella domanda, alla quale però non so dare una risposta precisa, si parla di così tanto tempo fa. Quando suonavo con i Servants (band new wave guidata da David Westlake, ndr) le canzoni nascevano in maniera naturale in sala, e in un certo senso anche per noi è stato così. Non mi sono mai fermato molto a pensare alla struttura, alla necessità di un break o di uno special, non tratto la musica in una maniera così chirurgica, è più come se la musica fosse nell’aria, come se fosse già presente nella mia testa, e io ho solo il compito di portarla su carta.
“New Wave” è stato pubblicato nel febbraio del 1993. Pochi mesi dopo, nel numero di aprile di Select, siete citati in copertina assieme a Suede, Pulp, Denim e St. Etienne con un messaggio molto chiaro “Yanks go home!” Quanto c’era di vero in questa sorta di rigetto musicale anti-americano?
Non c’era niente di vero, non c’è mai stato nulla di vero in tutto quello che scriveva la stampa al periodo. Noi facevamo la nostra musica e basta, ma la stampa è incontrollabile e imprevedibile: la stessa che voleva “cacciare a casa gli americani” è la stessa che glorificava il britpop ed è la stessa che spingeva la Brexit. C’è sempre stato questo orgoglio un po’ nazionalista…se il britpop fosse nato qualche anno più tardi lo avrebbero di sicuro utilizzato come campagna per accelerare la Brexit.
È innegabile però che agli inizi la stampa aveva un debole per voi, il disco è stato accolto positivamente e avete avuto anche copertine su NME e Melody Maker.
Sì, era un periodo in cui nascevano molte band e molti stili, e avere buone recensioni (ci) ha indubbiamente aiutato ad emergere dalla massa.
Nello stesso anno siete stati nominati per il Mercury Prize, alla seconda edizione. Eravate nella shortlist assieme a PJ Harvey, New Order e Suede, che alla fine vinsero il premio. Come avete vissuto quella nomination?
Al tempo, il Mercury Prize non era così importante come lo sarebbe stato in seguito, quindi penso che sia stato abbastanza indifferente per me. E, sottolineo, non dico “importante come lo è adesso” perché, ammettiamolo, adesso del Mercury Prize non interessa più a nessuno. Penso che i premi siano importanti se sei il vincitore! Io non ho mai vinto nulla, quindi al massimo ti potrei dire cosa si prova a non vincere un premio, ma preferisco non farlo perchè potrei passare come invidioso o superficiale. Dire che i premi non contano nulla quando non li hai mai vinti è facile. Quando vincerò qualcosa saprò dirti come ci si sente a essere il vincitore e il perdente.
Passiamo al secondo lavoro degli Auteurs, “Now I’m a Cowboy”. Il primo album è stato registrato in piena libertà, non avendo ancora nessuna casa discografica con richieste specifiche. Com’è stato registrare questo nuovo lavoro sotto contratto? Avete avuto pressioni da parte della Hut?
Non molta a dire il vero. Il primo lavoro era andato bene senza dover far fronte a richieste specifiche, quindi per il secondo album abbiamo avuto il semaforo verde a continuare per la nostra strada. Certo qualche velata pressione c’era, ma non come potrebbe avere una band adesso al secondo lavoro. Penso che sia stato durante le registrazioni di quest’album che ho realizzato di non essere interessato a quella “competizione” tra band che stava nascendo. Ma la casa discografica non era preoccupata per questo mio disinteresse: loro avevano già trovato nell’album i singoli “Lenny Valentino” e “New French Girlfriend” e tanto gli bastava per farci andare avanti. Devo dire che al tempo non ero molto soddisfatto del disco in generale…ma col tempo è migliorato.
Mentre molte band del periodo, anche con un solo album appena uscito, venivano catapultate in Giappone, con tour importanti, voi, assieme ai Divine Comedy, avete avuto riscontri molto positivi in Francia, tanto che nello stesso anno la rivista Les Inrockuptibles uscirà con una vostra compilation di brani live. Come mai secondo te ci fu questo interesse da parte dei francesi?
Li abbiamo ingannati con il nome della band (ride)! Non me lo so spiegare neanche io. Probabilmente hanno apprezzato il primo disco e dalla copertina hanno pensato che la “New Wave” del titolo fosse riferita alla French New Wave del cinema. Anche la copertina del resto era molto cinematografica. Quindi alla nostra seconda prova ci hanno accolto con più interesse. Mi piace pensare che la Francia abbia colto prima degli altri il lato “intellettuale” della nostra band e ne sia rimasta affascinata.
Poco tempo dopo l’uscita di “Now I’m a Cowboy” venne dato alle stampe un disco molto particolare, ovvero “U-Ziq vs The Auteurs”, da te definito come il “Metal Machine Music” del gruppo. Come mai non ha avuto la sua ristampa anni fa (come accaduto con altri lavori degli Auteurs, ndr) e come mai non è nel box?
Oh io amo quel disco, mi ha subito colpito e lo reputo molto interessante, non dal punto di vista strettamente musicale ma da quello concettuale. Amo i lavori di Michael Paradinas ed è stato spiazzante come ha rielaborato le canzoni. È stato come vederle sotto una luce nuova. Tuttavia non lo reputo un lavoro da inserire in una panoramica degli Auteurs, anche perché non sono remix che abbiamo curato direttamente. Riesco a immaginarmi un ascoltatore che, dopo aver sentito l’album, vuole approfondire con le b-side ma non riesco a trovare l’interesse nel sentire un album di remix. È un’opera a parte, per questo dico che non mi colpisce molto dal punto di vista musicale, ma più da quello concettuale ed emotivo.
Passiamo a quello che forse è il mio lavoro preferito della band, “After Murder Park”. Questo disco ha al mixer Steve Albini e si sente nelle chitarre ruvide e nei suoni spigolosi. Come siete entrati in contatto con lui?
Non è difficile registrare con Steve Albini, basta avere un’etichetta che paga per te, ed il gioco è fatto! Penso che all’inizio Steve non fosse molto convinto del progetto, secondo me ci ha visti come l’ennesima band spazzatura dall’Inghilterra, ma credo che dopo aver sentito i pezzi abbia cambiato idea e la scelta si è rivelata giusta. A differenza di quanto dicono in molti, noi abbiamo lavorato benissimo con lui, è una persona brillante e concreta e sin da subito abbiamo trovato il giusto feeling e una sorta di direzione comune dove puntare tutti assieme. Era come se inconsciamente volessimo tutti fare quel tipo di disco con quel tipo di suono, sia noi come band che lui come produttore.
Avete anche registrato ad Abbey Road…
Sì, ma al tempo non era come adesso. Ora chiunque può andare ad Abbey Road, basta aprire il portafoglio. Al tempo invece andavi ad Abbey Road solamente se eri un “pezzo grosso” che aveva una manciata di hit che erano una sicurezza per le vendite, oppure, come nel nostro caso, se non avevi nessuna hit single! Era una mentalità un po’ standard delle etichette dell’epoca: “Se vai ad Abbey Road di sicuro ci scappa il brano pop!“. Ma non era nel nostro caso: avevamo uno studio fantastico, il gruppo in quel momento era in ottima salute e avevamo per le mani questo disco che era volutamente claustrofobico e oscuro…e avevamo Steve Albini. Non ci interessava assolutamente un brano pop. Era tutto perfetto, eravamo tutti perfettamente “sintonizzati” tra di noi, come se comunicassimo le nostre intenzioni telepaticamente. E penso che questo affiatamento sia stato catturato a pieno nel lavoro.
È vera la storia che il disco è nato da un incidente che hai avuto e che ti ha costretto sulla sedia a rotelle per alcuni mesi?
Non è del tutto esatto. Il disco era già pronto, al periodo delle registrazioni avevo abbandonato la sedia a rotelle, mi muovevo dentro e fuori abbey Road con le stampelle.
6 mesi dopo l’uscita di “After Murder Park” ecco il progetto Baader Meinhof che, pur essendo un side project, è comunque contenuto nel box. Amo questo disco dai temi scomodi e sonorità essenziali, una sorta di disco funk ma ridotta allo scheletro. Cosa puoi dirci su questo lavoro?
È esattamente un disco funk: si basa molto sulle ritmiche e gran parte del merito va a Kuljit Bhamra, un percussionista indiano che ha suonato diversi set di Tabla (strumento a percussione) creando quei ritmi dance scarni. Fondamentalmente quel disco è stato fatto da me e lui e solo in seguito abbiamo aggiunto degli archi e dei violini. L’album è nato quasi come un passatempo. “After Murder Park” era pronto, ma non era ancora uscito, e io non sono proprio il tipo che fomenta la stampa o presenzia alle feste e ai party degli altri. Me ne stavo per conto mio, avevo parecchio tempo libero quindi ho deciso di impiegarlo su qualcosa di nuovo, senza dovermi preoccupare di legarlo agli Auteurs o a un post “After Murder Park”, quindi sì, è strano trovarlo nel box, ma sono molto orgoglioso di questo lavoro: è stata la prima volta che ho capito a pieno come funziona uno studio e come poter gestire in maniera autonoma un intero album dalla registrazione alla produzione.
Ho notato che come bonus track per quel disco ci sono solo dei remix. Nessuna traccia di demo o versioni alternative…
No, se la memoria non m’inganna non esiste alcuna traccia di demo o versioni diverse di quel disco. Niente tesori nascosti o rarità. Anzi, a dirla tutta, dei remix presenti due sono stati fatti da me, ma sono usciti sotto falso nome.
Siamo arrivati all’ultimo disco della band, “How I Learned To Love The Bootboys”. Un disco inaspettato da realizzare, per te, perché “After Murder Park” aveva raccolto recensioni positive ma, in fatto di vendite, era andato male, quindi avevate la sensazione che di lì a breve la Hut vi avrebbe scaricati, è vero?
Ricordo un’atmosfera strana: c’era il disco appena uscito, seguito poco dopo dal progetto Baader Meinhof, c’era la Hut che forse si aspettava di più da noi con Steve Albini a Abbey Road e poi c’ero io, che stavo perdendo interesse verso gli Auteurs e, a essere sincero, mi ero anche abbastanza annoiato nel portare dal vivo il precedente disco…
In più in quel periodo stava nascendo l’altro side project, i Black Box Recorder…
Sì, col tempo ho scoperto che mi piaceva collaborare con persone nuove, nuovi musicisti, nuove sonorità…
Nello stesso periodo hai avuto anche un altro, brevissimo, side project che non ha portato però a nessuna produzione discografica, erano gli ESP Kids.
Non era proprio un side project o forse non ha avuto il tempo di farlo diventare tale. ESP Kids era l’idea iniziale per il nuovo disco degli Auteurs. Volevo fare qualcosa di grosso, pensavo ad un doppio LP, forse troppo per gli Auteurs stessi. Ma, come hai detto tu, in quel periodo c’erano i Black Box Recorder con cui andavo in studio in maniera molto regolare, con cui uscivamo assieme dopo le prove, con cui provavamo più spesso e soprattutto la band a cui proponevo i miei pezzi, quindi gli Auteurs/ESP Kids sono naturalmente scivolati al secondo posto. Era un periodo di transizione, come quando sai che stai per lasciare la tua ragazza perché ami un’altra: con lei hai trascorso tanto tempo e hai un sacco di ricordi ma con la nuova vorresti ripetere tutto, perché sai che sarà diverso.
La voce di Sarah Nixey nei Black Box Recorder è tanto sexy quanto ipnotizzante…ma poi ti accorgi del testo e il risultato è spiazzante!
Mi ricordo che al tempo sui testi ci scherzavamo su. Molti erano convinti che i dischi avessero troppo humor nero e fossero troppo depressivi, in realtà noi ci stavamo divertendo, e molto, per questo faccio fatica a rapportarmi a quei lavori: lì dove molti vedono un’atmosfera cupa io ricordo giorni molto piacevoli e divertenti.
Arriviamo così all’ultimo disco del box, “Das Capital”, a nome Luke Haines & The Auteurs. Al tempo ci rimasi un po’ male perché questo disco, diciamolo, sa un po’ di greatest hits di fine rapporto discografico, anche se i brani riarrangiati con l’orchestra sono fantastici, in particolare l’overture in apertura. Com’è nata l’idea di riarrangiare tutto?
Ufficialmente, al tempo, ero già stato scaricato dall’etichetta. Mi ricordo che il boss della Hut mi volle nel suo ufficio. Aveva già pronte tutte le scartoffie per scaricare del tutto la band, pensavo mi avesse chiamato solo per mettere la firma alla parola fine e, invece, mi propose di fare questo album. In un certo senso volevano “mungere” il repertorio degli Auteurs con un ultimo disco d’addio, cosa che adesso stanno facendo in molti. Mi sembrava un bel modo di congedarsi, senza contare che l’offerta era quella di realizzare l’album con una cifra precisa (100.000 sterline, non so se vuoi scriverlo, una cifra non indifferente dato il periodo) di cui avrei potuto tenere tutto quello che sarebbe avanzato post registrazioni. In quel periodo ero al lavoro sul terzo disco dei Black Box Recorder che aveva problemi ad uscire (la band aveva il lavoro pronto ma era senza etichetta, ndr). Ero un po’ depresso e in un certo senso avevo la sensazione che quella era l’ultima occasione che avevo di fare un album con una “major” e “un budget da major”. È stata mia l’idea di rivedere i brani con l’orchestra e sono soddisfatto del lavoro che ne è uscito.
Ti va di parlare della tua ultima collaborazione con Peter Buck?
Certo con piacere
Il primo disco, “Beat Poetry Survivalists“, sbaglio o è uscito qualche settimana prima della Pandemia?
No, è uscito 2 giorni prima della pandemia! Anzi, l’uscita “da calendario” è stata due giorni prima della pandemia, ma nei negozi è arrivato il giorno seguente, ovvero quello precedente al lockdown. Poi…tutti a casa e tutto chiuso! Acquistarlo era impossibile perché, in quel periodo, si potevano acquistare solo beni di prima necessità, cosa che, però, il nostro disco poteva benissimo essere (ride). Con la pandemia ci siamo trovati chiusi in casa sia io che Peter, in USA, quindi abbiamo pensato di continuare a scrivere, e abbiamo scritto così tanto da poter fare un doppio LP.
“All The Kids Are Super Bummed Out” è uscito da qualche mese per Cherry Records. Molti lo definiscono un concept album…
Non lo vedo come un concept album perché non c’è un vero concetto di base a sostenere il tutto. Come il precedente è, secondo me, un disco “apocalittico”, ma forse perché è stato registrato in tempi apocalittici. Tutti vedevano un futuro piuttosto scuro all’orizzonte ma io non sono mai stato un grande ottimista, quindi non la vivevo così nera. È innegabile però che risente della “pressione” di quel periodo.
Come gestivate il lavoro da remoto? Ci sono pezzi molto complessi come “Exit Space” che non sono certo le classiche canzoni da formato standard, chi aveva l’ultima parola?
Essendo tutti chiusi a casa le canzoni rimbalzavano da più parti: Peter da Portland mandava un pezzo a me, che ero in UK, io lo rimandavo indietro o lo giravo a Scott (McCaughey, ndr) che inseriva il mellotron o il basso o le tastiere, poi lo mandavamo a Linda (Pitmon, ndr) che era a New York e lei inseriva la batteria. Credo che l’unico brano sul quale abbiamo avuto delle discussioni artistiche sia stato proprio “Exit Space”. Nella lunga coda finale Peter avrebbe voluto aggiungere molti più suoni di scimmia, quando in realtà secondo me ce n’erano anche troppi! Alla fine l’ho spuntata io, ma solo perché gli ho promesso che nel prossimo disco potrà inserire tutte le scimmie che vuole.
Quindi ci sarà anche un nuovo lavoro?
Adesso che la pandemia è finita siamo riusciti a vederci di persona, qualche giorno fa è venuto in UK e abbiamo fatto un paio di bevute assieme. Con molta probabilità il prossimo lavoro lo registreremo alla vecchia maniera, tutti e due nello stesso studio.
Un’ultima domanda. 10 anni fa è uscito un film su di te, si chiama “Art Will Save The World – The Life Of Luke Haines”. In rete si trovano i trailer, anche delle Q&A inoccasione delle proiezioni in alcuni festival, ma non si trova in streaming, né da acquistare, né in DVD. Cos’è successo?
Non ho molte informazioni in merito o, meglio, le informazioni che ho sono le stesse di 10 anni fa: il regista e la produzione sono in una posizione di stallo tra loro. A quanto ricordo la produzione non poteva comprare i diritti per tutte le musiche del film, ma fare un film di quel tipo senza le canzoni non ha molto senso. A distanza di dieci anni non so se la discussione sta andando avanti o se semplicemente hanno perso interesse nel progetto. Ma sono sicuro che in futuro, in un modo o nell’altro, arriverà su internet, forse con un classico leak di qualche addetto ai lavori. Basta solo attendere e avere fiducia.