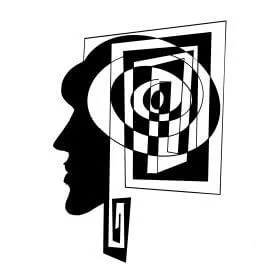Oltre due decadi sono trascorse dagli esordi dei The Kills e un percorso tumultuoso è quello che ha portato alla creazione del loro sesto e probabilmente più ambizioso lavoro intitolato “God Games”.

Alison Mosshart e Jamie Hince si incontrarono per caso agli albori del nuovo millennio e uniti dalla passione per la musica e l’arte strinsero un patto destinato a durare per la vita. Ancor prima di avere un nome come band iniziarono ad esibirsi live come VV e Hotel, riuscendo rapidamente a catalizzare l’attenzione di pubblico e stampa per le loro esplosive performance in un’epoca in cui i duo rock non erano una novità assoluta, sulla scia di band come The White Stripes e Royal Trux, ma la loro formula minimalista che fondeva un’attitudine punk con blues ed elettronica riuscì a farli emergere guadagnandosi un posto di assoluto rispetto nella scena indie rock, soprattuto grazie ad album come “Keep On Your Mean Side” e “No Wow”. Doveroso riconoscere che ben poche di quelle bands sono sopravvissute alla prova del tempo.
Ad un certo punto della carriera quasi inevitabilmente si giunge al bivio tra estinguersi ed evolversi e ascoltando “God Games” si direbbe che il duo anglo-americano abbia optato per la seconda opzione. “New York” e “LA Hex” sono state le prime carte estratte dal mazzo, anticipando nella dualità la cifra stilistica dell’album. Un ritorno alle radici per certi versi, ma segnato da un’ampia apertura alla contaminazione dei generi. La prima più fedele al Kills-style, densa di taglienti riff di chitarra e oscura come una tempesta, la seconda un elettronico sogno distopico in cui emergono trombe e coro gospel, è ispirata ai molteplici suoni provenienti dalle auto che sfrecciano per le strade in quel crocevia di culture che è Los Angeles, dove è possibile ascoltare nello stesso frangente mescolati tra loro ritmi mariachi, hip hop e rock’n’roll, come in una frenetica collisione tra diverse capsule del tempo.
Scrivere i brani da una nuova prospettiva rispetto ai lavori precedenti, partendo in fase compositiva da una tastiera invece che dalla chitarra, ha permesso loro di sperimentare con tonalità ed accordi, aggiungendo le chitarre solo nella fase finale. Per la produzione si sono rivolti a Paul Epworth, amico di vecchia data che fu il loro primo tecnico del suono e che nel frattempo ha collezionato numerosi Grammy Awards lavorando con artisti quali Adele, Florence and The Machine e Paul McCartney. La scelta di registrare insieme a lui negli studi londinesi che sorgono all’interno di un’antica chiesa e che perciò portano il nome The Church deve essere sembrata ironicamente provvidenziale essendo l’album nato dall’idea di scrivere “spirituals senza Dio”.
Tra i brani più innovativi per l’amalgama di suoni spicca “LA Hex”, che inizia con reminiscenze di “At The River” dei Groove Armada fine anni novanta, per poi decollare verso altri territori quando sullo spoken word del duo si inserisce il canto gospel del Compton Kidz Club Choir enfatizzato dal trionfante ingresso della chitarra di Jamie in un’atmosfera quasi visionaria. La città degli angeli è protagonista anche di “103”, che descrive le apocalittiche ondate di calore che affliggono il pianeta, immaginando di ripararsi dalle temperature roventi sotto l’ultima palma rimasta.
Non mancano di sorprendere in passaggi come “Going To Heaven” e “My Girls My Girls” col suo motivo di synth distorto e drum beats sparsi che evocano un ritmo dub o nella vocazione trip-hop della melodia di “Love and Tenderness”, mentre “Blank” spogliata al minimo su pianoforte e drum machine, nel suo tono allo stesso tempo solenne e tragico, va ad allinearsi con altri brani-confessione del loro repertorio come “That Love” o “The Last Goodbye”.
Quando il mondo nel 2020 si è fermato e le città divennero all’improvviso vuote e spettrali ci siamo probabilmente domandati se stesse accadendo realmente o se fossimo parte di qualche simulazione sovrannaturale in cui nessuno poteva più decidere cosa fare della propria vita e forse la chiave di lettura di questo album risiede nel suo stesso titolo, che Jamie ha spiegato essere collegato al mondo dei videogiochi. Nei God games si può creare e manipolare l’ambiente circostante, un po’ come nel mondo creativo si crea un piccolo universo in cui sperimentare, trasferendovi dilemmi e riflessioni.
Il collante di fondo dell’ album resta un’anima rock/blues e sebbene la scelta di puntare sulla mescolanza di suoni molto diversi tra loro e distanti dal minimalismo degli inizi potrebbe far risultare l’insieme a tratti frammentario, non manca di mostrare una vibrante personalità. Jamie Hince pur avendo quasi perso l’uso di un dito delle mano sinistra in seguito ad un incidente resta senza dubbio un chitarrista dalle doti eccezionali e le performance vocali di Alison Mosshart si sono arricchite anche grazie agli anni on the road con i The Dead Weather di cui fa parte insieme a Jack White, raggiungendo profonde e potenti sfumature.
This is not our time, cantano nell’ipnotica “Wasterpiece”, consapevoli che sperimentare può anche significare non essere sempre apprezzati nel proprio tempo e che l’atto creativo esula dalla ricerca del consenso, suggerendo più interrogativi che risposte assolute. La title track nel suo incedere lento e solenne di synth si collega al matador sulla cover del disco e risulta essere un’amara riflessione sulla condizione umana e su come la crudeltà venga falsamente nobilitata dal manto della tradizione.
La conclusiva “Better Days” potrebbe essere una colonna sonora perfetta per accompagnare l’eroe sopravvissuto che si allontana sul finale in un film di Quentin Tarantino.
Solido mix di vecchio e nuovo, arricchito da corposi layers elettronici e suoni gospel inediti per il duo, “God Games” è una brillante conferma dell’alchimia che, da sempre e per sempre, unisce i The Kills nel loro fervore creativo.