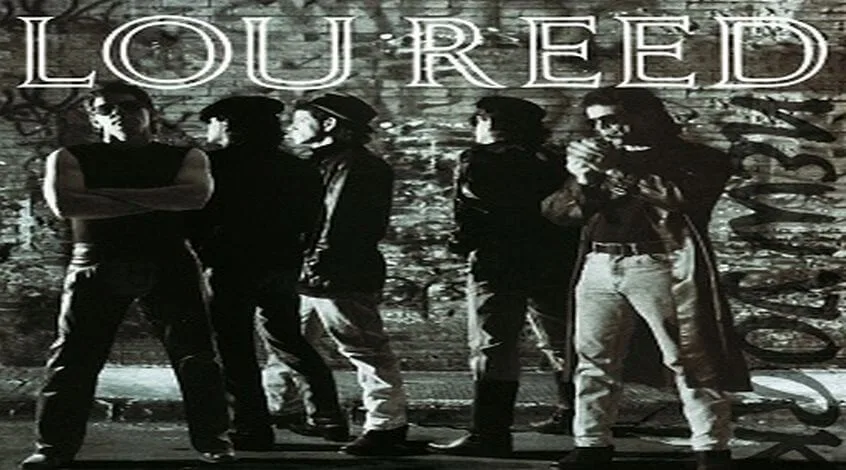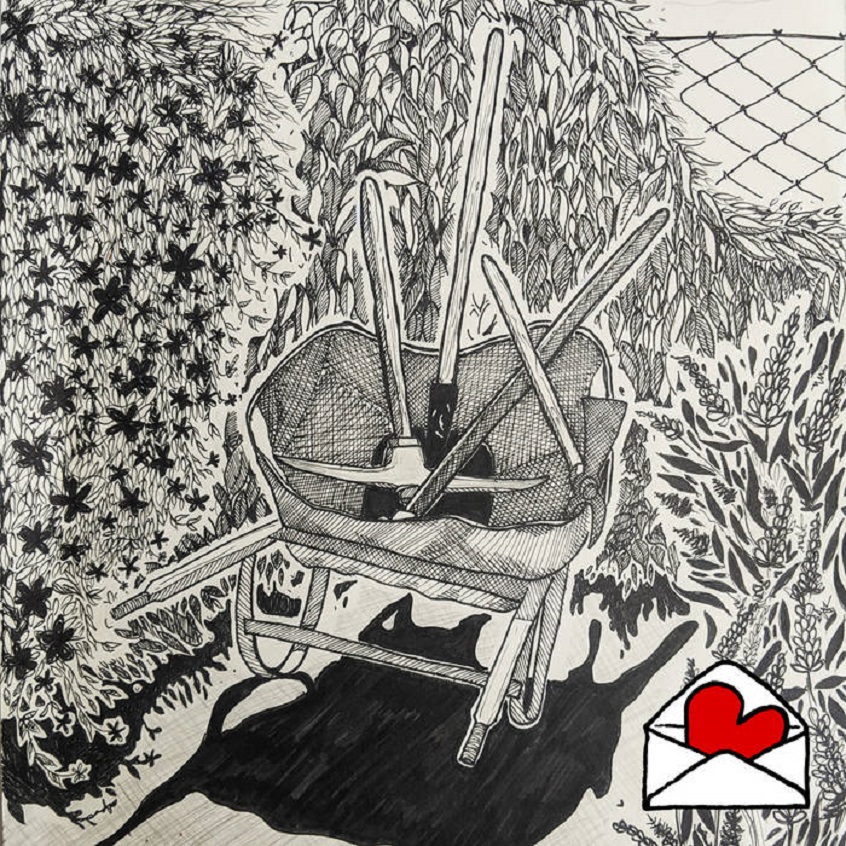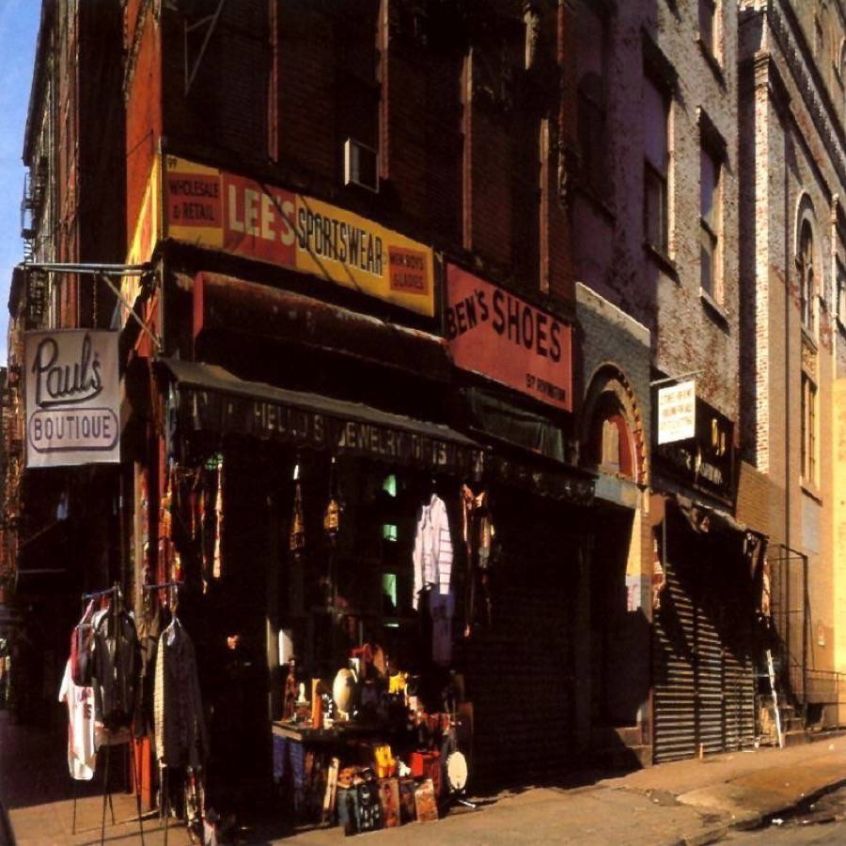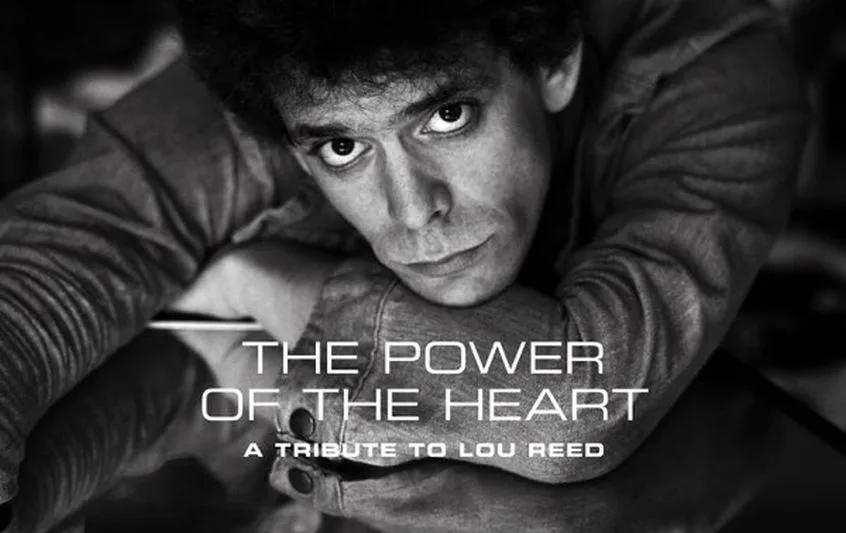
Stiamo aspettando, ma il nostro uomo è ormai lontano, così come lontani appariamo noi stessi – gli uni agli altri – e se non fosse per ciò che sentiamo dentro di noi, indipendentemente dalle nostre evidenti diversità, non avrebbe alcun senso parlarci, trovarci, perderci ed, alla fine, ritrovarci, improvvisamente, su qualche nuovo sentiero, magari in una nuova ed imprevedibile forma, una forma mai vista prima. Pioggia, sole e tutto quello che c’è in mezzo, tutto ciò che definiamo il potere del cuore, ovvero il brano conclusivo che dà il nome a questo tributo; un’opera che, come tutti i tributi, potrebbe apparire ovvia, per certi versi scontata o addirittura inutile. Una mera esca commerciale per racimolare qualche soldo dai fan più affezionati, quelli che non vogliono perdersi nulla.
Ed allora che senso a scriverne? Che senso ha cercare ancora uno spunto, un’interpretazione o una riflessione in qualcosa che, per quanto concerne l’uomo, la sua carne, il suo corpo materiale, è, ormai, finita da un pezzo?
Ha importanza, al di là degli abusi, delle dipendenze e degli eccessi, attuali e passati, per capire la direzione che stiamo prendendo; una direzione che sta rendendo la musica e, più in generale, qualsiasi aspetto delle nostre esistenze, il frutto di un calcolo, di un’analisi dei benefici, di un insieme di istruzioni e di operazioni, che, per quanto corrette, per quanto efficienti, per quanto efficaci, non hanno nulla a che vedere con la passione, con la follia, con il mondo visto attraverso un paio di occhiali scuri o il contatto con la pelle consumata di un giubbotto da motociclista. Un contatto fisico, reale e vissuto che racconta di crolli improvvisi, di rinascite inattese, di dolci melodie pop, di feedback noise-rock, di abbaglianti visioni glam-rock, di quel giorno perfetto, di quel giorno speciale, di quel giorno buono che sembra non arrivare mai. Ma, poi, quando siamo soli, a casa, forse dopo anni, ci rendiamo contro che, invece, ne abbiamo attraversati diversi di giorni così, tutti unici, tutti buoni, tutti speciali, tutti perfetti.
Alcune canzoni lasciano il segno, anche nella nuova veste sonora, altre sono messe lì con evidenti fini commerciali, ma gli Afghan Whigs sono assolutamente veri e naturali nell’interpretare Lou Reed, nello scandagliare quel cuore cupo, malinconico ed arrabbiato, mentre le linee più dolci della loro “I Love You, Suzanne” sfumano nella rilettura country di Mary Gauthier. Un disco che riesce, quindi, a donarci delle emozioni, ad essere qualcosa di più importante di una banale serie di nomi, più o meno famosi, più o meno validi, posizionati lì per dare un motivo per metter mano al proprio portafoglio. Non basterebbe, infatti, nemmeno l’iniziale interpretazione, rauca, consumata e blueseggiante, di Keith Richards, a rendere giustificato l’investimento. Ogni singolo brano, in fondo, riesce ad aggiungere il proprio tocco di originalità, a rendere più vivida un’emozione o a suscitare un pensiero che ci fa sussultare, che ci fa incuriosire e che ci ridesta, finalmente, da una quotidianità che, altrimenti, rischia di far apparire ogni cosa scontata, ovvia, scolorita, vuota, un tristo ritornello per sopravvivere e basta.