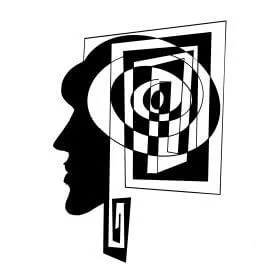Ho preparato tutto la sera prima. Ho riempito lo zaino, ci ho messo dentro un pullover, quello grigio e giallo con le toppe marrone scamosciato sui gomiti, la macchina fotografica, gli occhiali da sole, i guanti e qualche ricambio. L’ultimo spazio l’ho lasciato per i panini e la borraccia. Alle cinque del mattino non hai molta voglia di sistemare le cose. L’indomani mi sono vestito, pesante ma non troppo; ho atteso il lento farsi del caffè; alla finestra ho scorto il primo sciabolare di sole. Ho incorniciato collo e testa con sciarpa e cappello di lana e sono uscito. Ho raggiunto il sentiero che da valle stringe il monte fin su in cima. Scocche rosse e nuvole d’aria gelida, buona, come solo quella del mattino in montagna sa essere. Quest’aria mi lava gli occhi, è dura, scorbutica, dolorosa. Devi sapertela conquistare con tenacia e devozione. Salivo lentamente ma con passo regolare. Il canto degli uccelli dettava il tempo del mio respiro. La brina ghiacciata ricopriva le foglie rendendole addobbi luccicanti di quell’immota roccia maestosa. Più camminavo e più era silenzio attorno. Le montagne sono industrie di silenzio magnifico. Verrebbe voglia di registrare quell’assenza di esseri umani; poi ascoltarla per un tempo indefinito. Dopo quasi quattro ore ero in cima. Se fossi capace direi le cose più profonde su quel momento. Ma non lo sono; però tutto quello che c’è da sapere è dentro questo disco, strumentale, chitarristico, acustico, texano, pianistico, vorace, malinconico, estatico, classico, ardente, passionale, coinvolgente, crudo. Nel frattempo sigillo il mio silenzio tra le note di chi ridimensiona tutto il superfluo. Amen.
Ai lettori e alle loro voglie:
Rob Lowe e Michael Muller sono umani: strana cosa da credere dopo aver ascoltato un album che pare il resoconto sonoro dei tormenti pensierosi di una Natura in ostaggio piuttosto che la profezia del sogno di due uomini. Immaginare che il polveroso e petrolifero Texas possa essere stato la culla delle visioni sonore del duo americano è impresa ardua; invece se ci fate caso tutto torna. Spazi immensi, orizzonti giganteschi bruciati dal sole del tramonto, mostruose pompe petrolifere che ritmicamente scavano regolari il terreno: spirito e materia che giocano a mescolarsi in un unico magma. Tutto è delicato e forte in questo disco, ogni tempo è misurato, l’assenza delle parole non si avverte; chitarre liquide e banjo, pianoforti ed essenziali parti di violini e violoncelli trapuntano un mondo malinconico e quieto, apparentemente calmo, ma rigoglioso e vitale come poche cose. Sembra di perdersi in una foresta un giorno di pioggia, col ticchettio dell’acqua sulle foglie, l’odore di terra umida, tutto lucidato, nuovo, brillante, con mezzo sole pallido a riscaldare l’aria inumidita. Il portento di “Rivers Arms” è nella sua prepotenza nel farsi ascoltare, laddove dischi come questi diventano inerti ‘sottofondi’ da sala di attesa; al contrario in quest’album ci troviamo di fronte ad un ‘classico’ che scorre granitico, essenziale, emozionante. La grazia ha trovato casa tra le note dei Balmorhea. Amen.
Credit Foto: Claire Cottrell