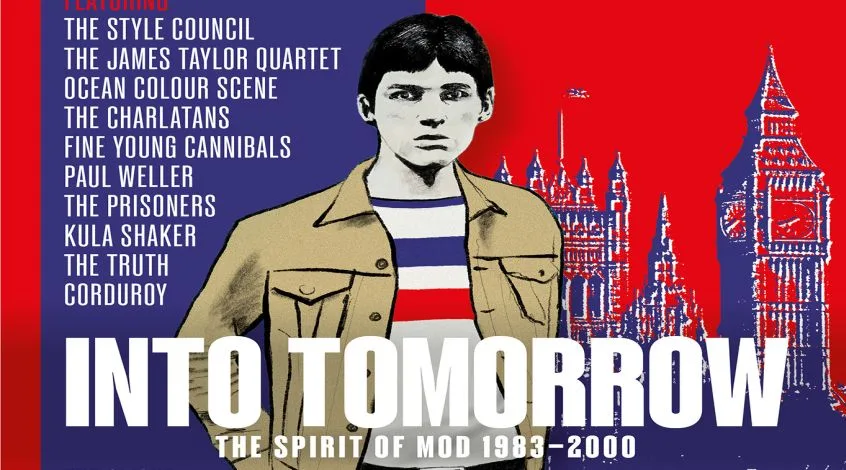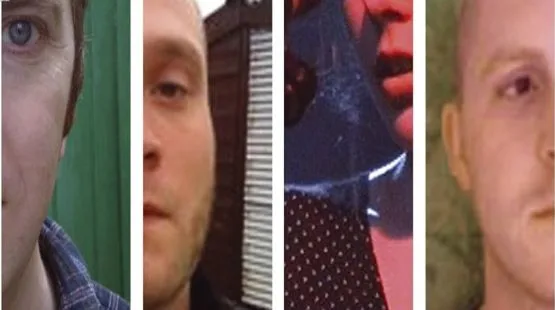Esempio di coerenza sonica e politica, mito del rock e patrigno di tutto il sound UK-garage, producer attento e figura imprescindibile dell’underground britannico, reduce di un futuro passato e pronto per un futuro radioso Mark Stewart, dopo qualche anno di silenzio, torna sulle scene con un nuovo album solista (nonostante le voci indicassero probabile l’uscita di un lavoro firmato Pop Group, dopo il lungo e promettente tour che, tra l’altro, aveva toccato anche il suolo italiano) intitolato programmaticamente “The Politics of Envy”.
Con una carrellata di ospiti importanti Mark decide di dare un seguito all’ottimo “Edit”, album che nel 2008 aveva segnato il suo ritorno. Se l’inizio di questo nuovo “Politics of Envy” è affidato all’ispirata invettiva combat-dub “Vanity Kills”, subito dopo è la volta del duetto molto rock con Bobby Gillespie in “Autonomia”. Non manca una lunga incursione in territori tra dub e dubstep, in compagnia del vecchio leone Lee “Scratch” Perry (“Gangsta War”), ma il disco mostra i primi momenti di stanca nel successivo irrisolto electro-rock di “Codex”. Per fortuna nostra arriva subito una “Want” (in compagnia dei figliastri Factory Floor) che, pur muovendosi sulle stesse coordinate, risolleva ampiamente le sorti dell’album. Ma è sopratutto l’inaspettato pop elettronico e trendy di “Baby Burgeois” ad impreziosire un ascolto altrimenti appesantito dalla brutta deviazione dance di “Gustav Says” (che vale neppure un quarto del ghetto-funk, da cui prende le mosse, “Rise Again” presente nel disco precedente).
Torna la presenza dei Factory Floor nel desolante tappeto industriale di “Method To The Madness”, mentre è la bella voce nera di Daddy G ad accompagnare il caracollante e drogato incedere di “Apocolypse Hotel”.
Chiudono l’album la toccante e scurissima cover di “Letter To Hermione” (mi piacerebbe capire perchè nella mia copia promozionale è intitolata “Don’t Sit Down” mentre altrove la trovate sempre citata col titolo originale) e l’ultimo catastrofico assalto insieme ai giovani Factory Floor.
Meno monolitico e massiccio rispetto a già citato “Edit”, questa nuova fatica è comunque aggressiva (come il bristoliano Mark ci ha sempre abituati) e scomodamente divertente.