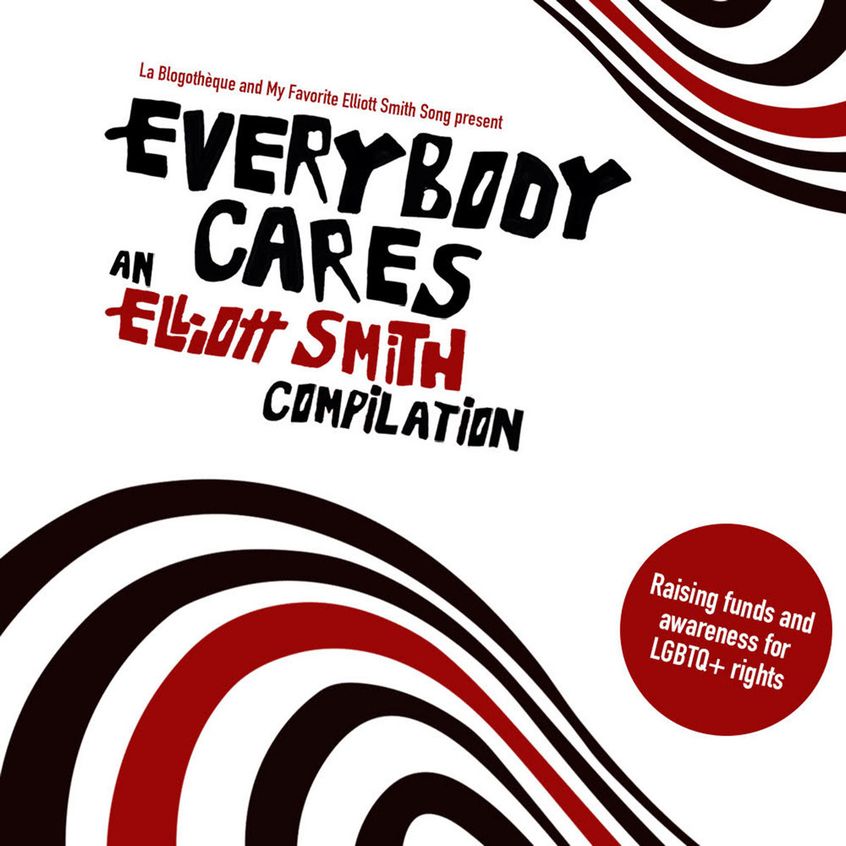C’è un fotogramma alla fine di “Heaven Adores You”, il documentario di Nickolas Rossi su Elliott Smith, in cui si scorge la targhetta commemorativa affissa nel liceo frequentato dal cantautore. Cita uno dei suoi pezzi più belli per celebrarne in maniera definitiva la piccola fama di storia incompiuta, ma non dimenticata: I’m never gonna know you now, but I’m gonna love you anyhow (“Waltz #2).
Allo stesso modo, il biopic di Rossi, amico e regista di alcuni video musicali di Smith, non è un’indagine sulla vicenda umana del cantautore quanto piuttosto un tributo, qualcosa di simile a un atto di affetto e, per certi aspetti, un tentativo di riscatto. Poco dopo l’inizio, si tocca già la questione dolorosa della morte dell’artista: due coltellate auto-inflitte, così se ne andò Smith, era il 21 ottobre 2003 in Echo Park, Los Angeles. I 104 minuti di film, però, non è lì che vogliono arrivare e non offrono ““ nè vogliono offrire ““ una risposta alla domanda morbosa di chi (come me) si chiede che cosa conduca un essere umano a compiere un gesto di simile violenza contro la sua stessa persona fisica. “Heaven Adores You” tratta il percorso di Smith sotto il segno della più delicata, quando non ostinata, reticenza.
Il giovane Steven Paul Smith (nome di battesimo) si trasferisce da Dallas, dove viveva con madre e patrigno, a Portland, quand’è ancora un ragazzino. La cause sono i cattivi rapporti con il marito della madre, ci spiegano di sfuggita. Portland diventa casa e lì Smith matura musicalmente, passando per alcune formazioni grunge – non ce l’aspettavamo ma Elliott Smith può essere loud, sì – fino alla sistemazione un po’ più duratura con gli Heatmiser: la band pubblica nel proprio piccolo tre album e l’ultimo, “Mic City Sons” (1996), già si incrocia con la carriera solista di Smith. Infatti, fra il 1994 e il 1995 cominciano a circolare il primo EP “Roman Candle” e il successivo full lenght self-titled “Elliott Smith”. Elliott diventa un nome in Oregon, una piccola star nella sua Portland, mentre è ancora sconosciuto nel resto del paese. Poi la svolta, il salto, il 1998 e la candidatura all’Oscar come Miglior colonna sonora per “Miss Misery” nel film “Will Hunting – Genio ribelle”. Lui stesso commenterà quanto fosse bizzarro vedere quel tizio con il completo bianco e i capelli un po’ unti fermo sul palco degli Academy Award con in mano una chitarra, solo la gamba che si muove esitante. Vinse Cèline Dion con “My Heart Will Go On”, lì c’era poco da fare.
“Sono il tipo di persona sbagliata” si ferma un attimo, intervistato: Sono il tipo di persona sbagliata per essere grande e famoso. In un’altra conversazione radiofonica dichiara: I like music, that’s the thing, it’ very uncomplicated. Però qualcosa di complicato c’è e gli intervistati in “Heaven Adores You” non ne parlano. Le cose si stavano mettendo male per Elliott, viene detto, e nessuno entra nel merito. Nessuno dice “abusi”, “malatrattamenti” quando si parla della fuga dal Texas e dei problemi con il patrigno Charlie Welch ““ il trauma infantile di cui aveva ricordi vaghi e incerti che lo perseguitarono per una vita intera, fino alle ultime settimane prima del suicidio. Nessuno dice “eroina”, “crack”, “antidepressivi” e lo sprofondamento nella dipendenza che lo vide al suo peggio fra il 2001 e il 2002 viene solo lasciato intendere negli impliciti del discorso, nei momenti di pausa che puntinano queste interviste nostalgiche quanto, a momenti, imbarazzate di omissioni ingombranti.
“Heaven Adores You” è sulla musica e certamente è così che dev’essere. Offre un repertorio di inestimabile valore fra vecchie registrazioni audio e VHS che ci consegnano l’immagine di un uomo di talento, non quella di un ragazzino cresciuto fragile e spezzato. A volte tuttavia si ha l’impressione che, nel fare questo, il biopic nasconda la polvere sotto il tappeto. La visione di “Heaven Adores You” urge una domanda che riguarda non solo Elliott Smith, ma tutto quel materiale biografico e personale sui musicisti che sentiamo a noi tanto intimi da farci pretendere rivelazioni e spiegazioni non dovute. Insomma pone la questione, non nuova, non semplice, su quanto (e se) sia importante accedere alla vita dell’artista per comprenderne la produzione, apprezzarne le sfumature; e quanto sia invece una tentazione a fare facile macelleria dei sentimenti e delle vite altrui.
Nickolas Rossi sceglie da che parte stare, sceglie di dare senso alla frase in quella targhetta commemorativa: no, forse non conosceremo mai Elliott Smith, ma lo ameremo comunque.