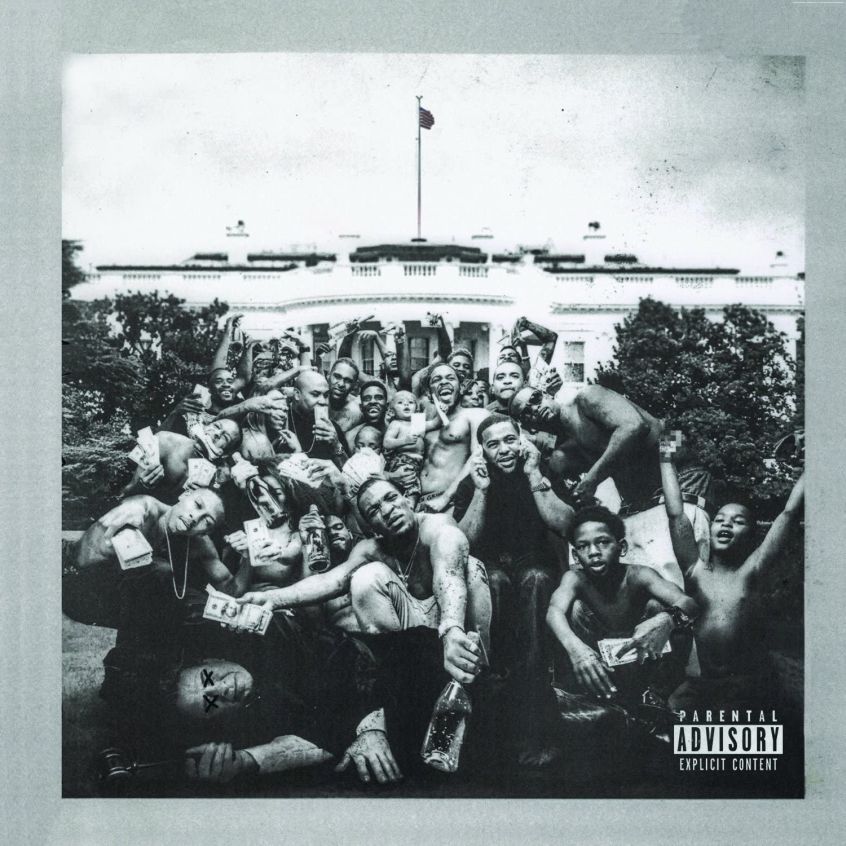Sono tra quelli che, per un motivo o per un altro, non sono mai riusciti ad apprezzare del tutto “Scorpion” (ultimo album in studio del rapper made in Canada prima di questi ultimi giorni) pur apprezzando Drake come artista ed il rapporto che ho con lui e la sua musica lo considero come piuttosto particolare: lo seguo da quando, in coppia con la Minaj, non era nient’altro che una bella scoperta sotto l’ala protettiva e produttiva di un Lil Wayne che già all’epoca (il 2013 circa), per influenza, rime e numero di classici consegnati al genere, cominciava a puzzare di “Goat” (per i profani, pochi ormai, “Greatest Of All Time”). La bella scoperta di mr. Carter era, ovviamente, anche la mia piccola “scoperta” personale, quella capace di dar voce ad una parte fin troppo sensibile di me che, per qualche minuto, avrebbe volentieri fatto a meno delle leggi necessarie per (soprav)vivere in un mondo sempre più simile ad una giungla.
Perchè se Drizzy (come io e moltissimi suoi fan continuiamo affettuosamente a chiamarlo) poteva veramente permettersi di insegnarci qualcosa a quei tempi, quel “qualcosa” sarebbe stato esattamente questo: essere se stessi, sempre e comunque, anche in un ambiente che di primo acchito avrebbe potuto rifiutarci, che ciò ci piacesse o meno. Parlare apertamente dei propri sentimenti, delle proprie insicurezze, ammettendo, quindi, il concetto stesso di debolezza, sotto gli occhi di un universo profondamente machista come quello hip hop, era un rischio che pochissimi eletti avrebbero potuto permettersi, figurarsi trasformare tutto questo in autentiche hits urban prima e pop dopo.
Ma da dove ero partito? Giusto, “Scorpion”, progetto che viene ricordato principalmente per la presenza al suo interno di colpacci come “God’s Plan”, “In My Feelings”, “Nice For What” e, d’altronde, come potrebbe non essere altrimenti? Provate un po’ ad immaginarvelo senza. Qualche anno dopo sarebbe arrivato il momento del migliore “Dark Lane Demo Tapes” (mixtape contenente quell’altro colpaccio di “Toosie Slide”) ed ultimamente il 6god aveva accontentato la sua fanbase e non solo con l’uscita del soddisfacente “Scary Hours 2”, un EP di appena 12 minuti, aumentando, di fatto, le aspettative per quello che sarebbe stato “CLB”.
E allora arriviamo al sodo: cos’è stato effettivamente “CLB”?
La risposta è semplice: un classico disco alla Drake, un buon disco e nulla più (come se poi fosse una nota di demerito), quasi ineccepibile addirittura, dove, però, manca l’elemento fondamentale che, nel bene o nel male, ha caratterizzato l’ascesa planetaria del rapper di Toronto dal 2016 ad oggi: la classica ed inconfondibile hit spacca-classifiche à la Drake. Dov’è, infatti, quel brano che, alla fine dei conti, finisce per oscurare, purtroppo o per fortuna, l’intero album? Il grande assente si conferma e si riconferma tale più e più volte tra qualche pezzo d’amore dei più classici, un dissing ai suoi cari colleghi (con un occhio di riguardo nei confronti del buon vecchio Kanye), una “Fountains” che non può che riportarci alla memoria i fasti dell’altrettanto esotica “Passionfruit” di “More Life” e qualche collaborazione ormai più che collaudata, “Girls Want Girls” tra tutte, per gentile concessione di un Lil Baby che sembra essere perennemente in forma. Neanche vere e proprie perle come “Race My Mind”, “Love All”, “Papi’s Home” e “Fucking Fans” riescono a risolvere il problema, lasciandoci tra le mani un buon prodotto che non sapremo, però, come invecchierà .
Nessuno stravolgimento, quindi, solo un disco che, in gran parte, già conosciamo, un Drake che già conosciamo, insomma: same old Drake e (forse) va bene così.