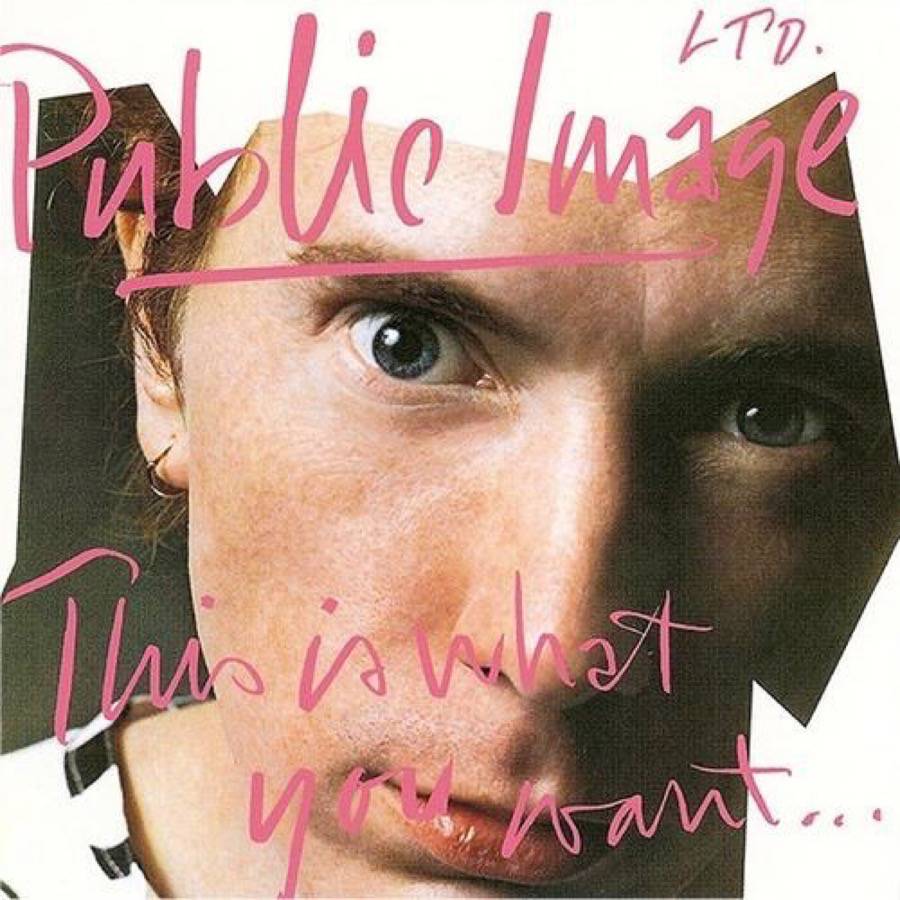Non si può certo dire che ultimamente soffra di noia la vita di per sè già tortuosa di Lydon alle prese con la dolorosa morte della moglie e con le beghe legali degli ex Pistols in merito ai diritti della serie TV omonima.

Tutto questo sicuramente si riflette su “End of the world”, inatteso guizzo del nostro che sforna assieme ai fidatissimi ed ottimi musicisti il miglior album dei P.I.L. da parecchio tempo, con elementi di freschezza, una decisa varietà dei generi affrontati, in generale un’idea di band ancora alle prese con qualcosa da dire, sia musicalmente che nei testi, sempre non banali e consolatori, sempre nello stile Lydon di protesta, derisione e sentenzialismo anarchico: l’insieme di una forma di resistenza ad un mondo non più in grado di reggere, l’inettitudine dei benpensanti della conoscenza, mentre per salvare la terra forse bisognerebbe essere un pò stupidi e diciamo noi, stupiti (“Being stupid again”).
Ma oltre a questo, troviamo anche e sorprendentemente il Lydon romantico ed intimo, alle prese con l’essenza della sua esistenza (“Strange”), soprattutto nel commovente addio in musica alla defunta consorte di “Hawaii”, una tenera ballata caraibica che accompagna un’amore che prende i colori e le armonie di questo inaspettato omaggio musicale.
L’album però dal punto di vista sonoro è tutt’altro che riappacificante come il citato singolo, anzi; la band riprende, nelle migliori canzoni, il piglio rock anni 80 di prove come “Album” e “Happy?” (“Penge”, “End of the World”) con bellissime chitarre aperte e batteria schiacciata, fa il verso agli Sleaford Mods sancendo un diretto filo quasi di progenia verso i nuovi punkers sociali (“Being Stupid Again “), proponendoci inoltre brani che sarebbero piaciuti al periodo Wobble/Levene con quel giro di basso groovy di cui una come Grace Jones diventerebbe pazza (“L F C F”).
In tutto questo l’interpretazione vocale del leader rimane assolutamente di prim’ordine, certo forse un tantino forzata nel raggiungimento di alcune vette, ma col tempo più duttile al servizio delle diverse incastonature che la band gli propone, ad esempio il semi jazz di “Dirty Murky Delight”
Un album che non demorde mai, che forse eccede nel numero e nei diversi generi trattati, ma che ci riporta vivo un suono e un’attitudine scomoda e presente, certo non nell’intensità di fine anni 70/inizio 80, ma ancora viva e con cui doversi confrontare, un’esempio di umanità ancora non rassegnata all’idea di qualsiasi omologazione: si direbbe molto rock!