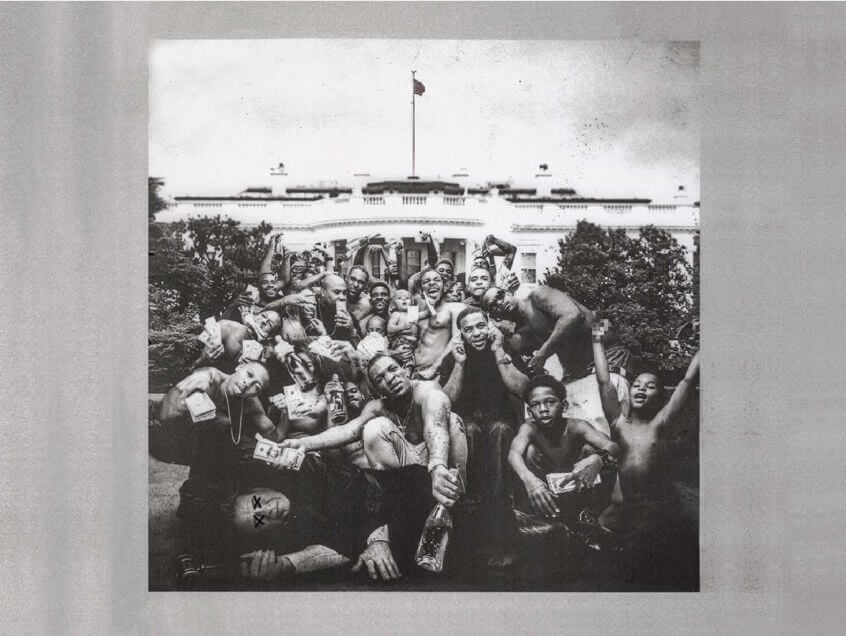L’enfant prodige statunitense, incredibilmente sexy, Joanna Newsom si è data da fare e ha buttato giù una mole non indifferente di lavoro.
Già conosciuta per l’ottimo “Ys”, torna con “Have One On Me”. Dal puro sbilanciamento delle strutture musicale delle partiture classiche tipico dei lavori precedenti, qui si viene a creare ad hoc una efficace storpiatura battute assestate e infiocchettate però su criteri stilistici più vicini al pezzo con apertura e chiusura definite. L’open-track “Soft As Chalk” ricorda terribilmente i Dresden Dolls, con una psycho cabaret sobrio e d’effetto. Forse è improprio parlare di open track, poichè il disco è diviso in 3mini Ep (mini si fa per dire, data la durata dei pezzi, che è il doppio di quella a cui siamo abituati da questo target musicale).
L’opera ha tutte le carte per essere un percorso piacevole in un paradiso multiforme di note tremolanti e non scontate. “Easy” è un arrangiamento vicino al gusto Tori Amos, ma la voce di Joanna è riconoscibile e sottolinea il giusto distacco. Man mano che si procede nel sentiero della Newsom, il maggior espediente per far posare la sua delicata voce sui pezzi è l’intenso uso dell’arpa, suonato quasi come un acustica in un disco di Van Morrison.
Il folk è marcato come mai. Il format della voce è il gemello siamese di Fiona Apple.
E’ fuori luogo indicare su quali tracce è più simile a Joni Mitchell o Kate Bush.
La cosa utile è parlare delle tracce in cui è simile ad una cantautrice formata, ovvero: “Esme”. Mi ha lasciato senza fiato per il gusto estremo del ritardo nel vibrare nelle sue stesse intenzioni, nella privazione che sottende al piacere, nella distensione naturale delle corde vocali su quelle dell’arpa, su quelle del cuore della ragazza di cui stiamo parlando. Una contorsione musicale che deriva dai veri movimenti dell’anima, e non da un tecnicismo scimmiottante la buona tradizione che la precede su questo viale di terriccio.
Il blues fa capolino ogni tanto, ma nel mood, mai nella cadenza.
“’81” è bellissima, lucida, degna di un climax in un serial americano, pregna di celtic coniugato a ritmo da powerballad introspettiva.
Discendendo di traccia in traccia, la voce si fa sempre meno timida, ma la seconda parte del disco è pressochè identica alla prima. Il livello non si abbassa, ma non si alza nemmeno.
“Good Intensions Company” è urn rise piacevole, ma si dilunga un po’ troppo.
La terza parte del disco è sensibilmente più amarostica delle precedenti.
I toni si alzano con brevi innesti di musica popolare nordica, ma si spengono subito al tramonto delle sillabe della Newsom. “Occident” commuove. “Does not Suffice” spaventa come un temporale.
L’opera è bella ma può stancare. Ben allacciata alla tradizione riesce comunque a non essere pedissequa. Ma se non ascoltata nello stato d’animo giusto, risulta non solo poco apprezzabile, ma del tutto accantonabile da un ascoltatore non disposto a venirle incontro.
Credit Foto: daniel arnold / CC BY-SA