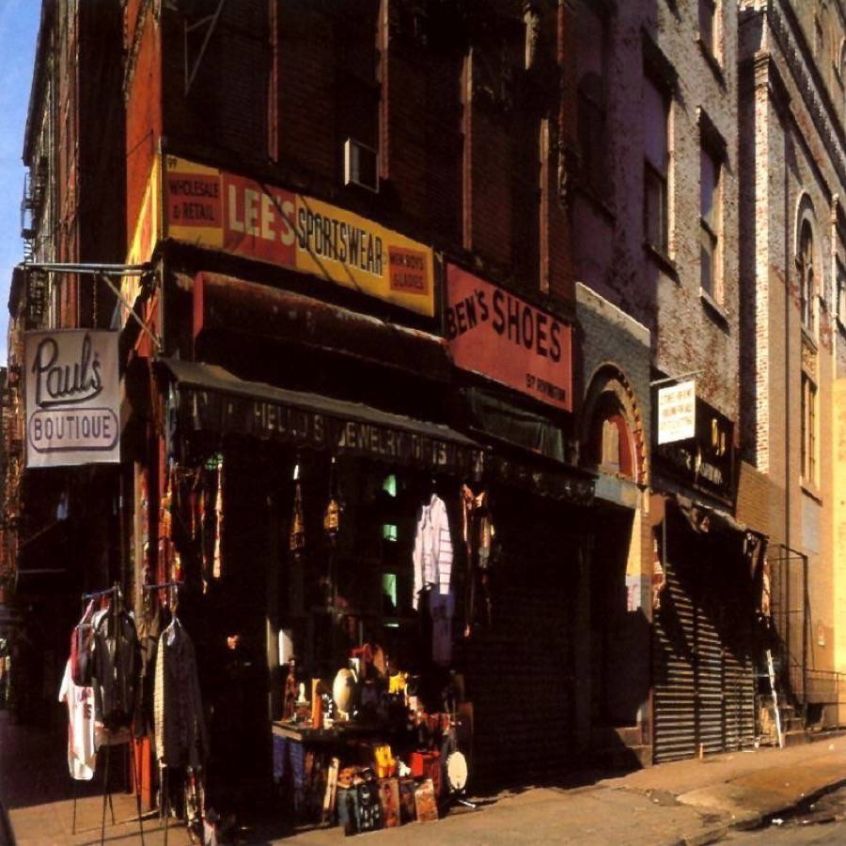La notizia della morte di Mimi Parker mi ha particolarmente toccato, e non in quanto amante dei Low, ma per quello che rappresentavano, lei e Alan Sparhawk – rispettivamente batterista e chitarrista, moglie e marito, madre e padre di due figli – all’interno di un mondo avido e crudele come quello dello spettacolo. Mimi e Alan erano una coppia normale, potevamo essere noi, due vicini di casa, quelli che incontri la domenica mattina mentre vanno a messa (mai hanno nascosto la loro forte fede spirituale). Niente di più lontano dallo star system che associamo al loro ambiente. Si conobbero da bambini in un paesino del mid-west, si sposarono giovani e partirono per Duluth, la città di Bob Dylan. Qui formarono una band e iniziarono a suonare una musica compassata, in forte controtendenza con le istanze grunge del periodo, venendo raramente capiti e spesso osteggiati. Molti anni e una vita al fianco di Alan dopo, Mimi è stata portata via da un male incurabile. Aveva appena 55 anni.
I Low, nel frattempo, erano diventati una delle band di riferimento nel panorama rock del terzo millennio, come dimostrano i tanti commiati espressi per l’occasione anche da testate prestigiose e che poco c’entrano con la musica, dal Guardian al New York Times (in Italia se li filò persino Vanity Fair). Sarebbe stato difficile preconizzare quel clamore anche solo una decade fa. In una lunga carriera ingemmata da tredici pregevoli album di studio, infatti, solo gli ultimi hanno riscontrato un minimo tepore commerciale, sfiorando a malapena la top 20 delle classifiche di vendita. Ma la robustezza dei fusti cresciuti durante una semina durata trent’anni ha garantito lo sviluppo di una fitta vegetazione, alla cui ombra sono cresciute molteplici generazioni di ascoltatori e musicisti, che hanno infine riconosciuto i giusti onori ai loro maestri.
Per chi li ha conosciuti al termine del percorso, specie con le allucinazioni elettroniche degli acclamati “Double Negative” (2018) e “Hey What” (2021), tornare a ritroso per studiarne l’ontogenesi potrebbe rivelarsi uno shock. Si scoprirebbe, ad esempio, che il sound delle origini era interamente basato su strumentazioni tradizionali, con scarso o nullo utilizzo di campionamenti e diavolerie di studio, un morigerato uso dei distorsori e le manopole degli amplificatori girate sempre verso il… ‘low’.
Tutto iniziò il 18 febbraio del 1994, quando “I Could Live in Hope” venne dato alle stampe. Ho ascoltato tutta la discografia dei Low, che considero con buona certezza una delle mie band preferite, ma ritengo che la magia di quell’esordio non sia più stata neanche lontanamente eguagliata. Quel suono spoglio, guidato esclusivamente dall’acustica di basso e batteria, accarezzati con enfasi minimale, è una delle grandi invenzioni in quel mondo (non solo musicale) in rapido cambiamento che erano gli anni ’90. Invero, la lentezza musicale di “I Could Live in Hope” è contemplazione pura, senza alcun orpello, nessun trucco in fase di registrazione, neppure un pianoforte, una mera esaltazione dei silenzi. L’unico ornamento è la chitarra psichedelica di Sparhawk, ora soave ora nevrotica, che funge da seconda voce e cala ogni brano in un preciso stato d’animo.
“Words”, che apre album e carriera, forse la loro canzone più nota e finanche orecchiabile, è il paradigma imprescindibile per chi voglia approcciarsi a questo genere di musica. Gli intrecci vocali si librano in una preghiera dolente, trascinati a largo dalla svogliata sezione ritmica: l’attesa diventa un fine, l’indolenza una virtù. Se dovessero mai chiedermi cosa s’intende con “slowcore”, il sonnambulismo dimesso di questo brano sarebbe la risposta più banale e centrata.
L’effetto di narcosi provocato dalla sfilata di livide ballate che segue, sporadicamente movimentate da brevi sezioni lisergiche (la salmodia di “Lazy”, i sussurri ruminati di “Cut”), è un’esperienza stupefacente. Mimi Parker appare al canto dapprima in “Slide”, un toccante lounge autunnale, per poi illuminare il pezzo centrale, l’incommensurabile esercizio d’ipnosi di “Lullaby”. Tre note e un reiterato giro di basso “cullano” la ninna-nanna del titolo, mentre la voce si inabissa nei riverberi e lascia il testimone alla chitarra, che completa l’opera d’intorpidimento. A metà brano le onde si increspano impetuose in un riff che si ripete ancora ed ancora ed ancora, ed infine, al culmine della fase onirica, si insinua l’avvolgente litania di qualcosa che somiglia al grido d’amore di un fantasma, estatico e trascendente. Poi di colpo il sogno si spezza e tutto torna garbatamente al delicato pattern iniziale, dissolvendosi come un’illusione.
Un altro capolavoro è “Down” e il suo incedere malinconico che sovente scivola e si sporge su un precipizio emotivo, venendo stravolto da una scossa tellurica che fa increspare il sismografo. Ma ogni volta è la quiete a riprendere il sopravvento e riportare l’umore nell’ordine delle cose. È musica quasi psicoanalitica, in cui anche gli istinti bestiali vengono sempre rivolti verso l’interno, introiettando il male e sublimandolo in rappresentazioni meditabonde e para-religiose. Proprio in coda all’album, le successive “Drag” e “Rope” ne sono degni complementi e costituiscono un trittico da lasciare senza fiato.
Chiude però la pastorale “Sunshine”, uno standard del country americano, la cui rivisitazione disinnesca ogni residuo d’ansia, congedando l’ascoltatore con toni tradizionali e rassicuranti. Si sentono chiari echi di Joy Division (il giro di basso di “Drag” è identico a quello di “New Dawn Fades”) e Galaxie 500 (il produttore, Mark Kramer, è lo stesso), ed un ruolo guida fondamentale lo hanno giocato i contemporanei Codeine, ma quello che i Low sono riusciti a creare va al di là della somma delle parti, codificando uno degli stili più fecondi della musica alternativa di fine secolo.
Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo, in occasione del tour promozionale di “Ones and Sixes” del 2015. Suonarono in un teatro ed eravamo tutti educatamente a sedere. Non sbagliarono una nota. In particolare, mi colpì lei: è raro che sia il batterista a cantare, ma in quel momento non ci feci caso perché sul palco, i Low, sembravano un unico organismo. L’afflato mistico che emanava dalle loro composizioni andava ben al di là di ciò che possiamo aspettarci da un gruppo rock.
Grazie Alan, grazie Mimi.
Che tutto l’amore inciso nei solchi della vostra musica possa sopravvivervi, per sempre.
Data di pubblicazione: 18 febbraio 1994
Genere: Slowcore
Registrato: Hope Township (New Jersey)
Lunghezza: 57 minuti
Etichetta: Vernon Yard
Produttori: Mark Kramer
Tracklist
1. Words
2. Fear
3. Cut
4. Slide
5. Lazy
6. Lullaby
7. Sea
8. Down
9. Drag
10. Rope
11. Sunshine